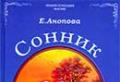Misurazione e controllo del dolore. Scala del dolore analogico visivo (VAS)
L'Associazione Internazionale per lo Studio del Dolore definisce il dolore come un'esperienza sensoriale ed emotiva spiacevole associata a un danno tissutale esistente o potenziale. Il dolore è sempre soggettivo. Ogni persona lo percepisce attraverso le esperienze legate alla ricezione di eventuali danni nei primi anni della sua vita.
Il dolore è una sensazione pesante, è sempre spiacevole e quindi un'esperienza emotiva.
La percezione del dolore dipende dall'umore del paziente e dal significato del dolore per lui. Il grado di sensazione del dolore è il risultato di diverse soglie del dolore. Con una soglia del dolore bassa, una persona avverte anche un dolore relativamente debole, mentre altre persone, avendo una soglia del dolore alta, percepiscono solo forti sensazioni di dolore.
La soglia del dolore è ridotta da disagio, insonnia, stanchezza, ansia, paura, rabbia, tristezza, depressione, noia, isolamento psicologico, abbandono sociale La soglia del dolore è aumentata dal sonno, sollievo di altri sintomi, empatia, comprensione, creatività, rilassamento, riduzione dell'ansia , antidolorifici.
La sindrome del dolore cronico accompagna quasi tutte le forme comuni di neoplasie maligne e differisce significativamente dal dolore acuto nella varietà delle manifestazioni dovute alla costanza e alla forza della sensazione di dolore. Il dolore acuto ha una durata diversa, ma non supera i 6 mesi. Si ferma dopo la guarigione e ha un finale prevedibile. Il dolore cronico dura più a lungo
(più di 6 mesi). Le manifestazioni della sindrome del dolore cronico possono essere ridotte a segni come disturbi del sonno, mancanza di appetito, mancanza di gioia nella vita, chiusura nella malattia, cambiamento di personalità, affaticamento. Le manifestazioni della sindrome del dolore acuto sono l'attività del paziente, la sudorazione, la mancanza di respiro, la tachicardia.
Tipi di dolore nel cancro e cause della loro insorgenza. Ci sono due tipi di dolore.
1. Il dolore nocicettivo è causato dall'irritazione delle terminazioni nervose.
Ci sono due sottotipi:
somatico: si verifica con danni alle ossa e alle articolazioni, spasmo dei muscoli scheletrici, danni ai tendini e ai legamenti, germinazione della pelle, tessuto sottocutaneo;
viscerale - in caso di danno ai tessuti degli organi interni, allungamento eccessivo di organi cavi e capsule di organi parenchimali, danno alle membrane sierose, idrotorace, ascite,
costipazione, ostruzione intestinale, spremitura dei vasi sanguigni e linfatici.
2. Il dolore neuropatico è causato da una disfunzione delle terminazioni nervose.
Si verifica quando danno, sovreccitazione delle strutture nervose periferiche (tronchi e plessi nervosi), danno al sistema nervoso centrale (cervello e midollo spinale).
Valutazione del dolore. Quando si valuta il dolore, determinare:
la sua localizzazione;
intensità e durata (dolore debole, moderato o grave, insopportabile, prolungato);
carattere (ottuso, lancinante, angustoso, dolorante, tormentoso, stancante);
fattori che contribuiscono alla sua comparsa e intensificazione (che riduce il dolore, che lo provoca);
la sua presenza nell'anamnesi (come il paziente ha sofferto un tale dolore prima).
Intensità del dolore
valutato in due modi.
1. Metodo soggettivo: una scala di valutazioni verbali. L'intensità del dolore è valutata dal paziente, in base alla sensazione:
0 punti - nessun dolore;
1 punto - dolore lieve;
2 punti: dolore moderato (medio);
3 punti: forte dolore;
4 punti - dolore insopportabile.
2. Scala analogica visiva - una linea, all'estremità sinistra della quale non c'è dolore (0%), all'estremità destra - dolore insopportabile (100%). Il paziente annota sulla bilancia l'intensità dei sintomi che avverte prima e durante la terapia:
0% - nessun dolore;
0 - 30% - dolore lieve (corrisponde a 1 punto della scala di valutazione verbale);
30 - 60% - moderato (2 punti della scala di valutazione verbale);
60 - 9 0% - dolore intenso (3 punti della scala di valutazione verbale);
90-100% - dolore insopportabile (4 punti della scala di valutazione verbale).
Usano anche righelli speciali con una scala che valuta la forza del dolore in punti. Il paziente segna sul righello un punto corrispondente alla sua sensazione di dolore. Per valutare l'intensità del dolore, è possibile utilizzare un righello con l'immagine di volti che esprimono emozioni diverse. L'uso di tali righelli fornisce informazioni più obiettive sul livello di dolore rispetto alle frasi: "Non sopporto più il dolore, fa terribilmente male".
Terapia farmacologica per alleviare il dolore. svolge un ruolo importante nella terapia farmacologica per alleviare il dolore. È molto importante che capisca come funziona questo o quell'antidolorifico. In questo caso, l'infermiere, insieme al paziente, può condurre una valutazione continua dell'adeguatezza del trattamento del dolore. Per condurre una valutazione finale dell'efficacia della terapia analgesica, sono necessari criteri oggettivi. Righelli e scale per determinare l'intensità del dolore possono servire come uno dei criteri per valutare il dolore.
Per il cancro viene utilizzata la tradizionale scala a tre gradini della farmacoterapia.
Analgesici non narcotici (aspirina, paracetamolo, analgin, baralgin, diclofenac, ibuprofene), oppiacei deboli (analgesici non narcotici) (codeina, dionina, tramal), oppiacei forti (morfina cloridrato, omnopon) sono usati per eliminare il dolore.
C'è un certo rischio di sviluppare una tossicodipendenza in un paziente. Tuttavia, secondo i dati dell'OMS, i pazienti hanno spesso bisogno di alleviare il dolore con analgesici narcotici.
la fase terminale della malattia (pre-agonia, agonia, morte clinica), per cui il rischio di sviluppare dipendenza è incomparabile per importanza con il sollievo apportato al paziente.
Oltre alla terapia farmacologica somministrata da un infermiere su prescrizione medica, esistono interventi infermieristici indipendenti volti ad alleviare o ridurre il dolore:
1) distrazione;
2) cambiamenti nella posizione del corpo;
3) applicazione di freddo o caldo;
4) insegnare al paziente varie tecniche di rilassamento;
5) musicoterapia e arte;
6) sfregamento o accarezzamento leggero dell'area dolorante;
7) attività distraente (terapia occupazionale).
Un trattamento così complesso del dolore cronico viene utilizzato negli hospice, dove al paziente viene insegnato come convivere con il dolore e non solo come "curarlo". Le persone che sono destinate a vivere nel dolore cronico hanno bisogno esattamente di questo.
Scopo funzionale: diagnostico
Condizioni di attuazione: ambulatoriale, degenza, trasporto in ambulanza
ATTREZZATURA: disinfettante per le mani o sapone, varie scale di valutazione del dolore. McGill Pain Severity Questionnaire, Glasgow Coma Scale.
Algoritmo di valutazione dell'intensità del dolore
I. Preparazione alla procedura
1. Assicurarsi che il paziente sia cosciente.
1.1. Quando si diagnostica una coscienza diversa da quella chiara, utilizzare la Glasgow Coma Scale per determinare il livello di depressione della coscienza.
2. Convinto della possibilità di un contatto verbale con il paziente, tenendo conto della gravità della condizione, dell'età, del livello di coscienza, del disturbo del linguaggio, della presenza o dell'assenza di una barriera linguistica.
2.1. Se il contatto verbale con il paziente è impossibile, diagnosticare e documentare i segni verbali della sindrome del dolore (marcatori del dolore).
II. Esecuzione della procedura.
3. Se c'è una chiara coscienza e possibilità di contatto verbale, valutare il grado di dolore a livello diagnostico.
3.1. Chiedere al paziente del dolore.
3.2. Quando il paziente conferma la presenza della sindrome del dolore:
3.2.1. Invitare il paziente a valutare l'intensità del dolore su una scala a 5 punti.
3.2.2. Scopri la posizione del dolore.
3.2.3. Scopri l'irradiazione del dolore.
3.2.4. Scopri la durata del dolore.
3.2.5. Scopri la natura del dolore.
3.2.6. Documenta i risultati. Le zone di dolore sono descritte in termini di anatomia topografica o contrassegnate su una rappresentazione schematica del corpo umano.
3.3. Se il paziente nega la presenza della sindrome dolorosa, documentare nella cartella clinica il fatto dell'assenza di dolore al momento dell'esame.
4. Quando si esegue un riesame del livello di dolore (monitoraggio dinamico del livello di dolore), valutare il livello di dolore a livello di valutazione dinamica
4.1. Invitare il paziente a annotare il livello attuale di dolore su una scala di 10 punti di controllo visivo analogico.
4.2. Chiedere al paziente di annotare sulla stessa scala il livello di dolore al momento dell'esame precedente.
4.3. Valutare la dinamica positiva/negativa della valutazione soggettiva della sindrome del dolore in termini assoluti e/o relativi.
4.4. Documenta i risultati.
5. Quando si esegue una valutazione primaria del livello di dolore, nonché quando si cambia la natura della sindrome del dolore, valutare il livello di dolore a livello descrittivo.
5.1. Istruire il paziente su come completare il questionario McGill per determinare la gravità del dolore.
5.2. Fornire al paziente un questionario e una penna stilografica.
5.3. Al termine del riempimento, calcolare gli indici di graduatoria per 4 gruppi principali (sensazioni sensoriali, sensazioni emotive, valutazione dell'intensità, parametri che riflettono le caratteristiche generali del dolore); sulla base degli indicatori ottenuti, calcolare l'indice di rango del dolore (RIB).
5.4. Compila i campi calcolati del modulo del questionario.
5.5. Sulla base dei dati ottenuti nel paragrafo 3.2.1., compilare il campo "vera sensazione di intensità del dolore" (NIB).
III Fine della procedura
6. Familiarizzare il paziente con i risultati.
7. Lavati (usando un antisettico o sapone) e asciugati le mani.
8. Fare una registrazione adeguata dei risultati dell'attuazione nella documentazione medica.
9. Se il paziente rifiuta di condurre una valutazione, così come se vi sono sospetti sulla veridicità dei dati forniti (simulazione, aggravamento, dissimulazione), diagnosticare e documentare segni di dolore non verbali (marcatori del dolore).
Ulteriori informazioni sulle caratteristiche dell'implementazione della tecnica.
Quando si valuta il livello di dolore sulla scala McGill, è necessario chiedere al paziente di contrassegnare una parola che riflette in modo più accurato la sua sensazione di dolore in qualsiasi (non necessariamente in tutte) classi della scala di valutazione.
Nella pratica pediatrica, geriatrica, psichiatrica, così come nei casi in cui la valutazione del livello del dolore sia difficoltosa a causa della barriera linguistica, può essere utilizzata scala pittografica, raffigurante schematicamente l'espressione facciale di una persona.
Ai segni non verbali di dolore ( marcatori del dolore) relazionare:
Pelle bagnata
Tachicardia e tachipnea non associate alla malattia
Lacrime, occhi umidi
dilatazione della pupilla
postura forzata
Espressioni facciali caratteristiche - denti serrati, tensione dei muscoli facciali del viso (fronte accigliata, labbra increspate)
Premendo la mano sul punto del dolore, accarezzandola e strofinandola
Violazione del contatto visivo (spostamento degli occhi).
Cambiare discorso (tempo, coerenza, stile)
Reazioni comportamentali (irrequietezza motoria, battito delle dita, irrequietezza)
Reazioni emotive: capricciosità, irascibilità, labilità emotiva, esplosioni di aggressività.
Disturbi del sonno
Perdita di appetito
Voglia di solitudine
Gemiti durante il sonno o quando il paziente pensa di essere solo
Lamentele frequenti e variegate non legate al dolore.
SCALA PER LA VALUTAZIONE DELLA DESCRIZIONE DEL DOLORE DEL PAZIENTE.
©2015-2019 sito
Tutti i diritti appartengono ai loro autori. Questo sito non rivendica la paternità, ma fornisce un uso gratuito.
Data di creazione della pagina: 13-02-2016
… l'oggettivazione del dolore è uno dei problemi intrattabili nella pratica clinica dei medici di varie specialità.
Attualmente, per valutare la presenza, il grado e la localizzazione del dolore in clinica, (1) psicologico, (2) psicofisiologico e (3) neurofisiologico metodi. La maggior parte di essi si basa su una valutazione soggettiva dei propri sentimenti da parte del paziente stesso.
 I modi più semplici per quantificare il dolore sono la scala di rango (Bonica JJ, 1990).
I modi più semplici per quantificare il dolore sono la scala di rango (Bonica JJ, 1990).
Scala di graduatoria numerica consiste in una serie consecutiva di numeri da 0 a 10. Ai pazienti viene chiesto di valutare le proprie sensazioni di dolore con numeri da 0 (nessun dolore) a 10 (il massimo dolore possibile). I pazienti sono facilmente addestrati all'uso di questa scala. La scala è semplice, visiva e facile da compilare e può essere utilizzata abbastanza spesso durante il trattamento. Ciò consente di ottenere informazioni sulla dinamica del dolore: confrontando gli indicatori di dolore precedenti e successivi, è possibile valutare l'efficacia del trattamento.
Scala del grado verbale consiste in un insieme di parole che caratterizzano l'intensità delle sensazioni del dolore. Le parole sono disposte in fila, riflettendo il grado di aumento del dolore, e sono numerate in sequenza da una gravità minore a una maggiore. I descrittori più comunemente usati sono: nessun dolore (0), dolore lieve (1), dolore moderato (2), dolore severo (3), dolore molto grave (4) e dolore intollerabile (insopportabile) (5). Il paziente sceglie la parola che più si avvicina ai suoi sentimenti. La scala è facile da usare, riflette adeguatamente l'intensità del dolore del paziente e può essere utilizzata per monitorare l'efficacia del sollievo dal dolore. I dati della scala del grado verbale si confrontano bene con i risultati delle misurazioni dell'intensità del dolore utilizzando altre scale.
Scala analogica visiva(VAS) è una linea retta lunga 10 cm, il cui inizio corrisponde all'assenza di dolore - "nessun dolore". Il punto finale della scala riflette un dolore insopportabile atroce - "dolore insopportabile". La linea può essere orizzontale o verticale. Il paziente è invitato a segnare su questa linea un segno corrispondente all'intensità del dolore che sta vivendo in quel momento. La distanza tra l'inizio della linea ("nessun dolore") e il segno fatto dal paziente viene misurata in centimetri e arrotondata al numero intero più vicino. Ogni centimetro della scala analogica visiva corrisponde a 1 punto. Di norma, tutti i pazienti, compresi i bambini di età superiore ai 5 anni, assimilano facilmente la scala analogica visiva e la utilizzano correttamente.
La scala analogica visiva è un metodo abbastanza sensibile per quantificare il dolore e i dati VAS sono correlati bene con altri metodi di misurazione dell'intensità del dolore.
Inventario del dolore McGill(Questionario sul dolore di McGill). Il dolore è una sensazione complessa e multidimensionale, che riflette contemporaneamente l'intensità del dolore, le sue componenti sensoriali ed emotive, pertanto, quando si utilizzano scale di rango unidimensionali, il medico valuta il dolore solo quantitativamente, senza tenere conto delle caratteristiche qualitative del dolore. All'inizio degli anni '70 del XX secolo, R. Melzack sviluppò il questionario sul dolore McGill, in cui tutte le parole (descrittori) che descrivono le caratteristiche qualitative del dolore sono divise in 20 sottoclassi (Melzack R., 1975). Il McGill Pain Inventory è stato tradotto in molte lingue e si è dimostrato altamente efficace nella valutazione multidimensionale del dolore.
Nel nostro paese esistono diverse versioni del questionario in russo, ma la versione di maggior successo è quella preparata dallo staff dell'Università medica statale russa, Università statale di Mosca. MV Lomonosov e CITO loro. NN Priorov (Kuzmenko V.V. et al., 1986), che è riportato di seguito.
QUESTIONARIO SUL DOLORE DI MACGILL
Leggi, per favore, tutte le definizioni di parole e segna solo quelle che più accuratamente caratterizzano il tuo dolore. Puoi contrassegnare solo una parola in una qualsiasi delle 20 colonne (righe), ma non necessariamente in ogni colonna (riga).
Quali parole puoi usare per descrivere il tuo dolore? (scala tattile)
(1)
1. pulsare, 2. afferrare, 3. tirare, 4. tirare, 5. martellare, 6. scavare.
(2)
simile a: 1. scarica elettrica, 2. scossa elettrica, 3. colpo.
(3)
1. accoltellamento, 2. scavo, 3 perforazione, 4. perforazione, 5. punzonatura.
(4)
1. affilato, 2. taglio, 3. striatura.
(5)
1. pressatura, 2. spremitura, 3. pizzicatura, 4. spremitura, 5. frantumazione.
(6)
1. tirare, 2. torcere, 3. strappare.
(7)
1. caldo, 2. bruciante, 3. scottante, 4. bruciante.
(8)
1. prurito, 2. pungente, 3. corrosivo, 4. pungente.
(9)
1. noioso, 2. dolorante, 3. cervello, 4. rottura, 5. scissione.
(10)
1. scoppio, 2. allungamento, 3. lacerazione, 4. lacerazione.
(11)
1. versato, 2. diffusione, 3. penetrazione, 4. penetrazione.
(12)
1. graffiare, 2. dolente, 3. lacrimazione, 4. segare, 5. rosicchiare.
(13)
1. muto, 2. riduzione, 3. raffreddamento.
Quale sentimento provoca dolore, che effetto ha sulla psiche? (scala affettiva)
(14)
1. pneumatici, 2. scarichi.
(15)
provoca una sensazione di: 1. nausea, 2. soffocamento.
(16)
provoca una sensazione di: 1. ansia, 2. paura, 3. orrore.
(17)
1. opprime, 2. irrita, 3. fa arrabbiare, 4. fa infuriare, 5. porta alla disperazione.
(18)
1. indebolisce, 2. acceca.
(19)
1. dolore-ostacolo, 2. dolore-fastidio, 3. dolore-sofferenza, 4. dolore-tortura, 5. dolore-tortura.
Come valuti il tuo dolore? (scala valutativa)
(20) 1. debole, 2. moderato, 3. forte, 4. più forte, 5. insopportabile.
Ogni sottoclasse era composta da parole simili nel loro significato semantico, ma diverse per l'intensità della sensazione di dolore che trasmettono. Le sottoclassi formavano tre classi principali: la scala sensoriale, la scala affettiva e la scala valutativa (valutativa). I descrittori della scala sensoriale (sottoclassi 1-13) caratterizzano il dolore in termini di effetti meccanici o termici, cambiamenti nei parametri spaziali o temporali. La scala affettiva (sottoclassi 14-19) riflette il lato emotivo del dolore in termini di tensione, paura, rabbia o manifestazioni autonome. La scala valutativa (20a sottoclasse) è composta da 5 parole che esprimono la valutazione soggettiva del paziente sull'intensità del dolore.
Durante la compilazione del questionario, il paziente seleziona le parole che corrispondono ai suoi sentimenti in quel momento, in una qualsiasi delle 20 sottoclassi (non necessariamente in ciascuna, ma solo una parola nella sottoclasse). Ogni parola selezionata ha un indicatore numerico corrispondente al numero ordinale della parola nella sottoclasse. Il calcolo si riduce alla definizione di due indicatori: (1) numero indice dei descrittori selezionati, che è la somma delle parole selezionate, e (2) indice di classificazione del doloreè la somma dei numeri ordinali dei descrittori nelle sottoclassi. Entrambi gli indicatori possono essere calcolati per la scala sensoriale e affettiva separatamente o insieme. La scala valutativa è essenzialmente una scala di classificazione verbale, in cui la parola selezionata corrisponde a un certo rango. I dati ottenuti vengono inseriti in una tabella e possono essere presentati sotto forma di diagramma.
Questionario McGill permette di caratterizzare in dinamica non solo l'intensità del dolore, ma anche le sue componenti sensoriali ed emotive, che può essere utilizzato nella diagnosi differenziale delle malattie.
Fattore di età nella valutazione del dolore nei bambini. I bambini di età pari o superiore a 8 anni possono utilizzare le stesse scale analogiche visive per valutare la gravità del dolore degli adulti: questa scala viene applicata al righello, che deve essere posizionato orizzontalmente.
Per i bambini dai 3 agli 8 anni, quando si autovaluta la forza del dolore, è possibile utilizzare sia scale mimiche (i volti nelle fotografie o nei disegni sono allineati in una fila in cui le espressioni facciali di angoscia aumentano gradualmente) o scale con un'analogia cromatica (righelli con crescente luminosità del rosso, che indica la forza del dolore) . È stato riportato un alto grado di somiglianza in termini di intensità del dolore ottenuta utilizzando la scala dei ritratti fotografici e la scala dell'analogia del colore nei bambini di età compresa tra 3 e 7 anni dopo l'intervento chirurgico.
L'uso delle scale di osservazione del comportamento infantile è il metodo principale per valutare il dolore nei neonati, nei lattanti e nei bambini di età compresa tra 1 e 4 anni e nei bambini con disabilità dello sviluppo. In tali scale, il dolore è valutato dall'espressione facciale, dalle risposte motorie degli arti e del tronco, dalle risposte verbali o da una combinazione di cambiamenti comportamentali e autonomici. In alcune di queste tecniche, il termine "angoscia" riflette non solo il dolore, ma anche la paura e l'ansia. Le scale comportamentali possono sottostimare l'intensità del dolore prolungato rispetto alle misure auto-riferite.
Durante l'intervento chirurgico e in terapia intensiva, è utile documentare le risposte fisiologiche al dolore, sebbene queste risposte possano essere aspecifiche. Ad esempio, la tachicardia può essere causata non solo dal dolore, ma anche dall'ipovolemia o dall'ipossiemia. Quindi, ( !!! ) è difficile valutare la gravità del dolore nei neonati, nei lattanti e nei bambini di età compresa tra 1 e 4 anni, nonché nei bambini con disturbi dello sviluppo significativi. Se il quadro clinico non è conclusivo, dovrebbero essere prese in considerazione misure di riduzione dello stress come comfort, nutrizione e analgesia e l'effetto può essere utilizzato per dedurre la causa del disagio.
Quantificazione della sensibilità al dolore si riferisce a indicatori integrativi che riflettono lo stato generale del corpo e la sua risposta allo stress fisiologico o psico-emotivo, quindi la misurazione delle soglie del dolore è un metodo molto utile in un esame completo dei pazienti. La soglia di sensibilità al dolore è considerata il valore minimo dello stimolo che il soggetto percepisce come sensazione di dolore.
Soglia della sensibilità al doloreè determinato utilizzando metodi strumentali, in cui vari stimoli meccanici, termici o elettrici vengono utilizzati come stimoli (Vasilenko A.M., 1997). La soglia del dolore è espressa in (1) unità di forza dello stimolo quando si utilizzano metodi con intensità crescente o in (2) unità di tempo sotto l'azione di uno stimolo con una forza costante. Ad esempio, quando si misura la sensibilità al dolore con un tensoalgometro, che fornisce un graduale aumento della pressione sulla pelle, la soglia del dolore è espressa in unità del rapporto tra la forza di pressione e l'area della punta (kg/cm2). Con la termoalgometria con una temperatura costante del termode, la soglia di sensibilità al dolore è espressa in secondi: il tempo dall'inizio dell'esposizione all'inizio del dolore.
Utilizzando i metodi di valutazione quantitativa della sensibilità al dolore, è possibile (1) rilevare zone di iperalgesia nella patologia degli organi interni, (2) punti trigger nelle sindromi dolorose miofasciali, (3) controllare l'efficacia degli analgesici e in alcuni i casi (ad esempio con sindromi dolorose psicogene) ( 4) determinano tattiche terapeutiche.
Metodi elettrofisiologici. I metodi elettrofisiologici vengono utilizzati anche per valutare la sensibilità al dolore dei pazienti e monitorare l'efficacia del sollievo dal dolore negli studi clinici. Il metodo di registrazione del riflesso nocicettivo da astinenza, o riflesso RIII, è diventato il più utilizzato.
Riflesso nocicettivo da astinenza(NRO), o riflesso flessore nocicettivo è un tipico riflesso protettivo. per la prima volta questo tipo di riflessi protettivi che si verificano sia negli animali che nell'uomo in risposta alla stimolazione del dolore è stato descritto da Sherrington nel 1910 ed è stato utilizzato in clinica per oggettivare il dolore dal 1960 (Kugekberg E. et al., 1960) . Molto spesso, NRO viene registrato in risposta alla stimolazione elettrica n. suralis o la superficie plantare del piede (Vayne A.M., 2001; Skljarevski V., Ramadan N.M., 2002). Allo stesso tempo, NRO può essere registrato con stimolazione del dolore delle dita (Gnezdilova A.V. et al., 1998) e anche con stimolazione eterosegmentale (Syrovegina A.V. et al., 2000).
Quando si registra NRO, si distinguono due componenti nell'attività EMG: le risposte RII e RIII. La risposta RII ha un periodo di latenza di 40–60 ms e il suo aspetto è associato all'attivazione di fibre Aβ spesse a bassa soglia, mentre la risposta RIII si verifica con un periodo di latenza di 90–130 ms ad un'intensità di stimolazione superiore alla soglia di eccitazione di sottili fibre Aδ. Si ritiene che l'NRO sia polisinaptico, il cui arco riflesso si chiude a livello del midollo spinale.
Tuttavia, ci sono dati che indicano la possibilità di coinvolgere le strutture sopraspinali nei meccanismi di insorgenza di NRO. Ciò è confermato direttamente da studi che hanno confrontato le caratteristiche dei cambiamenti nell'HRO nei ratti intatti e spinali (Gozariu M. et al., 1997; Weng H.R., Schouenborg J., 2000). Nel primo studio, gli autori hanno scoperto che nei ratti intatti, la conservazione dei meccanismi di controllo del dolore sopraspinale contrasta lo sviluppo di un aumento dell'ampiezza dell'NRO in condizioni di stimolazione del dolore prolungata, a differenza degli animali spinali. Il secondo documento fornisce prove di un aumento delle risposte inibitorie di NRO agli stimoli nocicettivi eterotopici in condizioni di spinalizzazione animale.
Comprendere il fatto del coinvolgimento delle strutture cerebrali sopraspinali nella formazione di NRO non solo espande le capacità diagnostiche del metodo, ma consente anche di utilizzarlo in clinica per una valutazione oggettiva della gravità della sindrome del dolore non solo durante la stimolazione omotopica , ma anche durante la stimolazione del dolore eterosegmentale.
Il metodo di soppressione esterocettiva dell'attività muscolare volontaria in m. massetere. Per studiare i meccanismi di sviluppo del mal di testa e dei dolori facciali in clinica, il metodo di soppressione esterocettiva dell'attività muscolare volontaria in m. masseter (Vane AM et al., 1999; Andersen OK et al., 1998; Godaux E., Desmendt J.E., 1975; Hansen PO et al., 1999). Questo metodo è essenzialmente un tipo di riflesso nocicettivo da astinenza.
È stato stabilito che la stimolazione elettrica periorale induce due periodi successivi di inibizione dell'attività EMG tonica dei muscoli masticatori, denominati ES1 ed ES2 (soppressione esterocettiva). Il primo periodo di inibizione (ES1) si verifica con una latenza di 10-15 ms, quello tardivo (ES2) ha un periodo di latenza di 25-55 ms. Il grado di soppressione esterocettiva nei muscoli masticatori è accresciuto dall'attività nocicettiva omotopica nelle afferenze trigeminali, che viene utilizzata in clinica per quantificare il dolore nei pazienti con mal di testa e dolore facciale.
Gli esatti meccanismi di sviluppo di ES1 ed ES2 sono sconosciuti. Si ritiene che ES1 sia associato all'attivazione oligosinaptica da parte delle afferenze trigeminali degli interneuroni dei nuclei del complesso trigemino, che hanno un effetto inibitorio sui motoneuroni dei muscoli masticatori, mentre ES2 sia mediato da un arco riflesso polisinaptico che coinvolge i neuroni della parte midollare del nucleo del trigemino spinale (Ongerboer de Visser et al., 1990) . Allo stesso tempo, ci sono prove che l'ES2 può essere registrato durante la stimolazione del dolore eterotopico e la stimolazione elettrica delle dita riduce l'ES2 nei muscoli masticatori (Kukushkin M.L. et al., 2003). Ciò suggerisce che i meccanismi di sviluppo di ES2 sono più complessi e si realizzano con la partecipazione dei centri sopraspinali attraverso il ciclo ricorrente spinocorticospinale.
Metodo di registrazione dei potenziali evocati somatosensoriali. Negli ultimi due decenni, la registrazione dei potenziali evocati somatosensoriali (SSEP) è stata ampiamente utilizzata per misurare il dolore clinico e sperimentale negli esseri umani. Esiste un ampio materiale di ricerca su questo argomento, riassunto in una serie di articoli di revisione (Zenkov L.R., Ronkin M.A., 1991; Bromm B., 1985; Chen A.C.N., 1993). Si ritiene che le prime componenti della SSEP (N65-P120) riflettano l'intensità dello stimolo fisico utilizzato per evocare il dolore, mentre l'ampiezza delle ultime componenti della SSEP (N140-P300) è correlata alla percezione soggettiva del dolore.
L'opinione che l'ampiezza delle componenti del SSEP tardivo possa riflettere la percezione soggettiva del dolore è stata formata sulla base di studi che hanno mostrato una relazione positiva tra una diminuzione dell'ampiezza dei componenti del SSEP N140-P300 e la somministrazione di vari analgesici. Allo stesso tempo, è ben nota la variabilità dell'ampiezza dei componenti tardivi di SSEP, che dipende da una serie di fattori psicologici, come l'attenzione, la memoria, lo stato emotivo (Kostandov EA, Zakharova NN, 1992), che possono in gran parte cambiare senza cambiare solo gli analgesici, ma anche la stessa procedura di ricerca. Inoltre, recenti pubblicazioni su questo argomento (Syrovegin A.V. et al., 2000; Zaslansky R. et al., 1996) indicano una bassa correlazione tra la percezione soggettiva del dolore e l'ampiezza delle componenti del SSEP tardivo.
!!! Il più affidabile tra i metodi elettrofisiologici per controllare l'entità del dolore soggettivo è il riflesso nocicettivo da astinenza (NRO).
Mappatura funzionale dell'attività neuronale delle strutture cerebrali. Recentemente, sono stati introdotti nella pratica clinica metodi di mappatura funzionale dell'attività neuronale delle strutture cerebrali nel dolore acuto e cronico (Coghill R.C., et al., 2000; Rainville P. et al., 2000). I più famosi sono: (1) tomografia ad emissione di positroni e metodo (2) risonanza magnetica funzionale. Tutti i metodi di mappatura funzionale si basano sulla registrazione di una risposta emodinamica locale nelle strutture cerebrali, che ha una correlazione positiva con l'attività elettrica delle popolazioni di neuroni.
Con l'aiuto di metodi di mappatura funzionale, è possibile visualizzare in coordinate spaziali tridimensionali (millimetri nell'uomo e micrometri negli animali) cambiamenti nell'attività neuronale in risposta agli effetti nocicettivi (dolori) presentati, il che rende possibile lo studio della neurofisiologia e meccanismi neuropsicologici del dolore.
Letteratura: 1. Guida per i medici "Patologia generale del dolore" M.L. Kukushkin, NK Khitrov; Mosca, "Medicina"; 2004. 2. "L'uso di analgesici nel trattamento del dolore nei bambini" Editore Elaster J. Wood, Charles Verde, Javille F. Setna (Children's Hospital, Boston, Harvard Medical School, Boston, USA, 2002).
© Laesus De Liro
Cari autori di materiale scientifico che utilizzo nei miei messaggi! Se ritieni che ciò costituisca una violazione della "Legge sul diritto d'autore della Federazione Russa" o desideri vedere la presentazione del tuo materiale in una forma diversa (o in un contesto diverso), in questo caso, scrivimi (al indirizzo postale: [email protetta]) ed eliminerò immediatamente tutte le violazioni e le imprecisioni. Ma siccome il mio blog non ha scopo (e base) commerciale [per me personalmente], ma ha uno scopo puramente didattico (e, di regola, ha sempre un legame attivo con l'autore e il suo lavoro scientifico), quindi gliene sarei grato a voi per l'occasione fare alcune eccezioni per i miei messaggi (contro le norme di legge vigenti). Cordiali saluti, Laesus De Liro.
Messaggi di questo diario di tag "Dolore".
Sindrome di Nikolaou
MANUALE DI UN NEUROLOGO Lo strumento principale e i mezzi efficaci della terapia sintomatica e patogenetica della sindrome del dolore sono ...
Scala analogica visiva (VAS)
La scala analogica visiva (VAS) è stata originariamente creata per l'uso in medicina - secondo essa, il paziente doveva valutare l'intensità del dolore provato in quel momento. Secondo il metodo VAS, il paziente rileva l'intensità del dolore su una linea retta lunga 10 cm. L'inizio della linea a sinistra corrisponde all'assenza di dolore, la fine del segmento a destra corrisponde a un dolore insopportabile. Per comodità dell'elaborazione quantitativa, le divisioni vengono applicate al segmento ogni centimetro. La linea può essere orizzontale o verticale.
L'uso del VAS è abbastanza comune in campo medico perché presenta i seguenti vantaggi:
1) il metodo consente di determinare l'effettiva intensità del dolore;
2) la maggior parte dei pazienti, anche i bambini (di età pari o superiore a 5 anni) imparano facilmente e utilizzano correttamente la VAS;
3) l'utilizzo del VAS consente di studiare la distribuzione del rating;
4) i risultati della ricerca sono riproducibili nel tempo;
5) una valutazione più adeguata dell'effetto del trattamento rispetto alla descrizione verbale del dolore. VAS è stato utilizzato con successo in molti studi per studiare l'efficacia della terapia.
Tuttavia, VAS presenta anche alcuni svantaggi rispetto ad altri metodi. In primo luogo, i pazienti possono arbitrariamente mettere dei segni sulla scala. Spesso tali segni non riflettono la realtà e non corrispondono alle valutazioni del dolore orale fornite dai pazienti stessi. In secondo luogo, deve essere misurata la distanza dalla boa tracciata, che richiede tempo e precisione, e sono possibili anche errori di misurazione. In terzo luogo, la VAS è difficile da spiegare ai pazienti anziani che non capiscono il collegamento tra la linea e la posizione del loro segno su di essa. Infine, la fotocopiatura a volte porta alla distorsione della linea, che si riflette nella misurazione. Pertanto, la VAS non è considerata il metodo ottimale per misurare l'intensità del dolore negli adulti e nei pazienti anziani, ma è raccomandata come efficace nei bambini.
Come già accennato, in campo medico, l'uso del VAS in vari studi è molto più diffuso che in qualsiasi altro campo. Questo vale in particolare per la psicologia.
La scala analogica visiva fu descritta per la prima volta nel 1921 da Hayes & Patterson. . Solo a partire dal 1969 è divenuto oggetto di serio studio, dopo la pubblicazione dell'opera di Aitken, ancora attuale, per l'esiguo numero di opere dedicate alla VAS.
Aitken ha utilizzato questa scala nel suo studio per valutare i sentimenti dei pazienti con disturbo depressivo. Credeva che un sistema digitale fosse imposto all'osservatore, mentre un sistema analogico sarebbe stato più appropriato.
Se persone diverse usano la stessa parola, non significa che provino le stesse emozioni - questo vale anche per la posizione dei segni sulla scala. Un'emozione vissuta due volte più intensamente non può essere correlata a un punteggio raddoppiato. C'è la tendenza a limitare le divisioni in categorie, poiché di solito vengono utilizzate solo le più elementari. Ciò rende tali scale inefficaci nell'esaminare determinate associazioni a concetti dati, come l'entità fisica di uno stimolo. Queste scale non sono in grado di segnare le sfumature dei sentimenti.
Aitken era convinto che le analogie dovessero essere visive e non semplici frasi, altrimenti valutazioni estreme (es. 0 o 5) sarebbero state troppo comuni (Yerkes & Urban 1906).
Nel suo studio, ai pazienti è stato chiesto di segnare l'intensità della loro condizione su una scala analogica visiva ogni giorno per diverse settimane. In questa situazione, la scala era davvero molto adatta per misurare i cambiamenti e valutarne l'importanza. Tuttavia, il dottor Raymond Levy (Dipartimento di Psichiatria, Middlesex Hospital School of Medicine, Londra) ha ritenuto di aver sottovalutato le difficoltà legate al lavoro con tali scale. Sospettava che tali scale fossero particolarmente efficaci nel valutare i pazienti con sintomi lievi che sapevano esattamente cosa intendeva il medico, che iniziavano a usare la stessa terminologia. I pazienti che soffrivano sia di una forma moderata di depressione che di una più grave hanno avuto difficoltà a lavorare con queste scale.
Il dottor J.P. Watson (Maudsley Clinic, Londra) ha ritenuto che i problemi di definizione dei termini e delle scale presentati dal Dr. Aitken non fossero diversi da quelli dell'utilizzo di qualsiasi scala di valutazione. Si chiese se il dottor Aitken avesse prove che i pazienti stavano dando intenzionalmente risultati che sapevano essere sbagliati.
Il dottor Aitken ha notato che l'osservazione del dottor Levy era importante e ha concordato con il dottor Watson che si applica a tutti i tipi di autovalutazione. Nella sua esperienza, i pazienti oggi usano parole come "depressione" senza esitazione, ma non c'è dubbio che le loro parole possono significare qualcosa di molto diverso da quello che gli psichiatri avevano in mente quando le usavano. È necessario chiarire l'esatta natura del sintomo, come indicato nella valutazione clinica di tutti i sintomi. Le scale analogiche possono dire esattamente ciò che i pazienti vogliono dire, ma non ciò che il medico aveva in mente.
Questo studio spiega in dettaglio perché la VAS può essere migliore, più conveniente, più affidabile e più affidabile delle misurazioni con punteggi o divisioni limitate. Ovviamente, le persone con depressione sono divise in diverse categorie e l'uso di un "sistema digitale" può distorcere i risultati nel senso che il paziente semplicemente non cerca di pensare all'intensità delle sue esperienze e sceglie uno dei valori estremi. L'uso di scale simili, ma solo con una descrizione della condizione, dà ancora una volta la sensazione che stiano scegliendo per il paziente, senza ottenere un risultato realmente affidabile. Tuttavia, questo è solo uno studio in cui il soggetto è uno stato psicologico piuttosto complesso, in modo da poter scegliere inequivocabilmente il miglior sistema di misurazione per esso.
In generale, non ci sono molti studi che confrontino la scala Likert e la scala analogica visiva. Ad esempio, in uno studio di Torrance, Feeny e Furlong, il VAS ha dimostrato di essere più affidabile della scala Likert. . Un altro studio di Flynn che confronta una scala Likert a 5 punti con 65 mm. VAS sull'esempio della misurazione dei coping, è dimostrato che i soggetti, quando rispondono alla stessa domanda, mostrano risultati più elevati quando lavorano con la scala Likert, rispetto a VAS.
Jennifer A. Cowley e Heather Youngblood, nel loro studio che confronta le differenze nelle risposte su scale visive analogiche, numeriche e miste, riferiscono di aver trovato emotivamente più difficile usare le scale analogiche rispetto alle scale numeriche perché gli spazi non erano stati riempiti. fornire una spiegazione.
Le scale in cui ogni divisione contiene una spiegazione testuale dettagliata hanno mostrato risultati più affidabili rispetto a quelle in cui alcune divisioni contenevano lacune. Inoltre, il vantaggio dell'utilizzo di dati numerici, ad esempio, quando si lavora con l'analisi delle variazioni, è che in questo caso è possibile valutare alcune interazioni mutevoli, cosa impossibile quando si lavora con dati non parametrici.
Tuttavia, alcuni ricercatori potrebbero preferire le scale analogiche perché, a differenza delle scale numeriche, possono utilizzare analisi statistiche parametriche efficienti.
Anche in questo studio sono state utilizzate scale miste - scale analogiche con l'aggiunta di varie divisioni: digitali o con spiegazione testuale selettiva. Allo stesso tempo, è stata preservata la capacità di mettere la propria valutazione in qualsiasi punto della scala.
Le scale miste qui hanno mostrato punteggi medi molto più alti rispetto a quelle analogiche. Inoltre, le risposte raccolte dalle scale numeriche e miste non differivano molto l'una dall'altra, mentre le risposte dalle scale analogiche e numeriche differivano notevolmente.
Pertanto, possiamo concludere che i VAS, come la scala Likert, hanno i propri insiemi di vantaggi e svantaggi. Tuttavia, nel primo studio, come nell'ultimo, è stata sollevata la domanda principale, che potrebbe poi diventare una soluzione al problema della scelta di uno strumento di misura: possiamo misurare caratteristiche come depressione, ansia o qualsiasi altro stato continuo con scale ordinali? In questo caso dovremmo utilizzare una scala non parametrica, perché utilizzando una scala ordinale rischiamo di ottenere un risultato approssimativo e lontano dal vero atteggiamento del soggetto, oltre a perdere una quantità significativa di dati.
È possibile che l'idea di utilizzare scale miste sia anche la soluzione a questo problema. Dato che i punteggi numerici e misti producono punteggi medi più alti in molti studi, i ricercatori potrebbero chiedersi se ciò sia dovuto al fatto che una persona ottiene punteggi senza o in base a divisioni numeriche e testuali. Fino a quando questo problema non sarà risolto, i ricercatori possono utilizzare scale miste per facilitare la compilazione del questionario da parte dei soggetti, garantendo l'affidabilità dei risultati dell'analisi parametrica utilizzando dati analogici.