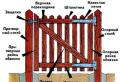La fase iniziale dello shock. Condizioni d'urto pericolose
Lo shock è una certa condizione in cui c'è una forte carenza di sangue negli organi più importanti di una persona: cuore, cervello, polmoni e reni. Pertanto, si verifica una situazione in cui il volume disponibile di sangue è insufficiente per riempire il volume disponibile dei vasi sotto pressione. In una certa misura, lo shock è una condizione che precede la morte.
cause
Le cause dello shock sono causate da una violazione della circolazione di un volume fisso di sangue in un certo volume di vasi, che sono in grado di restringersi ed espandersi. Pertanto, tra le cause più comuni di shock, si può individuare una forte diminuzione del volume del sangue (perdita di sangue), un rapido aumento dei vasi sanguigni (i vasi sanguigni si espandono, di regola, in risposta al dolore acuto, l'esposizione a un allergene o ipossia), nonché l'incapacità del cuore di svolgere le funzioni ad esso assegnate (contusione del cuore durante una caduta, infarto del miocardio, "flessione" del cuore in caso di pneumotorace iperteso).
Cioè, lo shock è l'incapacità del corpo di garantire la normale circolazione sanguigna.
Tra le principali manifestazioni di shock, si possono distinguere una frequenza cardiaca rapida superiore a 90 battiti al minuto, un polso debole filiforme, bassa pressione sanguigna (fino alla sua completa assenza), respiro rapido, in cui una persona a riposo respira come se stesse eseguendo pesanti attività fisica. Anche il pallore della pelle (la pelle diventa blu pallido o giallo pallido), la mancanza di urina e una grave debolezza in cui una persona non può muoversi e pronunciare parole sono segni di shock. Lo sviluppo dello shock può portare alla perdita di coscienza e alla mancanza di risposta al dolore.
Tipi di shock
Lo shock anafilattico è una forma di shock caratterizzata da una forte vasodilatazione. La causa dello shock anafilattico può essere una certa reazione all'ingresso di un allergene nel corpo umano. Questa può essere una puntura d'ape o la somministrazione di un farmaco a cui una persona è allergica.
Lo sviluppo dello shock anafilattico si verifica quando l'allergene entra nel corpo umano, indipendentemente da quanto entra nel corpo. Ad esempio, non importa affatto quante api hanno morso una persona, poiché in ogni caso si verificherà lo sviluppo di uno shock anafilattico. Tuttavia, il sito del morso è importante, poiché con danni al collo, alla lingua o all'area del viso, lo sviluppo dello shock anafilattico avverrà molto più velocemente rispetto a un morso alla gamba.
Lo shock traumatico è una forma di shock, che è caratterizzata da una condizione estremamente grave del corpo, provocata da sanguinamento o irritazione del dolore.
Tra i motivi più comuni per lo sviluppo dello shock traumatico ci sono la pelle pallida, il sudore appiccicoso, l'indifferenza, la letargia e il battito cardiaco accelerato. Altre cause di shock traumatico includono sete, secchezza delle fauci, debolezza, ansia, incoscienza o confusione. Questi segni di shock traumatico sono in qualche modo simili ai sintomi di emorragia interna o esterna.
Lo shock emorragico è una forma di shock in cui si osserva una condizione di emergenza del corpo, che si sviluppa a causa di una perdita di sangue acuta.
Il grado di perdita di sangue ha un impatto diretto sulla manifestazione dello shock emorragico. In altre parole, la forza della manifestazione dello shock emorragico dipende direttamente dalla quantità di cui il volume di sangue circolante (CTC) diminuisce in un periodo di tempo abbastanza breve. La perdita di sangue in un volume di 0,5 litri, che si verifica per tutta la settimana, non sarà in grado di provocare lo sviluppo di shock emorragico. In questo caso, si sviluppa la clinica dell'anemia.
Lo shock emorragico si verifica a causa della perdita di sangue in un volume totale di 500 ml o più, che è il 10-15% del volume del sangue circolante. La perdita di 3,5 litri di sangue (70% del volume sanguigno) è considerata fatale.
Lo shock cardiogeno è una forma di shock, che è caratterizzata da un complesso di condizioni patologiche nel corpo, provocate da una diminuzione della funzione contrattile del cuore.
Tra i principali segni di shock cardiogeno, si possono individuare interruzioni nel lavoro del cuore, che sono il risultato di un ritmo cardiaco anormale. Inoltre, con lo shock cardiogeno, ci sono interruzioni nel lavoro del cuore e dolore al petto. L'infarto del miocardio è caratterizzato da una forte sensazione di paura con embolia polmonare, mancanza di respiro e dolore acuto.
Tra gli altri segni di shock cardiogeno, si possono distinguere reazioni vascolari e autonomiche, che si sviluppano a seguito di una diminuzione della pressione sanguigna. Sudore freddo, pallore, alternato a unghie e labbra blu, così come una grave debolezza sono anche sintomi di shock cardiogeno. Si notano spesso sentimenti di intensa paura. Il gonfiore delle vene che si verifica dopo che il cuore smette di pompare sangue provoca il rigonfiamento delle vene giugulari del collo. Con il tromboembolismo, la cianosi si verifica abbastanza rapidamente e c'è anche una marmorizzazione della testa, del collo e del torace.
Nello shock cardiogeno, dopo la cessazione della respirazione e dell'attività cardiaca, può verificarsi perdita di coscienza.
Pronto soccorso per shock
Un'assistenza medica tempestiva per lesioni gravi e traumi può prevenire lo sviluppo di shock. L'efficacia del primo soccorso per lo shock dipende in gran parte dalla rapidità con cui viene fornito. Il primo soccorso per lo shock consiste nell'eliminare le principali cause dello sviluppo di questa condizione (arresto del sanguinamento, riduzione o alleviare il dolore, miglioramento dell'attività respiratoria e cardiaca, raffreddamento generale).
Quindi, prima di tutto, nel processo di fornire il primo soccorso per lo shock, si dovrebbero affrontare le cause di questa condizione. È necessario liberare la vittima dai detriti, fermare l'emorragia, estinguere gli indumenti in fiamme, rendere innocua la parte danneggiata del corpo, eliminare l'allergene o fornire un'immobilizzazione temporanea.
Se la vittima è cosciente, si consiglia di offrirgli un anestetico e, se possibile, dargli del tè caldo.
Nel processo di fornire il primo soccorso per lo shock, è necessario allentare gli indumenti stretti sul petto, sul collo o sulla vita.
La vittima deve essere posta in una posizione tale che la testa sia girata di lato. Questa postura evita di affondare la lingua, così come il soffocamento con il vomito.
Se lo shock si verifica quando fa freddo, la vittima deve essere riscaldata e, se fa caldo, protetta dal surriscaldamento.
Inoltre, nel processo di fornitura del primo soccorso per lo shock, se necessario, è necessario liberare la bocca e il naso della vittima da oggetti estranei, dopodiché eseguire un massaggio cardiaco chiuso e una respirazione artificiale.
Il paziente non deve bere, fumare, usare termofori o borse dell'acqua calda o stare da solo.
Attenzione!
Questo articolo è pubblicato solo a scopo didattico e non costituisce materiale scientifico o consulenza medica professionale.
Iscriviti per un appuntamento con il medico
V.K. Kulagin distingue le seguenti fasi:
1. Stadio nervoso: il nome sottolinea il ruolo principale del fattore nervoso nella fase iniziale dello shock.
2. Vascolare (i principali fattori patogenetici sono una diminuzione del volume del sangue circolante, la centralizzazione della circolazione sanguigna, i disturbi della microcircolazione con il successivo sviluppo dell'ipossia in molti tessuti).
3. Metabolico (i disturbi metabolici vengono aggiunti ai disturbi emodinamici, che complicano il corso del processo: acidosi metabolica, rilascio di vari enzimi dalle cellule, compresi gli enzimi lisosomiali nei tessuti e nel sangue).
Le seguenti fasi di shock sono più comuni:
1) Lo stadio di shock compensato, eccitazione - erettile.
2) Stadio di shock scompensato, inibizione - torpore.
3) Stadio di shock termico, preagonale.
Nella fase erettile, c'è un aumento della pressione sanguigna, un aumento della frequenza cardiaca, un'accelerazione del flusso sanguigno. C'è anche uno spasmo dei vasi di molti organi periferici sullo sfondo dell'attivazione del flusso sanguigno negli organi vitali - la centralizzazione della circolazione sanguigna. Lo stadio è più pronunciato nello shock traumatico e da ustione, con shock anafilattico e trasfusionale, è di breve durata.
Nella fase torpida, la pressione sanguigna diminuisce e il grado di questa diminuzione determina, insieme ad altri indicatori, la gravità dello shock. Una diminuzione della produzione oraria di urina inferiore a 40 ml porta successivamente allo sviluppo di disordini metabolici e quindi, al passaggio allo stadio successivo - termico e irreversibili disturbi morfologici. Si basano sull'ipossia stagnante - anossia, che spesso diventa irreversibile.
2.1.1. Eziologia e patogenesi dello shock ipovolemico (hsh)
Questo shock si sviluppa con un'ampia perdita di liquidi. La causa più comune di HS è la perdita di sangue acuta a seguito di traumi o emorragie interne (da ulcera peptica, varici esofagee, aneurismi aortici). La perdita di sangue può essere evidente (p. es., con feci sanguinolente) o latente (p. es., con una gravidanza extrauterina).
Allo stesso tempo, l'HS può svilupparsi con grandi perdite non solo di sangue, ma anche di altri fluidi. In questi casi i suoi sintomi non compaiono subito, ma dopo alcune ore e sono accompagnati da ispessimento del sangue. Il fluido può essere perso:
con massicce ustioni termiche e chimiche;
quando si accumula nella cavità addominale (peritonite).
con abbondante diarrea e vomito indomabile.
con urina con diabete mellito e diabete insipido, insufficienza surrenalica, con sovradosaggio di forti diuretici.
Oltre all'ipovolemia assoluta, c'è l'ipovolemia relativa, in cui può esserci abbastanza e anche molto sangue nei vasi, ma una parte minore di esso partecipa alla circolazione e una grande parte si deposita (sequestrata) nel capillare e letto venoso. Questa situazione è tipica dello shock settico, anafilattico e, in una certa misura, cardiogeno, conferendo a tutte queste varianti di shock una certa somiglianza con lo shock ipovolemico, incluso lo shock emorragico.
Un adulto può facilmente far fronte alla perdita del 10% del volume sanguigno circolante totale (BCC) mediante meccanismi di mantenimento della pressione sanguigna, che, prima di tutto, includono la vasocostrizione sotto l'influenza delle catecolamine. Se, tuttavia, una persona perde rapidamente dal 20 al 25% del sangue circolante, i meccanismi compensatori di solito non funzionano più completamente e si sviluppano sintomi di shock.
Con lo shock emorragico, si osservano i cambiamenti più sorprendenti nell'emodinamica.
I meccanismi compensatori si attivano immediatamente dopo la perdita di sangue, volti a mantenere la pressione sanguigna:
1) una diminuzione della gittata cardiaca (CO) è accompagnata da un aumento del tono delle arteriole dovuto ad un aumento della sensibilità dei vasi periferici alle catecolamine e ad altri vasocostrittori;
2) i capillari si sovrappongono e il sangue inizia a fluire attraverso gli shunt artero-venosi;
3) l'ischemia renale innesca la secrezione di renina e, attraverso di essa, il sistema renina-angiotensina-aldosterone con ritenzione di sodio e acqua e aumento del BCC.
La vasocostrizione periferica (o spasmo delle arteriole), da un lato, mantiene la pressione sanguigna e, dall'altro, complica la perfusione tissutale. A questo proposito, l'ipossia si sviluppa nei tessuti, si accumulano sostanze che riducono il tono vascolare. Questi sono lattato, adenosina e molti altri prodotti intermedi. I microvasi, specialmente quelli metabolici, traboccano di sangue. Questo può essere considerato come una reazione compensatoria del corpo in risposta all'ipossia (per risolvere la carenza di ossigeno) in questa situazione estrema. Di conseguenza, si sviluppa la stasi venosa e molti liquidi lasciano la circolazione attiva, il flusso sanguigno si indebolisce. In questa fase, tutti i microvasi muscolari perdono la sensibilità ai vasocostrittori.
La perfusione del cuore e del cervello viene mantenuta per il tempo più lungo, ma poi fallisce. Vasocostrizione. compensatoria infatti, può provocare necrosi ischemica dell'intestino o delle dita. Il fattore della depressione miocardica compare nel sangue, indebolendo le contrazioni cardiache.
Oltre all'ipossia, l'endotossina dei batteri intestinali gram-negativi svolge un ruolo importante nella diminuzione del tono vascolare periferico in qualsiasi forma di shock. Se i disturbi del microcircolo fossero associati solo all'acidosi metabolica, sarebbero eliminati relativamente facilmente dopo aver rimosso il corpo dall'ipossia. Ciò, tuttavia, non accade, perché oltre all'ipossia, una serie di mediatori "shockogenic" altamente attivi dei leucociti e dell'endotelio microvascolare formati sotto l'influenza dell'endotossina sono coinvolti nell'espansione paralitica dei microvasi (vedi shock settico).
Il fatto è che qualsiasi shock è accompagnato da ischemia dell'intestino crasso. A sua volta, l'ischemia rende la parete intestinale permeabile all'endotossina, che entra nel fegato attraverso il sistema della vena porta. In condizioni normali, quasi tutta l'endotossina viene depositata e neutralizzata nelle RES epatiche. Allo stesso tempo, in stato di shock, il fegato perde la sua capacità di catturare e disintossicare l'endotossina. Quest'ultimo, bypassando il fegato, penetra nella circolazione sistemica, collegandosi alla patogenesi dello shock.
Informazione Generale
Lo shock è la risposta del corpo all'azione di stimoli aggressivi esterni, che può essere accompagnato da disturbi della circolazione sanguigna, del metabolismo, del sistema nervoso, della respirazione e di altre funzioni vitali del corpo.
Ci sono tali ragioni per lo shock:
1. Lesioni derivanti da effetti meccanici o chimici: ustioni, rotture, danni ai tessuti, lacerazioni degli arti, esposizione a corrente (shock traumatico);
2. Trauma concomitante perdita di sangue in grandi quantità (shock emorragico);
3. Trasfusione di sangue incompatibile al paziente in un grande volume;
4. Ingresso di allergeni in un ambiente sensibilizzato (shock anafilattico);
5. Ampia necrosi di fegato, intestino, reni, cuore; ischemia.
È possibile diagnosticare lo shock in una persona che ha subito uno shock o un infortunio in base ai seguenti segni:
- ansia;
- coscienza offuscata con tachicardia;
- bassa pressione sanguigna;
- problemi di respirazione
- diminuzione del volume di urina escreta;
- la pelle è fredda e umida, marmorizzata o di colore cianotico pallido
Il quadro clinico dello shock
Il quadro clinico dello shock differisce a seconda della gravità degli stimoli esterni. Per valutare correttamente le condizioni di una persona che ha subito uno shock e per fornire assistenza con lo shock, è necessario distinguere diverse fasi di questa condizione:
1. Shock di 1 grado. La persona mantiene la coscienza, entra in contatto, sebbene le reazioni siano leggermente inibite. Indicatori del polso - 90-100 battiti, pressione sistolica - 90 mm;
2. Grado d'urto 2. Anche le reazioni della persona sono inibite, ma è cosciente, risponde correttamente alle domande poste, parla con voce ovattata. C'è una rapida respirazione superficiale, polso rapido (140 battiti al minuto), la pressione sanguigna è ridotta a 90-80 mm Hg. La prognosi per un tale shock è grave, la condizione richiede procedure anti-shock urgenti;
3. Grado d'urto 3. Una persona ha reazioni inibite, non sente dolore ed è adinamica. Il paziente parla lentamente e in un sussurro, potrebbe non rispondere affatto alle domande o a monosillabi. La coscienza può essere completamente assente. La pelle è pallida, con acrocianosi pronunciata, ricoperta di sudore. Il polso della vittima è appena percettibile, palpabile solo sulle arterie femorale e carotide (di solito 130-180 battiti / min). Si osserva anche una respirazione superficiale e rapida. La pressione venosa centrale può essere inferiore a zero o zero e la pressione sistolica inferiore a 70 mmHg.
4. Shock 4 gradi - questo è uno stato terminale del corpo, spesso espresso in cambiamenti patologici irreversibili - ipossia tissutale, acidosi, intossicazione. Le condizioni del paziente con questa forma di shock sono estremamente difficili e la prognosi è quasi sempre negativa. Il cuore della vittima non è disturbato, è privo di sensi e respira superficialmente con singhiozzi e convulsioni. Non c'è reazione al dolore, le pupille sono dilatate. In questo caso, la pressione sanguigna è di 50 mm Hg e potrebbe non essere determinata affatto. Anche il polso è sottile e si fa sentire solo sulle arterie principali. La pelle umana è grigia, con un caratteristico disegno marmoreo e macchie, simili a quelle cadaveriche, che indicano una diminuzione generale della circolazione sanguigna.
Tipi di shock
Lo stato di shock è classificato in base alla causa dello shock. Quindi, puoi evidenziare:
Shock vascolare (shock settico, neurogeno, anafilattico);
Ipovolemico (shock anidroemico ed emorragico);
Shock cardiogenico;
Shock doloroso (ustione, shock traumatico).
Lo shock vascolare è uno shock causato da una diminuzione del tono vascolare. Le sue sottospecie: shock settico, neurogeno, anafilattico - queste sono condizioni con patogenesi diversa. Lo shock settico si verifica a seguito di un'infezione umana con un'infezione batterica (sepsi, peritonite, processo cancrenoso). Lo shock neurogeno si verifica più spesso dopo una lesione del midollo spinale o del midollo allungato. Lo shock anafilattico è una grave reazione allergica che si verifica entro i primi 2-25 minuti. dopo che l'allergene entra nel corpo. Le sostanze che possono causare shock anafilattico sono plasma e preparazioni di proteine plasmatiche, contrasto radiografico e anestetici e altri farmaci.
Lo shock ipovolemico è causato da una carenza acuta di sangue circolante, una diminuzione secondaria della gittata cardiaca e una diminuzione del ritorno venoso al cuore. Questa condizione di shock si verifica con disidratazione, perdita di plasma (shock anidro) e perdita di sangue - shock emorragico.
Lo shock cardiogeno è una condizione estremamente grave del cuore e dei vasi sanguigni, caratterizzata da un alto tasso di mortalità (dal 50 al 90%), e derivante da un grave disturbo circolatorio. Nello shock cardiogeno, il cervello, a causa della mancanza di afflusso di sangue (funzione cardiaca compromessa, vasi dilatati, incapacità di trattenere il sangue), sperimenta una forte mancanza di ossigeno. Pertanto, una persona in uno stato di shock cardiogeno perde conoscenza e molto spesso muore.
Lo shock doloroso, come lo shock cardiogeno e anafilattico, è una condizione di shock comune che si verifica durante una reazione acuta a una lesione (shock traumatico) oa un'ustione. Inoltre, è importante capire che l'ustione e lo shock traumatico sono tipi di shock ipovolemico, perché sono causati dalla perdita di una grande quantità di plasma o sangue (shock emorragico). Questo può essere sanguinamento interno ed esterno, così come l'essudazione di fluido plasmatico attraverso le aree bruciate della pelle con ustioni.
Aiuto shock
 Quando si fornisce assistenza in caso di shock, è importante capire che spesso la causa degli stati di shock tardivi è il trasporto improprio della vittima e la fornitura di primo soccorso in caso di shock, quindi è molto importante eseguire le procedure di soccorso di base prima dell'arrivo della squadra di ambulanze.
Quando si fornisce assistenza in caso di shock, è importante capire che spesso la causa degli stati di shock tardivi è il trasporto improprio della vittima e la fornitura di primo soccorso in caso di shock, quindi è molto importante eseguire le procedure di soccorso di base prima dell'arrivo della squadra di ambulanze.
L'aiuto con lo shock consiste nelle seguenti attività:
1. Eliminare la causa dello shock, ad esempio, smettere di sanguinare, rilasciare gli arti pizzicati, estinguere gli indumenti in fiamme sulla vittima;
2. Verificare la presenza di corpi estranei nella bocca e nel naso della vittima, se necessario rimuoverli;
3. Verificare la presenza di respirazione, polso e, se necessario, eseguire un massaggio cardiaco, respirazione artificiale;
4. Assicurati che la vittima giace con la testa sul fianco, in modo che non si soffochi con il proprio vomito, la sua lingua non affondi;
5. Determinare se la vittima è cosciente e somministrargli l'anestetico. Si consiglia di somministrare al paziente tè caldo, ma di escludere prima questa lesione all'addome;
6. Allentare i vestiti sulla cintura, sul petto, sul collo della vittima;
7. Il paziente deve essere riscaldato o raffreddato, a seconda della stagione;
8. La vittima non deve essere lasciata sola, non deve fumare. Inoltre, non è possibile applicare un termoforo ai punti feriti: questo può provocare il deflusso di sangue dagli organi vitali.
Video di YouTube relativo all'articolo:
In medicina, il termine "shock" viene utilizzato quando si tratta di condizioni complesse (gravi, patologiche) derivanti dall'influenza di stimoli estremi e che hanno determinate conseguenze.
Nella vita di tutti i giorni, lo stesso termine è usato dalle persone per definire un forte shock nervoso, sebbene ci siano molte situazioni diverse che possono causare uno stato di shock. Quindi cos'è lo shock e che tipo di cure di emergenza sono necessarie in tali situazioni?
Terminologia e classificazioni
Le prime menzioni dello shock come processo patologico sono apparse più di 2000 anni fa, sebbene nella pratica medica questo termine sia diventato ufficiale solo nel 1737. Ora viene utilizzato per determinare la risposta del corpo agli stimoli esterni più forti.
Tuttavia, lo shock non è un sintomo o una diagnosi. E questa non è nemmeno una malattia, sebbene la sua definizione indichi un processo patologico acuto che si sviluppa nel corpo, che provoca gravi disturbi nell'attività dei sistemi interni.
Esistono solo due tipi di shock:
- Lo shock psicologico è una potente reazione nel cervello umano che si manifesta in risposta a un trauma psicologico o fisico. È così che la coscienza umana viene “protetta” quando rifiuta di accettare la realtà di ciò che è accaduto.
- Fisiologico è un problema puramente medico, la cui soluzione deve essere affrontata da professionisti.
Tra i vari fattori che provocano il verificarsi di tali reazioni, si possono distinguere le seguenti cause di shock:
- Lesioni di diversa natura (ustioni o altri disturbi tissutali, scosse elettriche, rottura di legamenti, ecc.).
- Le conseguenze della lesione sono gravi emorragie.
- Trasfusione di sangue incompatibile per gruppo (in grandi quantità).
- Reazione allergica grave.
- Necrosi, che ha gravemente danneggiato le cellule del fegato, dei reni, dell'intestino e del cuore.
- Ischemia, accompagnata da disturbi circolatori.
A seconda di quali fattori iniziali hanno provocato la condizione patologica, si distinguono diversi tipi di shock:
1. Vascolare è uno shock causato da una diminuzione del tono vascolare. Può essere anafilattico, settico e neurogeno.
2. Shock ipovolemico. Tipi di shock: anidremico (a causa della perdita di plasma), emorragico (con grave perdita di sangue). Entrambi i tipi sorgono sullo sfondo di un'insufficienza acuta di sangue nel sistema di afflusso di sangue, una diminuzione del flusso di sangue venoso che entra o esce dal cuore. Una persona può anche cadere in uno shock ipovolemico durante la disidratazione (disidratazione).
3. Cardiogenico: una condizione patologica acuta che provoca disturbi nel lavoro del sistema cardiovascolare, che nel 49-89% dei casi porta alla morte. Un tale stato di shock è accompagnato da una forte mancanza di ossigeno nel cervello, che si verifica sullo sfondo della cessazione dell'afflusso di sangue.
4. Doloroso: la condizione più comune del corpo umano, manifestata in risposta a un'irritazione esterna acuta. Ustioni e traumi sono le cause più comuni di shock doloroso.
C'è un'altra classificazione dello shock che è stata sviluppata dal patologo Selye dal Canada. In accordo con esso, è possibile distinguere le fasi principali dello sviluppo del processo patologico, che sono caratteristiche di ciascuno dei tipi di condizioni gravi sopra descritte. Quindi, le fasi principali nello sviluppo delle deviazioni:
Stadio I - reversibile (o compensato). Nella fase iniziale dello sviluppo della risposta del corpo a uno stimolo aggressivo, il funzionamento dei principali sistemi e organi dell'attività vitale viene interrotto. Tuttavia, poiché il loro lavoro non si ferma, viene stabilita una previsione molto favorevole per questa fase di shock.
Stadio II - parzialmente reversibile (o scompensato). In questa fase, ci sono violazioni significative dell'afflusso di sangue che, fornite cure mediche tempestive e corrette, non causeranno gravi danni ai principali sistemi di funzionamento del corpo.
A sua volta, questa fase può essere subcompensata, in cui il processo patologico procede in forma moderata con previsioni piuttosto controverse, e scompenso, procedendo in forma più grave e previsioni difficili da stabilire.
Stadio III - irreversibile (o terminale). La fase più pericolosa in cui viene inflitto un danno irreparabile al corpo, che esclude la probabilità di ripristino delle funzioni anche con un intervento medico tempestivo.
Allo stesso tempo, il famoso chirurgo russo Pirogov è stato in grado di identificare le fasi dello shock, la cui caratteristica distintiva è il comportamento del paziente:
1. Fase torpida: una persona è stordita, passiva e letargica. In uno stato di shock, non è in grado di rispondere agli stimoli esterni e rispondere alle domande.
2. La fase erettile: il paziente si comporta in modo estremamente attivo ed eccitato, non si rende conto di ciò che sta accadendo e, di conseguenza, commette molte azioni incontrollate.
Quali sono i segnali per riconoscere il problema
Se consideriamo i sintomi dello shock in modo più dettagliato, possiamo evidenziare i principali segni che indicano lo sviluppo di un processo patologico sullo sfondo dello shock ricevuto. I suoi sintomi principali sono:
- Battito cardiaco accelerato.
- Una leggera diminuzione della pressione sanguigna.
- Raffreddamento delle estremità in un contesto di bassa perfusione.
- Aumento della traspirazione sulla pelle.
- Secchezza delle mucose.
Contrariamente ai sintomi della fase iniziale del problema, i segni di shock nella terza fase (terminale) sono più pronunciati e richiedono una risposta immediata da parte degli operatori sanitari. Esso:
- Tachicardia.
- Un forte calo della pressione sanguigna a un livello inferiore a quello critico.
- Problemi respiratori.
- Polso debole, appena palpabile.
- Raffreddamento della pelle in tutto il corpo.
- Cambiamento del colore della pelle da normale a grigio chiaro, marmorizzato.
- Oligureya.
- Cambiamenti nel colore della pelle delle dita: quando vengono premuti, diventano pallidi e tornano al colore precedente se il carico viene rimosso.
Il decorso dello shock durante la disidratazione è accompagnato da ulteriori sintomi: essiccazione delle mucose e diminuzione del tono dei tessuti dei bulbi oculari. Nei neonati e nei bambini fino a 1-1,5 anni si può osservare il prolasso della fontanella.
Questi e altri segni sono solo manifestazioni esterne di processi patologici che possono essere trovati in una persona che sta vivendo uno stato di shock. Confermare la presenza di questi processi e stabilire le cause del loro verificarsi consentono studi speciali condotti in cliniche. Nella modalità di emergenza, il personale medico deve prelevare il sangue, eseguire l'analisi biochimica, esaminare la frequenza cardiaca, determinare la pressione venosa e monitorare la respirazione del paziente.
Se consideriamo questo problema dal punto di vista del quadro clinico, si possono distinguere tre gradi di shock. La classificazione delle condizioni di shock per gravità consente di valutare correttamente il benessere del paziente. Dovrebbero essere distinti i seguenti gradi del processo patologico:
I grado - il paziente rimane cosciente e può anche mantenere una conversazione adeguata, sebbene possa avere reazioni inibite. In tali situazioni, il polso della vittima può variare tra 90-100 battiti/min. L'indicatore caratteristico della pressione sistolica in un paziente in questo stato è di 90 mm.
II grado: una persona mantiene il buon senso e può comunicare, ma allo stesso tempo parlerà in modo ovattato, leggermente inibito. Altri segni caratteristici di questa condizione sono polso rapido, respiro superficiale, inspirazione ed espirazione frequenti e pressione sanguigna bassa. Il paziente ha bisogno di assistenza immediata sotto forma di trattamenti anti-shock.
III grado: una persona in questa fase di shock parla piano, non molto chiaramente, lentamente. Non sente dolore ed è in prostrazione. Il suo polso non si sente praticamente, ma quando si sonda l'arteria, si possono contare da 130 a 180 battiti cardiaci al minuto. I sintomi esterni di questo grado includono: pelle pallida, sudorazione eccessiva, respirazione rapida.
IV grado - uno stato di shock, che procede in forma grave ed è caratterizzato da perdita di coscienza, una risposta assente agli stimoli del dolore, pupille dilatate, convulsioni, respiro rapido con singhiozzi, macchie cadaveriche che appaiono casualmente sulla pelle. È difficile per il paziente controllare il polso e determinare la pressione sanguigna. Con questa forma di shock, le previsioni sono generalmente deludenti.
Come e come aiutare in tali situazioni
Prima di intraprendere qualsiasi azione nei confronti della vittima, è importante determinare i fattori che hanno provocato la reazione del corpo e fornire assistenza elementare al paziente sul posto prima dell'arrivo di una squadra di operatori sanitari. Va ricordato che in caso di trasporto improprio di una persona che subisce uno shock o in assenza di procedure di salvataggio, possono comparire reazioni tardive del corpo, complicandone la rianimazione.
In tali situazioni, le seguenti manipolazioni devono essere eseguite in più fasi:
- Eliminare le cause iniziali che hanno provocato lo shock (fermare il sanguinamento, estinguere le cose che bruciano su una persona), nonché indebolire / eliminare gli oggetti che tengono premuti gli arti.
- Esaminare la cavità orale e i seni paranasali alla ricerca di corpi estranei che dovranno essere rimossi in seguito.
- Controlla se la vittima respira e ha il polso.
- Dare la respirazione artificiale, così come il massaggio cardiaco.
- Girare la testa della persona da un lato per evitare che la lingua cada e soffochi in caso di fuoriuscita di vomito.
- Controlla se la vittima è cosciente.
- Introdurre l'anestetico se necessario.
- A seconda delle condizioni circostanti, dovrai raffreddare la persona o riscaldarla.
Una vittima in stato di shock non dovrebbe mai essere lasciata sola. Dopo avergli fornito il primo soccorso, dovresti aspettare con lui l'arrivo della squadra dell'ambulanza per aiutare i medici a stabilire le cause della violazione per la loro corretta eliminazione. Autrice: Elena Suvorova
Il termine "shock", che significa shock, shock, shock in inglese e francese, fu accidentalmente introdotto nel 1743 da un ora oscuro traduttore inglese del libro del consulente dell'esercito Louis XV Le Dran per descrivere la condizione dei pazienti dopo una ferita da arma da fuoco. Fino ad ora, questo termine è ampiamente utilizzato per descrivere lo stato emotivo di una persona esposta a fattori mentali inaspettati ed estremamente forti senza implicare danni d'organo specifici o disturbi fisiologici. Per quanto riguarda la medicina clinica, shock significa una condizione critica, che è caratterizzata da una forte diminuzione della perfusione degli organi, dell'ipossia e dei disordini metabolici. Questa sindrome si manifesta con ipotensione arteriosa, acidosi e deterioramento rapidamente progressivo delle funzioni dei sistemi vitali del corpo. Lo shock porta rapidamente alla morte senza un trattamento adeguato.
I disturbi emodinamici acuti a breve termine possono essere un episodio transitorio in violazione del tono vascolare, causato in modo riflessivo da dolore improvviso, paura, vista di sangue, soffocamento o surriscaldamento, nonché aritmia cardiaca o ipotensione ortostatica sullo sfondo di anemia o ipotensione. Questo episodio si chiama crollo e nella maggior parte dei casi si ferma da solo senza trattamento. A causa di una transitoria diminuzione dell'afflusso di sangue al cervello, svenimento- perdita di coscienza a breve termine, spesso preceduta da sintomi neurovegetativi: debolezza muscolare, sudorazione, vertigini, nausea, oscuramento degli occhi e tinnito. Caratterizzato da pallore, bassa pressione sanguigna, bradia o tachicardia. Lo stesso può svilupparsi in persone sane a temperature ambiente elevate, poiché lo stress da calore porta a una significativa espansione dei vasi cutanei e a una diminuzione della pressione sanguigna diastolica. Disturbi emodinamici più prolungati rappresentano sempre un pericolo per il corpo.
causeshock
Lo shock si verifica quando il corpo è esposto a stimoli superforti e può svilupparsi in varie malattie, lesioni e condizioni patologiche. A seconda della causa, si distinguono emorragico, traumatico, ustione, cardiogeno, settico, anafilattico, trasfusionale, neurogeno e altri tipi di shock. Ci possono essere forme miste di shock causate da una combinazione di diversi motivi. Tenendo conto della patogenesi dei cambiamenti che si verificano nel corpo e che richiedono determinate misure terapeutiche specifiche, si distinguono quattro tipi principali di shock
Shock ipovolemico si verifica con una significativa diminuzione del BCC a causa di un massiccio sanguinamento o disidratazione e si manifesta con una forte diminuzione del ritorno venoso del sangue al cuore e una pronunciata vasocostrizione periferica.
Shock cardiogenico si verifica con una forte diminuzione della gittata cardiaca a causa della ridotta contrattilità miocardica o dei cambiamenti morfologici acuti nelle valvole del cuore e nel setto interventricolare. Si sviluppa con BCC normale e si manifesta con il trabocco del letto venoso e la circolazione polmonare.
Shock ridistributivo manifestata da vasodilatazione, diminuzione delle resistenze periferiche totali, ritorno venoso del sangue al cuore e aumento della permeabilità della parete capillare.
Shock ostruttivo extracardiaco si verifica a causa dell'improvviso verificarsi di un'ostruzione al flusso sanguigno. La gittata cardiaca diminuisce drasticamente nonostante il normale BCC, la contrattilità miocardica e il tono vascolare.
Patogenesi dello shock
Lo shock si basa su disturbi generalizzati della perfusione che portano a ipossia di organi e tessuti e disturbi del metabolismo cellulare ( Riso. 15.2.). I disturbi circolatori sistemici derivano dalla diminuzione della gittata cardiaca (CO) e dai cambiamenti nelle resistenze vascolari.
I principali disturbi fisiologici che riducono l'effettiva perfusione tissutale sono l'ipovolemia, l'insufficienza cardiaca, il disturbo del tono vascolare e l'ostruzione dei grandi vasi. Con lo sviluppo acuto di queste condizioni, nel corpo si sviluppa una "tempesta mediatrice" con l'attivazione dei sistemi neuro-umorali, il rilascio di grandi quantità di ormoni e citochine proinfiammatorie nella circolazione sistemica, che influenzano il tono vascolare, la permeabilità della parete vascolare e SV. In questo caso, la perfusione di organi e tessuti viene bruscamente interrotta. Disturbi emodinamici acuti di grado grave, indipendentemente dalle ragioni che li hanno causati, portano allo stesso tipo di quadro patologico. Si sviluppano gravi disturbi dell'emodinamica centrale, della circolazione capillare e disturbi critici della perfusione tissutale con ipossia tissutale, danno cellulare e disfunzioni d'organo.
Disturbi emodinamici
La bassa CO è una caratteristica precoce di molti tipi di shock, ad eccezione dello shock ridistributivo, in cui la gittata cardiaca può anche essere aumentata nelle fasi iniziali. La CO dipende dalla forza e dalla frequenza delle contrazioni miocardiche, dal ritorno venoso (precarico) e dalle resistenze vascolari periferiche (postcarico). Le ragioni principali della diminuzione della CO in stato di shock sono l'ipovolemia, il deterioramento della funzione di pompaggio del cuore e l'aumento del tono delle arteriole. Le caratteristiche fisiologiche dei vari tipi di shock sono presentate in scheda. 15.2.
In risposta a una diminuzione della pressione sanguigna, viene potenziata l'attivazione dei sistemi di adattamento. Innanzitutto, c'è un'attivazione riflessa del sistema nervoso simpatico, quindi viene potenziata la sintesi delle catecolamine nelle ghiandole surrenali. Il contenuto di noradrenalina nel plasma aumenta di 5-10 volte e il livello di adrenalina aumenta di 50-100 volte. Ciò migliora la funzione contrattile del miocardio, accelera l'attività cardiaca e provoca un restringimento selettivo dei letti venosi e arteriosi periferici e viscerali. La successiva attivazione del meccanismo renina-angiotensina porta ad una vasocostrizione ancora più pronunciata e al rilascio di aldosterone, che trattiene sale e acqua. Il rilascio dell'ormone antidiuretico riduce il volume dell'urina e ne aumenta la concentrazione.
In stato di shock, l'angiospasmo periferico si sviluppa in modo non uniforme ed è particolarmente pronunciato nella pelle, negli organi addominali e nei reni, dove si verifica la diminuzione più pronunciata del flusso sanguigno. La pelle pallida e fresca, osservata all'esame obiettivo, e l'intestino pallido con polso indebolito nei vasi mesenterici, visibile durante l'intervento chirurgico, sono chiari segni di angiospasmo periferico.
La vasocostrizione del cuore e del cervello si verifica in misura molto minore rispetto ad altre aree e questi organi sono forniti di sangue più a lungo di altri a causa di una forte restrizione dell'afflusso di sangue ad altri organi e tessuti. I livelli metabolici del cuore e del cervello sono alti e le loro riserve di substrati energetici sono estremamente basse, quindi questi organi non possono tollerare un'ischemia prolungata. La compensazione neuroendocrina del paziente in stato di shock è principalmente finalizzata a garantire i bisogni immediati degli organi vitali: il cervello e il cuore. Un adeguato flusso sanguigno in questi organi è mantenuto da ulteriori meccanismi di autoregolazione, purché la pressione sanguigna superi i 70 mm Hg. Arte.
Centralizzazione della circolazione sanguigna- risposta compensativa biologicamente opportuna. Nel periodo iniziale, salva la vita del paziente. È importante ricordare che le reazioni di shock iniziali sono reazioni di adattamento dell'organismo volte alla sopravvivenza in condizioni critiche, ma quando superano un certo limite, iniziano ad essere di natura patologica, portando a danni irreversibili a tessuti e organi. La centralizzazione della circolazione sanguigna, che persiste per diverse ore, insieme alla protezione del cervello e del cuore, è carica di pericolo mortale, anche se più lontano. Questo pericolo risiede nel deterioramento della microcircolazione, dell'ipossia e dei disordini metabolici negli organi e nei tessuti.
La correzione dei disturbi emodinamici centrali nello shock comprende una terapia infusionale intensiva volta ad aumentare il BCC, l'uso di farmaci che influenzano il tono vascolare e la contrattilità miocardica. La terapia infusionale massiva è controindicata solo nello shock cardiogeno.
Violazioni mmicrocircolazione e perfusione tissutale
Il microcircolo (arteriole, capillari e venule) è l'anello più importante del sistema circolatorio nella fisiopatologia dello shock. È a questo livello che i nutrienti e l'ossigeno vengono forniti agli organi e ai tessuti e i prodotti metabolici vengono rimossi.
Lo spasmo in via di sviluppo delle arteriole e degli sfinteri precapillari in stato di shock porta a una significativa diminuzione del numero di capillari funzionanti e a un rallentamento della velocità del flusso sanguigno nei capillari perfusi, all'ischemia e all'ipossia tissutale. Un ulteriore deterioramento della perfusione tissutale può essere associato a patologia capillare secondaria. L'accumulo di ioni idrogeno, lattato e altri prodotti del metabolismo anaerobico porta ad una diminuzione del tono delle arteriole e degli sfinteri precapillari e ad una diminuzione ancora maggiore della pressione arteriosa sistemica. In questo caso, le venule rimangono ristrette. In queste condizioni, i capillari traboccano di sangue e l'albumina e la parte liquida del sangue lasciano intensamente il letto vascolare attraverso i pori nelle pareti dei capillari ("sindrome da perdita capillare"). L'ispessimento del sangue nel microcircolo porta ad un aumento della viscosità del sangue, mentre aumenta l'adesione dei leucociti attivati alle cellule endoteliali, gli eritrociti e le altre cellule del sangue si uniscono e formano grandi aggregati, una sorta di tappi, che compromettono ulteriormente la microcircolazione fino allo sviluppo della sindrome dei fanghi.
I vasi bloccati dall'accumulo di corpuscoli sanguigni vengono disattivati dal flusso sanguigno. Si sviluppa la cosiddetta “deposizione patologica” che riduce ulteriormente il BCC e la sua capacità di ossigeno e diminuisce il ritorno venoso del sangue al cuore e, di conseguenza, provoca un calo di CO e un ulteriore deterioramento della perfusione tissutale. L'acidosi, inoltre, riduce la sensibilità dei vasi alle catecolamine, impedendone l'azione vasocostrittrice e porta all'atonia delle venule. Si chiude così un circolo vizioso. Un cambiamento nel rapporto del tono degli sfinteri precapillari e delle venule è considerato un fattore decisivo nello sviluppo della fase irreversibile dello shock.
Una conseguenza inevitabile del rallentamento del flusso sanguigno capillare è lo sviluppo della sindrome ipercoagulabile. Ciò porta alla formazione di trombi intravascolari disseminati, che non solo migliorano i disturbi della circolazione capillare, ma causano anche lo sviluppo di necrosi focale e insufficienza multiorgano.
Il danno ischemico ai tessuti vitali porta costantemente a un danno secondario che mantiene e aggrava lo stato di shock. Il circolo vizioso che ne risulta può essere fatale.
Le manifestazioni cliniche dei disturbi della perfusione tissutale sono pelle fredda, umida, pallida, cianotica o marmorizzata, allungamento del tempo di riempimento capillare per più di 2 secondi, gradiente di temperatura superiore a 3 ° C, oliguria (minzione inferiore a 25 ml / ora). Per determinare il tempo di riempimento dei capillari, premere per 2 secondi la punta della lamina ungueale o la punta dell'alluce o della mano e misurare il tempo durante il quale l'area pallida riprende il colore rosa. Nelle persone sane, questo accade immediatamente. In caso di deterioramento del microcircolo, lo sbiancamento persiste a lungo. Tali disturbi del microcircolo non sono specifici e sono una componente costante di qualsiasi tipo di shock e il grado della loro gravità determina la gravità e la prognosi dello shock. Anche i principi di trattamento dei disturbi del microcircolo non sono specifici e praticamente non differiscono per tutti i tipi di shock: eliminazione della vasocostrizione, emodiluizione, terapia anticoagulante, terapia antipiastrinica.
Disturbi metabolici
In condizioni di ridotta perfusione del letto capillare, non è garantito un adeguato apporto di nutrienti ai tessuti, il che porta a disordini metabolici, disfunzione delle membrane cellulari e danni alle cellule. Il metabolismo interrotto di carboidrati, proteine, grassi, l'utilizzo di normali fonti di energia - glucosio e acidi grassi - viene drasticamente soppresso. In questo caso, c'è un pronunciato catabolismo delle proteine muscolari.
I disordini metabolici più importanti in stato di shock sono la distruzione del glicogeno, una diminuzione della defosforilazione del glucosio nel citoplasma, una diminuzione della produzione di energia nei mitocondri, l'interruzione della pompa sodio-potassio della membrana cellulare con lo sviluppo di iperkaliemia, che può causare fibrillazione atriale e arresto cardiaco.
L'aumento dei livelli plasmatici di adrenalina, cortisolo, glucagone e la soppressione della secrezione di insulina che si sviluppa durante lo shock influenzano il metabolismo nella cellula modificando l'uso dei substrati e la sintesi proteica. Questi effetti includono un aumento del tasso metabolico, un aumento della glicogenolisi e della gluconeogenesi. Una diminuzione dell'utilizzo del glucosio da parte dei tessuti è quasi sempre accompagnata da iperglicemia. A sua volta, l'iperglicemia può portare a una diminuzione del trasporto di ossigeno, all'interruzione dell'omeostasi dell'acqua-elettrolita e alla glicosilazione delle molecole proteiche con una diminuzione della loro attività funzionale. Un significativo effetto dannoso aggiuntivo dell'iperglicemia da stress nello shock contribuisce all'approfondimento della disfunzione d'organo e richiede una correzione tempestiva con il mantenimento della normoglicemia.
Sullo sfondo dell'aumento dell'ipossia, i processi di ossidazione nei tessuti vengono interrotti, il loro metabolismo procede lungo il percorso anaerobico. Allo stesso tempo, si formano prodotti metabolici acidi in quantità significative e si sviluppa acidosi metabolica. Il criterio per la disfunzione metabolica è il pH del sangue inferiore a 7,3, un deficit di basi superiore a 5,0 mEq/L e un aumento della concentrazione di acido lattico nel sangue superiore a 2 mEq/L.
Un ruolo importante nella patogenesi dello shock appartiene alla violazione del metabolismo del calcio, che penetra intensamente nel citoplasma delle cellule. Livelli elevati di calcio intracellulare aumentano la risposta infiammatoria, portando a un'intensa sintesi di potenti mediatori della risposta infiammatoria sistemica (SVR). I mediatori dell'infiammazione svolgono un ruolo significativo nelle manifestazioni cliniche e nella progressione dello shock, nonché nello sviluppo delle complicanze successive. L'aumento della produzione e della distribuzione sistemica di questi mediatori può portare a danni cellulari irreversibili e ad alta mortalità. L'uso di calcio-antagonisti aumenta il tasso di sopravvivenza dei pazienti con vari tipi di shock.
L'azione delle citochine pro-infiammatorie è accompagnata dal rilascio di enzimi lisosomiali e radicali liberi del perossido, che causano ulteriori danni - "sindrome delle cellule malate". L'iperglicemia e un aumento della concentrazione di prodotti solubili di glicolisi, lipolisi e proteolisi portano allo sviluppo dell'iperosmolarità del liquido interstiziale, che provoca la transizione del liquido intracellulare nello spazio interstiziale, la disidratazione delle cellule e un ulteriore deterioramento del loro funzionamento. Pertanto, la disfunzione della membrana cellulare può rappresentare un percorso fisiopatologico comune per varie cause di shock. E sebbene i meccanismi esatti della disfunzione della membrana cellulare non siano chiari, il modo migliore per eliminare i disordini metabolici e prevenire l'irreversibilità dello shock è ripristinare rapidamente il BCC.
I mediatori infiammatori prodotti durante il danno cellulare contribuiscono a un'ulteriore compromissione della perfusione, che danneggia ulteriormente le cellule all'interno del microcircolo. Pertanto, un circolo vizioso si chiude: una violazione della perfusione porta a danni cellulari con lo sviluppo di una sindrome da risposta infiammatoria sistemica, che a sua volta compromette ulteriormente la perfusione tissutale e il metabolismo cellulare. Quando queste risposte sistemiche eccessive persistono per lungo tempo, diventano autonome e non possono essere invertite, si sviluppa la sindrome da insufficienza multiorgano.
Nello sviluppo di questi cambiamenti, il ruolo principale spetta al fattore di necrosi tumorale (TNF), interleuchine (IL-1, IL-6, IL-8), fattore di attivazione piastrinica (PAF), leucotrieni (B4, C4, D4, E4), trombossano A2, prostaglandine (E2, E12), prostaciclina, gamma interferone. L'azione simultanea e multidirezionale dei fattori eziologici e dei mediatori attivati nello shock porta a danni all'endotelio, alterazione del tono vascolare, permeabilità vascolare e disfunzione d'organo.
La persistenza o la progressione dello shock può derivare da un difetto di perfusione in corso o da un danno cellulare, o da una combinazione di entrambi. Poiché l'ossigeno è il substrato vitale più labile, la sua erogazione inadeguata da parte del sistema circolatorio costituisce la base della patogenesi dello shock e il tempestivo ripristino della perfusione e dell'ossigenazione dei tessuti spesso interrompe completamente la progressione dello shock.
Pertanto, la patogenesi dello shock si basa su disordini profondi e progressivi dell'emodinamica, del trasporto dell'ossigeno, della regolazione umorale e del metabolismo. L'interrelazione di questi disturbi può portare alla formazione di un circolo vizioso con un completo esaurimento delle capacità adattative dell'organismo. La prevenzione dello sviluppo di questo circolo vizioso e il ripristino dei meccanismi di autoregolazione del corpo sono il compito principale della terapia intensiva dei pazienti con shock.
Stadi d'urto
Lo shock è un processo dinamico, a partire dal momento dell'azione del fattore di aggressione, che porta a disturbi circolatori sistemici e con la progressione delle violazioni, che termina con un danno d'organo irreversibile e la morte del paziente. L'efficacia dei meccanismi compensatori, il grado delle manifestazioni cliniche e la reversibilità dei cambiamenti risultanti consentono di distinguere una serie di fasi successive nello sviluppo dello shock.
Stadio Preshoka
Lo shock è solitamente preceduto da una moderata diminuzione della pressione sanguigna sistolica, non superiore a 20 mm Hg. Arte. dalla norma (o 40 mm Hg. se il paziente ha ipertensione arteriosa), che stimola i barocettori del seno carotideo e dell'arco aortico e attiva i meccanismi compensatori del sistema circolatorio. La perfusione tissutale non è significativamente influenzata e il metabolismo cellulare rimane aerobico. Se allo stesso tempo cessa l'influenza del fattore di aggressione, i meccanismi compensatori possono ripristinare l'omeostasi senza alcuna misura terapeutica.
Fase iniziale (reversibile) dello shock
Questa fase di shock è caratterizzata da una diminuzione del livello della pressione sanguigna sistolica inferiore a 90 mm Hg. Arte. , grave tachicardia, mancanza di respiro, oliguria e pelle fredda e umida. In questa fase, i meccanismi compensatori da soli non sono in grado di mantenere un SV adeguato e soddisfare le esigenze di ossigeno di organi e tessuti. Il metabolismo diventa anaerobico, si sviluppa acidosi tissutale e compaiono segni di disfunzione d'organo. Un criterio importante per questa fase di shock è la reversibilità dei conseguenti cambiamenti nell'emodinamica, nel metabolismo e nelle funzioni degli organi e una regressione abbastanza rapida dei disturbi sviluppati sotto l'influenza di una terapia adeguata.
Stadio intermedio (progressivo) di shock
Questa è un'emergenza pericolosa per la vita con pressione sanguigna sistolica inferiore a 80 mm Hg. Arte. e disfunzioni d'organo gravi ma reversibili con un trattamento intensivo immediato. Ciò richiede la ventilazione polmonare artificiale (ALV) e l'uso di farmaci adrenergici per correggere i disturbi emodinamici ed eliminare l'ipossia d'organo. L'ipotensione profonda prolungata porta all'ipossia cellulare generalizzata e all'interruzione critica dei processi biochimici, che diventano rapidamente irreversibili. È dall'efficacia della terapia durante la prima cosiddetta "Ora d'oro" la vita del paziente dipende.
Stadio refrattario (irreversibile) dello shock
Questa fase è caratterizzata da disturbi pronunciati dell'emodinamica centrale e periferica, morte cellulare e insufficienza multiorgano. La terapia intensiva è inefficace, anche se le cause eziologiche vengono eliminate e la pressione arteriosa viene momentaneamente aumentata. La progressiva disfunzione multiorgano di solito porta a danni permanenti agli organi e alla morte.
Test diagnostici e monitoraggio in stato di shock
Lo shock non lascia tempo per la raccolta ordinata delle informazioni e il chiarimento della diagnosi prima di iniziare il trattamento. La pressione sanguigna sistolica in stato di shock è più spesso inferiore a 80 mm Hg. Arte. , ma lo shock viene talvolta diagnosticato con una pressione sanguigna sistolica più elevata, se ci sono segni clinici di un forte deterioramento della perfusione degli organi: pelle fredda ricoperta di sudore appiccicoso, un cambiamento dello stato mentale da confusione a coma, oligo o anuria e insufficiente riempimento dei capillari cutanei. La respirazione rapida in stato di shock di solito indica ipossia, acidosi metabolica e ipertermia e l'ipoventilazione indica depressione del centro respiratorio o aumento della pressione intracranica.
I test diagnostici per lo shock includono anche un esame del sangue clinico, determinazione di elettroliti, creatinina, indicatori di coagulazione del sangue, gruppo sanguigno e fattore Rh, emogasanalisi arteriosa, elettrocardiografia, ecocardiografia, radiografia del torace. Solo i dati raccolti con cura e interpretati correttamente aiutano a prendere le decisioni giuste.
Il monitoraggio è un sistema di monitoraggio delle funzioni vitali dell'organismo, in grado di notificare rapidamente il verificarsi di situazioni minacciose. Ciò consente di iniziare il trattamento in tempo e prevenire lo sviluppo di complicanze. Per monitorare l'efficacia del trattamento d'urto, viene mostrato il monitoraggio dei parametri emodinamici, del cuore, dei polmoni e dell'attività renale. Il numero di parametri monitorati dovrebbe essere ragionevole. Il monitoraggio dello shock deve necessariamente includere la registrazione dei seguenti indicatori:
- BP, utilizzando la misurazione intra-arteriosa se necessario;
- frequenza cardiaca (FC);
- l'intensità e la profondità della respirazione;
- pressione venosa centrale (CVP);
- pressione di incuneamento dell'arteria polmonare (PAWP) in caso di shock grave e causa poco chiara dello shock;
- diuresi;
- emogasanalisi ed elettroliti plasmatici.
Per una valutazione approssimativa della gravità dello shock, è possibile calcolare l'indice Algover-Burri o, come viene anche chiamato, l'indice di shock: il rapporto tra la frequenza del polso in 1 minuto e il valore della pressione sanguigna sistolica. E più alto è questo indicatore, maggiore è il pericolo che minaccia la vita del paziente. L'impossibilità di monitorare uno qualsiasi dei parametri elencati complica la scelta corretta della terapia e aumenta il rischio di complicanze iatrogene.
Pressione venosa centrale
Un CVP basso è un criterio indiretto per l'ipovolemia assoluta o indiretta e il suo aumento è superiore a 12 cm di acqua. Arte. indica insufficienza cardiaca. La misurazione della CVP con una valutazione della sua risposta a un basso carico di liquidi aiuta a selezionare un regime di fluidoterapia e a determinare l'adeguatezza del supporto inotropo. Inizialmente, al paziente viene somministrata una dose di liquido di prova entro 10 minuti: 200 ml con una CVP iniziale inferiore a 8 cm acq. Arte. ; 100 ml - con CVP nel range di 8-10 cm acq. Arte. ; 50 ml - con CVP superiore a 10 cm acq. Arte. La reazione viene valutata in base alla regola “5 e 2 cm aq. Arte. »: Se il CVP è aumentato di oltre 5 cm, l'infusione viene interrotta e viene decisa la questione dell'opportunità del supporto inotropo, poiché tale aumento indica un'interruzione del meccanismo di regolazione della contrattilità di Frank-Starling e indica insufficienza cardiaca. Se l'aumento di CVP è inferiore a 2 cm di acqua. Arte. - questo indica ipovolemia ed è un'indicazione per un'ulteriore terapia infusionale intensiva senza necessità di terapia inotropa. Aumento del CVP nel range di 2 e 5 cm ac. Arte. richiede un'ulteriore terapia infusionale sotto il controllo dei parametri emodinamici.
Va sottolineato che la CVP è un indicatore inaffidabile della funzione ventricolare sinistra, poiché dipende principalmente dallo stato del ventricolo destro, che può differire dallo stato del sinistro. Informazioni più obiettive e ampie sullo stato del cuore e dei polmoni sono fornite dal monitoraggio emodinamico nella circolazione polmonare. Senza il suo utilizzo, in più di un terzo dei casi, il profilo emodinamico di un paziente con shock viene valutato in modo errato. L'indicazione principale per il cateterismo dell'arteria polmonare in stato di shock è un aumento della CVP durante la terapia infusionale. La risposta all'introduzione di un piccolo volume di fluido durante il monitoraggio dell'emodinamica nella circolazione polmonare viene valutata secondo la regola “7 e 3 mm Hg. Arte. ".
Monitoraggio dell'emodinamica nel circolo polmonare
Il monitoraggio invasivo della circolazione sanguigna nel circolo polmonare viene eseguito utilizzando un catetere installato nell'arteria polmonare. A tale scopo viene solitamente utilizzato un catetere con punta a palloncino galleggiante (Swan-Gans), che consente di misurare una serie di parametri:
- pressione nell'atrio destro, ventricolo destro, arteria polmonare e PAWP, che riflette la pressione di riempimento del ventricolo sinistro;
- SW per termodiluizione;
- pressione parziale di ossigeno e saturazione dell'emoglobina con ossigeno nel sangue venoso misto.
La determinazione di questi parametri amplia notevolmente le possibilità di monitoraggio e valutazione dell'efficacia della terapia emodinamica. Gli indicatori risultanti consentono:
- differenziare l'edema polmonare cardiogeno e non cardiogeno, identificare l'embolia polmonare e la rottura dei lembi della valvola mitrale;
- valutare il BCC e lo stato del sistema cardiovascolare nei casi in cui il trattamento empirico sia inefficace o comporti un aumento del rischio;
- regolare il volume e la velocità di infusione di liquidi, le dosi di farmaci inotropi e vasodilatatori, il valore della pressione positiva di fine espirazione durante la ventilazione meccanica.
Una diminuzione della saturazione di ossigeno venoso misto è sempre un indicatore precoce di una gittata cardiaca inadeguata.
Diuresi
Una diminuzione della produzione di urina è il primo segno oggettivo di una diminuzione del BCC. I pazienti con shock devono avere un catetere urinario a permanenza installato per controllare il volume e la velocità della minzione. Quando si esegue la terapia infusionale, la diuresi deve essere di almeno 50 ml / ora. Con l'intossicazione alcolica, lo shock può procedere senza oliguria, poiché l'etanolo inibisce la secrezione dell'ormone antidiuretico.