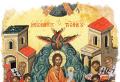Sulla necessità di rispettare i canoni della chiesa nella pittura di icone. Perché i canonici nella chiesa non invecchiano
Quali canoni esistono nella Chiesa? Cosa regolano? I canoni servono per privare una persona della libertà o, al contrario, per aiutarla? Perché c'è un tale formalismo giuridico nella Chiesa? È davvero impossibile salvarsi senza di essa?
L'arciprete Dmitry Pashkov, docente nel dipartimento di storia generale e della Chiesa russa e diritto canonico, PSTGU, ha risposto a queste e ad altre domande specialmente per "Thomas".
Cosa sono i canoni della chiesa e perché sono necessari?
La parola "canone" è di origine greca, ed è tradotta come "regola", "norma". I canoni sono generalmente regole di condotta vincolanti accettate nella Chiesa. Pertanto, possiamo dire che il canone nella Chiesa nel suo contenuto e nel suo significato è lo stesso della legge nello Stato.La necessità di canoni ecclesiastici è generalmente chiara. Trovandoci in qualsiasi società, dobbiamo attenerci a determinate regole di comportamento adottate in essa. Così è nella Chiesa. Divenuto suo membro, una persona deve obbedire alle norme - canoni - operanti nei suoi limiti.
Si può ricorrere a una simile analogia. Quando miglioriamo la nostra salute in ospedale, ci troviamo di fronte a determinate regole a cui, che ci piaccia o no, dobbiamo obbedire. E queste regole ospedaliere possono a prima vista sembrare ridondanti o addirittura assurde finché non proviamo ad approfondirle.
Allo stesso tempo, nella Chiesa non può esserci formalismo canonico. Ogni persona è individuale, e quindi un confessore svolge un ruolo significativo nella sua vita ecclesiale. Conoscendo i punti di forza e di debolezza della persona che si rivolge a lui, il sacerdote, basandosi sulla norma canonica, può agire con assoluta libertà. Dopotutto, non dobbiamo dimenticare che la serie principale di canoni si è formata molto tempo fa, nel primo millennio, e molti canoni non possono essere applicati letteralmente al momento attuale. Il sacerdote, quindi, ha molto spazio di “manovra” (lo suggeriscono i canoni stessi, lasciando al sacerdote, ad esempio, il diritto di abbreviare o, al contrario, di prolungare le penitenze), e questo è molto importante quando si tratta di ad una materia così complessa ed estremamente delicata come la pastorizia.

Ma è davvero impossibile salvarsi senza questo formalismo?
No, il punto qui non è nel formalismo stesso, ma in noi stessi. Poiché anche dopo il battesimo rimaniamo esseri imperfetti, pigri ed egocentrici, abbiamo bisogno di essere condotti a un ordine di vita pia che corrisponda alla nostra fede.Naturalmente, la nostra comunicazione con Dio non è soggetta a regolamentazione normativa, ad esempio, come una persona prega a casa: sia per molto tempo, per poco tempo, con o senza lampada, guardando un'icona o chiudendo gli occhi, mentire o stare in piedi: sono affari suoi e dipendono esclusivamente da Come migliora a pregare? Ma se un cristiano viene a un raduno di credenti, alla Chiesa, dove ce ne sono già molti come lui e ognuno ha le proprie opinioni, interessi, alcune preferenze, non ci sono già regole precise che portino tutta questa diversità a una sorta di corretta uniformità. , non abbastanza.
Cioè, norme generalmente vincolanti, canoni, sono necessarie laddove una società appare, dove già è tenuta a prescrivere determinati diritti e doveri ai suoi membri per evitare in essa il caos e il disordine.
Inoltre, i canoni servono a mantenere quell'immagine originaria della Chiesa, sorta nel giorno di Pentecoste, affinché rimanga immutata in ogni stato, cultura, formazione sociale. La Chiesa è sempre e sempre la stessa: nel I secolo, e nell'era dei Concili ecumenici, e alla fine di Bisanzio, e nel regno di Mosca, e ora. E i canoni custodiscono a se stessa questa identità della Chiesa attraverso tutti i secoli.

Cristo nel Vangelo ha detto qualcosa sulla necessità di seguire alcune regole?
Certo che l'ha fatto. Il Signore stabilisce alcune norme della vita cristiana direttamente nel Vangelo. Ad esempio, ci sono dei canoni che regolano il sacramento del Battesimo. E nel Vangelo, Cristo è il primo a stabilire questa norma: Andate dunque, ammaestrate tutte le nazioni, battezzandole nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro ad osservare tutto ciò che io ho comandato voi; ed ecco, io sono con te tutti i giorni fino alla fine dei secoli. Amen» (Mt 28,19-20).Qui troviamo la formula del battesimo - "nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo" - che viene pronunciata oggi dal sacerdote durante la celebrazione del sacramento. Inoltre, si dice che prima devi insegnare e solo dopo battezzare. E da qui, ad esempio, ha origine la pratica dei cosiddetti catecumeni prima del battesimo, quando un sacerdote o un catechista deve spiegare in dettaglio a una persona che vuole entrare nella Chiesa i fondamenti della fede e della pietà cristiana.
Inoltre, il Signore Gesù Cristo stabilì la monogamia come norma (Matteo 19:4–9). È sulla base delle sue parole che la Chiesa ha sviluppato il suo insegnamento sul sacramento del matrimonio. Tuttavia, ha un po' addolcito la “severità” del Vangelo, dove, come è noto, si dice: chi ripudia la moglie non per adulterio e ne sposa un'altra, commette adulterio; e chi sposa una divorziata commette adulterio (Mt 19,9). La Chiesa, condiscendendo alla debolezza umana e rendendosi conto che non tutti possono sopportare il peso della solitudine, permette in determinate circostanze di contrarre un secondo e perfino un terzo matrimonio.
Tuttavia, ci sono altri canoni che non sono presi direttamente dal Nuovo Testamento. La Chiesa, guidata dallo Spirito Santo, agisce come successore del Cristo Legislatore, ampliando, chiarendo e aggiornando le sue norme giuridiche. Allo stesso tempo, lo ripeto, proprio questa precisazione e, in generale, tutta l'attività legislativa della Chiesa si basa sui principi dati dal Salvatore nel Vangelo.
Quali sono i canoni? E cosa regolano?
Ci sono molti canonici ecclesiastici. Possono essere divisi in diversi grandi gruppi. Ci sono, ad esempio, dei canoni che regolano l'ordine amministrativo della Chiesa. Esistono canoni "disciplinari" che regolano la vita dei credenti e il ministero dei chierici.Ci sono canoni dogmatici che condannano certe eresie. Ci sono canoni che snelliscono l'amministrazione territoriale della Chiesa. Questi canoni stabiliscono i poteri dei più alti vescovi - metropoliti, patriarchi, determinano la regolarità di tenere i Concili, e così via.
Tutti i canoni in tutta la loro diversità sono stati formulati nel primo millennio della storia della Chiesa, e alcuni di essi sono alquanto superati. Ma la Chiesa onora ancora questi antichi canoni e li studia con molta attenzione, perché l'epoca unica dei Concili ecumenici è una specie di standard, un modello per tutti i secoli successivi.
Oggi, da queste antiche norme, estraiamo, se non regole dirette di condotta, almeno il loro spirito, principi, per stabilire in forma aggiornata tali norme che rispondano alle esigenze odierne.

È chiaro che se un cittadino viola la legge, sarà punito per questo con una decisione del tribunale. E nella Chiesa? Prevede sanzioni per la violazione di questo o quel canone della chiesa?
Se parliamo di diritto ecclesiastico, che regola la pia vita di un cristiano, le sanzioni canoniche, prima di tutto, privano il colpevole della cosa più importante: la comunione con Cristo nel sacramento della Comunione. Non si tratta di una misura di punizione, non di una punizione nel senso comune della parola, ma di una misura “terapeutica” volta a curare l'una o l'altra malattia spirituale. Tuttavia, qui c'è anche un avvertimento molto importante e significativo: la decisione finale sull'applicazione di questa o quella punizione ecclesiastica è presa dal confessore o, se prendiamo un livello superiore, dal vescovo. Inoltre, ogni caso viene considerato separatamente e, a seconda della situazione specifica, viene presa l'una o l'altra decisione.Pertanto, i canoni della chiesa sono più simili a medicine che a leggi. La legge opera in gran parte formalmente, i rami legislativo ed esecutivo devono essere indipendenti.
In questo senso, il garante (vescovo o sacerdote) dovrebbe agire allo stesso modo di un medico buono e attento. Dopotutto, il medico non tormenterà il suo paziente con nuovi farmaci se i farmaci prescritti hanno già avuto un effetto benefico! Ma se il trattamento non porta risultati positivi, il medico inizia a usare altri farmaci fino a quando il paziente non si riprende. E se in medicina l'indicatore del successo della cura è la guarigione del paziente, allora per il vescovo e il confessore tale prova sarà il sincero pentimento del credente.
Per questo, infatti, esistono le sanzioni ecclesiastiche: predisporre una persona al pentimento e alla correzione, per aiutarla nella crescita spirituale, affinché un credente caduto nella penitenza subisca uno sconvolgimento interiore e si penta. In modo che si renda conto che il peccato che ha commesso lo priva della comunione con Dio e cerca di restaurarlo di nuovo.

Canoni della Chiesa da qualche parte riparati? Ci sono collezioni in cui sono classificate e presentate?
Certo. La Chiesa iniziò a codificare i suoi diritti già alla fine del IV secolo. Fu in quest'epoca, dopo la fine della persecuzione dei cristiani, che apparve un numero enorme di canoni, che doveva essere in qualche modo sistematizzato e razionalizzato. Così sono comparse le prime raccolte canoniche. Alcuni di loro sono stati organizzati cronologicamente, altri - tematicamente, secondo le materie di regolamentazione legale. Nel VI secolo apparvero raccolte originali a contenuto misto, i cosiddetti "nomocanons" (dalle parole greche "nomos" - diritto imperiale, "canonico" - regola ecclesiastica). Comprendeva sia i canoni adottati dalla Chiesa che le leggi degli imperatori riguardanti la Chiesa.Ci sono anche le cosiddette regole apostoliche. Non sono direttamente imparentati con i discepoli di Cristo stessi e molto probabilmente hanno ricevuto un tale nome a causa del loro significato e autorità speciali. Questi canoni ebbero origine in Siria nel 4° secolo.
La più famosa raccolta di canoni antichi si chiama Libro delle Regole. Comprendeva le norme "apostoliche", i canoni adottati nei Concili ecumenici, i canoni di alcuni Concili locali, e le autorevoli opinioni dei santi padri su vari problemi della vita ecclesiale.

Un laico ha bisogno di conoscere le norme del diritto ecclesiastico?
Penso sia necessario. La conoscenza dei canoni aiuta a capire quali diritti e doveri ha. Inoltre, i canoni ecclesiastici sono molto utili anche nella vita di tutti i giorni.Ad esempio, la vita di un neonato è in bilico e ha bisogno di essere battezzato urgentemente. La madre stessa può farlo in maternità, e se può (e infatti lo è), come può farlo correttamente affinché il sacramento del Battesimo avvenga davvero? Oppure sei stato invitato a fare il padrino. Cosa significa questo da un punto di vista canonico, quali responsabilità hai? Molte domande difficili sono legate al sacramento del matrimonio. Ad esempio, è possibile, da un punto di vista canonico, sposare un non ortodosso o un non ortodosso?

Che cosa, allora, dovrebbe leggere un profano? Dove può conoscere i suoi diritti e doveri nella Chiesa?
Negli ultimi anni è stato più volte ripubblicato l'eccellente corso di lezioni di diritto canonico dell'arciprete Vladislav Tsypin. Se parliamo di conoscere le fonti, dovresti iniziare studiando il "Libro delle regole" già menzionato sopra. Gli atti normativi moderni della nostra Chiesa locale (ad esempio, la sua Carta e varie disposizioni private) sono pubblicati sul suo sito web ufficiale patriarchia.ru e cinque anni fa la Casa editrice del Patriarcato di Mosca ha iniziato a pubblicare una raccolta in più volumi di documenti del Patriarcato di Mosca Chiesa Ortodossa Russa.Canone - Greco. κανών, letteralmente: un palo dritto, qualsiasi misura che determini la direzione diretta, la livella, il righello. Nell'antica Grecia, questa parola era chiamata un insieme di disposizioni o regole di base nella specialità, che aveva un carattere assiomatico o dogmatico.
Tra i giuristi greci antichi, κανών significava la stessa cosa dei giuristi romani regula juris - una disposizione breve, una tesi estratta dalla legge vigente e che rappresentava uno schema per risolvere una o l'altra questione giuridica particolare.
canonico della chiesa- queste sono le regole nel campo della dogmatica di una singola chiesa, delle azioni di culto, dell'organizzazione della chiesa stessa, elevata a legge.
Le chiese cristiane tendono a seguire la tassonomia dei libri dell'Antico Testamento del III secolo aC, la traduzione greca delle Sacre Scritture "Settanta".
Di norma, per i libri dell'Antico Testamento, la tradizione cristiana accettava semplicemente la collezione di libri ebraica, che erano considerate fonti autorevoli per l'uso nella società. Ma poiché il canone ebraico non è stato stabilito ufficialmente, molti dei libri usati con riferimento all'ebraismo non hanno raggiunto lo status di santità.
Per definizione generale, un canone è un insieme di affermazioni dogmatiche.
Canone biblico- una raccolta di libri selezionati che sono considerati insegnamenti indiscutibili, alla cui creazione ha partecipato Dio stesso.
Il canone del Nuovo Testamento prese forma tra il I e il IV secolo. All'inizio della chiesa cristiana, rimase aperto a nuovi scritti. Molti di loro furono ampiamente diffusi e letti nelle parti occidentali e orientali della Chiesa. Nel tempo, diverse comunità cristiane sono arrivate a riconoscerne alcune autorevoli.
Durante il cristianesimo, il nome "canonico", anche nell'era degli apostoli (Gal 6, 16; Fil 3, 16), fu adottato da quelle regole ecclesiastiche che provenivano dallo stesso Gesù Cristo e dagli apostoli, o sono stati istituiti dalla Chiesa successivamente, o, sono stati istituiti, sia pure dallo Stato, ma in relazione alla competenza della Chiesa stessa in base ai comandamenti divini. Avendo la forma di definizioni positive e portanti una sanzione ecclesiastica esterna, queste regole erano dette canoniche, in contrasto con quei decreti sulla chiesa, i quali, procedendo dal potere statale, sono protetti dalla sua approvazione ed eseguiti dal suo potere.
I canoni sono più potenti delle leggi, poiché le leggi furono emanate solo da imperatori greco-romani e canonici - dai santi padri della chiesa, con l'approvazione degli imperatori, in conseguenza dei quali i canonici hanno l'autorità di entrambe le autorità - chiesa e stato. In un senso più ampio, i canoni sono tutti i decreti della chiesa, sia relativi al dogma che riguardanti la struttura della chiesa, le sue istituzioni, la disciplina e la vita religiosa della società ecclesiale.
Tipi di Canon
Dopo che la chiesa ha iniziato a esprimere la sua dottrina nei simboli generali della chiesa, la parola canone ha ricevuto un significato più speciale: i decreti del Concilio ecumenico, relativi alla struttura della chiesa, alla sua gestione, alle istituzioni, alla disciplina e alla vita.
Le definizioni dei concili ecumenici del VI e VII secolo. i canoni ecclesiastici sono riconosciuti come "irrevocabili", "indistruttibili" e "incrollabili"; ma queste definizioni, per loro stessa natura, sono soggette a limitazioni ed eccezioni.
I canonisti dotti distinguono tra i canoni in vigore e quelli che hanno cessato di essere validi.
I canoni irrevocabilmente validi includono i canoni universali riguardanti i soggetti della fede, nonché i fondamenti essenziali della struttura e della disciplina generale della Chiesa. Un canone ecclesiastico, condizionato dalle circostanze del tempo, sospende l'azione di un canone più antico, in cui non sono d'accordo tra loro, e a sua volta può essere cancellato allo scadere delle circostanze che lo hanno causato. A volte un canone successivo non è considerato un'abrogazione di un canone più vecchio sullo stesso argomento, ma solo una delucidazione di esso. La tradizione orale acquista carattere canonico solo dopo essere stata formalizzata in una decisione di un concilio.
I canoni dei concili ecumenici correggono e annullano le decisioni dei consigli locali. Si riconosce che altri canoni hanno perso la loro forza a causa del mutato ordine della vita ecclesiastica, nonché in presenza di leggi statali che non sono d'accordo con loro. Dalle risoluzioni dei concili si stabiliva il nome dei canonici dietro le regole dei Concili ecumenici, le regole dei nove consigli locali, quelli apostolici, e le regole estratte dalle opere dei tredici padri della chiesa.
Il "canone ecclesiastico" della chiesa ecumenica è considerato dalla maggior parte dei canonisti completato nel X secolo, con la pubblicazione del nomocanon di Fozio.
Tutti i canoni della Chiesa Ortodossa 762.
Il primo codice dei canoni ecclesiastici in uso dai tempi dell'imperatore Costantino il Grande fu la raccolta delle regole del Concilio di Nicea, integrate dalle regole dei consigli locali.
La codificazione delle leggi statali dell'impero greco-romano sotto Giustiniano provocò un lavoro simile da parte della Chiesa in relazione sia ai propri canoni sia in relazione alle leggi statali in materia ecclesiastica. È qui che hanno avuto origine i cosiddetti nomocanoni. Canoni attuali
Attualmente, Pidalion (πηδάλιον - il volante su una nave), compilato dal greco. scienziati nel 1793-1800. In allegato al testo dei canoni: interpretazioni di Zonara, Aristinus e Balsamon; Le interpretazioni di questi tre interpreti hanno sempre goduto di autorità nelle Chiese ortodosse greca e russa. E questo non solo per il bene della loro dignità interiore, ma anche per la loro approvazione da parte della massima autorità ecclesiastica.Oltre alle opere degli interpreti, sono allegate le regole di Giovanni il Digiuno, Niceforo e Nicola dei Patriarchi al testo di Pidalion. Costantinopoli e diversi articoli relativi al campo del diritto matrimoniale e delle formalità del lavoro d'ufficio ecclesiastico.
La Chiesa ortodossa russa, che all'inizio adottò la legge ecclesiastica di Bisanzio insieme alla sua dottrina nella forma del Nomocanon (che in Russia ricevette il nome di Pilot's Book), non ha un codice completo di leggi e regolamenti ecclesiastici in vigore oggi. Esiste solo una raccolta completa, in ordine cronologico, dei canoni dell'antica chiesa ecumenica sotto il titolo del libro delle regole, pubblicato a nome del Santo Sinodo.
Nel 1873-1878. La Società di Mosca per gli amanti dell'illuminazione spirituale ha realizzato un'edizione scientifica di queste regole: il loro originale greco e la traduzione slava in parallelo con le interpretazioni di Zonara, Aristinus e Balsamon.
La "Raccolta dei decreti sul Dipartimento del Santo Sinodo" cronologica fu avviata dalla Commissione archivistica sinodale (dal 1869 al 1894 furono pubblicati sette volumi, che coprono il periodo dal 1721 al 1733 compreso) La necessità dei canonici ecclesiastici
Ogni società organizzata presuppone alcuni principi della sua organizzazione, ai quali tutti i suoi membri devono obbedire. I canoni sono le regole con cui i membri della Chiesa devono servire Dio e organizzare la propria vita in modo da mantenere costantemente questo stato di servizio, questa vita in Dio.
Come tutte le regole, i canoni sono progettati non per complicare la vita di un cristiano, ma, al contrario, per aiutarlo a navigare nella complessa realtà ecclesiale e nella vita in generale. Se non ci fossero canoni, allora la vita della Chiesa sarebbe un caos completo, e in generale l'esistenza stessa della Chiesa come un'unica organizzazione sulla terra sarebbe impossibile. Allo stesso tempo, è molto importante sottolineare che, in netto contrasto con i dogmi, che sono immutabili, poiché Dio stesso è immutabile e non può avere alternative, tutti i canoni sono stati adottati secondo il fattore umano, poiché sono orientato verso una persona - un essere debole e incline al cambiamento.
Inoltre, la Chiesa stessa è primaria in relazione ai suoi canoni, e quindi sono del tutto possibili casi in cui la Chiesa modifica i propri canoni, il che è del tutto impossibile in relazione ai dogmi. Si può dire che se i dogmi ci dicono cosa esiste veramente, allora i canoni ci dicono quanto sia conveniente per la Chiesa esistere nelle circostanze proposte del mondo terreno e decaduto.
Bibliografia
Alexander A. Sokolovsky
Articolo tratto dall'enciclopedia "Albero": sito
Canone(Greco κανών, letteralmente - un polo dritto - qualsiasi misura che determini la direzione diretta: livella, righello, quadrato).
Nell'antica Grecia, compositori, grammatici, filosofi, medici chiamavano questa parola un insieme di disposizioni o regole di base nella loro specialità che avevano un carattere assiomatico o dogmatico (quella che più tardi, nell'era della scolastica, fu chiamata summa, ad esempio summa philosophiae) . Tra i giuristi greci antichi, κανών significava la stessa cosa dei giuristi romani regula juris - una disposizione breve, una tesi estratta dalla legge vigente e che rappresentava uno schema per risolvere una o l'altra questione giuridica particolare.
Nel nostro tempo, alla parola canone sono stati assegnati diversi significati.
- Regola della Chiesa o insieme di regole (vedi sotto).
- Canone sacro o biblico - la composizione di quei libri sacri dell'Antico ("canone dell'Antico Testamento") e del Nuovo ("canone del Nuovo Testamento"), che sono riconosciuti dalla chiesa come divinamente ispirati e servono come fonti primarie e norme di fede .
- Elenco o catalogo di ecclesiastici e ecclesiastici di una nota diocesi, compilato per le esigenze dell'amministrazione diocesana. Le persone incluse in questo elenco erano dette canoniche.
- Uno dei generi di innografia della chiesa, vedi Canon (canto) .
Al tempo del cristianesimo, il nome " canone«innanzitutto, nell'epoca degli apostoli (Galat. VI, 16; Filippo III, 16), fu assimilato da quelle regole ecclesiastiche che provenivano dallo stesso Gesù Cristo e dagli apostoli, o furono stabilite dalla Chiesa in seguito , o, infine, furono stabilite sebbene e lo stato, ma in relazione alla competenza della chiesa propriamente detta in base ai comandamenti divini. Avendo la forma di definizioni positive e recanti sanzione ecclesiastica esterna, queste regole erano dette canoniche, in contrasto con quelle decreti sulla chiesa, che, procedendo dal potere statale, sono protetti dalla sua sanzione e sono attuati Il cognome nella letteratura giuridica greco-romana è assimilato al nome della legge - νόμος, comune a tutte le leggi dello stato.
Secondo i canonisti bizantini (Balsamon, Vlastar e altri), così come alcuni degli ultimi studiosi, canoni hanno più forza delle leggi, poiché il messaggio è stato pubblicato solo dagli imperatori greco-romani e dai canonici - dai santi padri della chiesa, con l'approvazione degli imperatori, in conseguenza dei quali i canonici hanno l'autorità di entrambi autorità - Chiesa e stato.
In senso lato canoni sono chiamati tutti i decreti della chiesa, sia relativi alla dottrina che riguardanti la struttura della chiesa, le sue istituzioni, la disciplina e la vita religiosa della società ecclesiastica, e talvolta le creazioni dei singoli padri della chiesa (ad esempio, Κανών έκκλησιαστικός di Clemente Alessandrino ).
Dopo che la chiesa iniziò ad esprimere il suo dogma nei simboli generali della chiesa, la parola canone ricevettero un significato più speciale: le decisioni del concilio ecumenico, relative alla struttura della chiesa, alla sua gestione, alle istituzioni, alla disciplina e alla vita. In questo senso, la parola canone è finalmente legittimata dai canoni 1 e 2 del Concilio di Trullo. Pertanto, nelle raccolte dei canoni ecclesiastici, sebbene ci siano sia simboli che dogmi, ma solo nella misura in cui fanno parte delle definizioni dei concili.
Quindi di solito si distinguono canoni universali(καθολικοί, γενικοι κανόνες) e privato o locale(τοπικοί, ίδικοί κανόνες), e alcuni canonisti, inoltre, - canoni personali(προςοπικοί). La maggioranza degli studiosi, con Balsamon in testa, non riconosce come canonici decreti riguardanti individui per la forza del principio "jura non in singulas personas, sed generaliter constituntur".
La codificazione delle leggi statali dell'impero greco-romano sotto Giustiniano provocò un lavoro simile da parte della Chiesa in relazione sia ai propri canoni sia in relazione alle leggi statali in materia ecclesiastica. È qui che hanno avuto origine i cosiddetti nomocanoni. Attualmente, Pidalion (πηδάλιον - il volante su una nave), compilato dal greco. scienziati nel 1793-1800. basato principalmente sul sintagma del Patr. Fozio. In allegato al testo dei canoni:
- interpretazioni di Zonara, Aristinus (che compilò nel XII secolo una "interpretazione sulla sinossi di K.") e Balsamon;
- regole di Giovanni il Faster, Niceforo e Nicola patr. Costantinopoli e
- diversi articoli relativi al campo del diritto matrimoniale e delle formalità del lavoro d'ufficio ecclesiastico.
Ha lo stesso significato
I canoni sono le leggi fondamentali della Chiesa che costituiscono il fondamento della legge in vigore nella Chiesa, ed è la stessa in tutte le Chiese ortodosse locali in tutte le epoche della storia della Chiesa. Da quando si formò definitivamente il corpus canonico della Chiesa, dall'883 (questo è l'anno della pubblicazione del Nomocanon del Patriarca Fozio nei titoli XIV), la Chiesa non vi ha aggiunto un solo nuovo canone e non ha escluso uno solo da esso. Così, la stessa storia della Chiesa ha posto i canoni così in alto che abbiamo motivo di parlare dell'immutabilità di quei fondamenti del diritto ecclesiastico che sono contenuti in questi canoni. Il noto e autorevole teologo ortodosso, l'archimandrita Justin (Popovich), scrisse addirittura: «I santi canoni sono santi dogmi di fede applicati nella vita attiva di un cristiano, incoraggiano i membri della Chiesa a incarnare nella vita quotidiana il santo dogmi: verità celesti illuminate dal sole”. L'alto posto dei canonici nella Tradizione della Chiesa è testimoniato anche dal fatto che VII Esp. Il Concilio, in una norma consacrata alla qualificazione educativa dei candidati alla carica di Vescovo, li ha accostati alle Sacre Scritture: diligenza con riflessione, e non di passaggio, lettura dei Santi Canoni e del Santo Vangelo, e il libro del Divin Apostolo, e tutta la Divina Scrittura.
Ma pur affermando l'alta autorità e l'inviolabilità del corpus canonico per la revisione, non si può allo stesso tempo insistere sul fatto che tutte le norme di diritto contenute nei canoni siano valide o debbano essere valide in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo nel loro senso letterale. È noto che la disciplina della punizione contenuta nelle regole fu fondamentalmente riformata nella pratica penitenziale reale già nella prima epoca bizantina, quando non i termini canonici per la scomunica dalla Comunione, ma quelli offerti nel Nomocanon penitenziale del Patriarca Giovanni il Faster, contenente sanzioni incomparabilmente più morbide, sebbene il Nomocanon di Giovanni il Digiuno non fosse incluso nel codice canonico principale e nella gerarchia delle fonti autorevoli del diritto ecclesiastico sia inferiore ai canoni. È considerato nient'altro che un'aggiunta al corpus canonico principale. Successivamente la disciplina delle pene nei confronti dei laici continuò ad evolversi nella direzione della mitigazione, tanto che nella Chiesa russa, nel XVIII secolo, la scomunica dei peccatori pentiti per lunghi periodi fu positivamente vietata dalla massima autorità ecclesiastica sotto il minaccia di svincolo, ma nello stesso tempo, ovviamente, nessuno ha annullato i canoni stessi, contenente sanzioni vietate per l'uso pratico nella pratica giudiziaria ecclesiastica.
La situazione è paradossale, spingendo a una profonda riflessione sullo statuto dei canoni nella Chiesa. Soluzioni radicalmente semplici sono o dichiarare come abuso qualsiasi non applicazione della lettera delle regole e, diciamo, in relazione alla pratica delle punizioni ecclesiastiche, insistere sulla necessità di scomunicare i peccatori penitenti, secondo le regole, per 7, 10 , 15 o 20 anni, o vedere nei canoni solo un monumento della scrittura cristiana e della storia della chiesa e ignorarli completamente nella vita reale della chiesa - sembra un approccio al problema altrettanto irragionevole, non ecclesiastico e inaccettabile.
Il fatto è che i canoni rappresentano essenzialmente l'applicazione degli immutabili ed eterni fondamenti infallibili dell'insegnamento morale cristiano e dei dogmi ecclesiologici, contenuti direttamente o implicitamente nei loro testi, alla mutevole vita ecclesiale. Pertanto, in ogni canone si può trovare, da un lato, il radicamento nell'immutabile insegnamento dogmatico della Chiesa, e dall'altro, la norma canonica è sempre attuale e, quindi, condizionata da una situazione storicamente specifica, connessa con le circostanze della vita ecclesiastica che si verificarono al momento dell'emanazione del canone e che successivamente potrebbero mutare. Pertanto, l'idea di qualsiasi canone contiene un momento immutabile, dogmaticamente condizionato, ma nel suo senso concreto e letterale, il canone riflette anche le circostanze transitorie della vita ecclesiale.
I canoni non sono soggetti ad abrogazione, ma ciò non significa che le norme giuridiche in essi stabilite siano assolutamente immutate. Allo stesso tempo, nei testi delle regole stesse si può trovare un'adeguata flessibilità nell'approccio alle norme dei canoni. Quindi, 37 apostoli. diritti. prevede che i vescovi di ogni regione si riuniscano per un consiglio due volte l'anno, e in 8 diritti. Thrull. Inc. i padri, riferendosi alle incursioni barbariche e ad altri ostacoli casuali, introducono una nuova norma: convocare i consigli una volta all'anno. Significa che 8 è giusto. Thrull. Inc. cancellato 37 Apostoli. diritti. No, non è così, perché la convocazione di un consiglio due volte l'anno è ancora considerata cosa auspicabile, ma viste le difficoltà che sono sorte, si sta formando un nuovo ordine. Ma sarebbe anche letteralismo canonico concludere che l'ordine canonico si osserva solo nei casi in cui i concili sono convocati due o una volta l'anno. È evidente che quando, in connessione con l'allargamento delle Chiese locali, in connessione con la formazione dei Patriarcati, si cominciò a convocare ancor meno spesso dei Concili, ciò non si discostava dai principi canonici, per l'idea ecclesiologica fondamentale e immutabile di 37 Apost. e 8 diritti. vero singhiozzo. consiste nella cattolicità, e la periodicità specifica della convocazione dei concili può, se siamo guidati dall'esempio dei padri del Concilio di Trullo, essere stabilita tenendo conto delle circostanze del loro tempo, che non restano le stesse per secoli.
Il canone può essere inapplicabile per la scomparsa dell'istituzione ecclesiastica in esso menzionata. Quindi, a 15 a destra. Hulk. Inc. il limite di età per diventare diaconessa è di 40 anni. Con la scomparsa del grado di diaconesse, la norma cessò naturalmente di essere applicata nel suo senso letterale. Tuttavia rimase nel corpus canonico, e quindi nel nostro Libro delle Regole. Essa contiene inoltre un certo principio ecclesiologico, che non ha perso il suo significato pratico a causa della scomparsa dell'istituto di cui alla norma. Ad esempio, può servire come punto di partenza nella discussione delle autorità ecclesiastiche sulla fissazione di un limite di età per la nomina delle donne a qualsiasi posizione ecclesiale.
Alcuni dei canoni hanno natura di definizioni private, e quindi, secondo il testo letterale, non sono applicabili in nessun altro caso, ad eccezione di quelli secondo cui sono stati pubblicati: ad esempio, 4 diritti. II Universo. Inc. si legge: "Riguardo a Massimo Cinico e al disordine che commise a Costantinopoli: Massimo era inferiore, o c'è un vescovo, inferiore e da lui posto a qualsiasi grado del clero, e ciò che è stato fatto per lui e ciò che è stato fatto da lui, tutto è insignificante". Nel suo significato letterale, questo canone è inapplicabile poiché è stata risolta la situazione con il sequestro della Sede di Costantinopoli da parte di Massimo Cinico, poiché il suo testo formula una decisione giudiziaria in un caso specifico. Ma tenendo conto di tutte le circostanze del caso di Maxim Cynic, da questo canone derivano principi ecclesiologici di eccezionale importanza, in particolare l'inammissibilità di porre un vescovo in una sede già occupata. Così, questa regola opera nella Chiesa sulla base del principio precedente, e si applica per analogia.
Sulla base degli esempi precedenti, possiamo concludere che, nonostante la variabilità storica delle norme giuridiche in vigore nella Chiesa, nonostante il fatto che alcuni canoni non siano generalmente applicabili in senso letterale, e l'applicazione letterale di altri sia inaccettabile a causa delle circostanze radicalmente mutate rispetto al tempo della loro pubblicazione, i santi canoni conservano invariabilmente il loro significato come criterio della legislazione ecclesiastica e fondamento fondamentale della coscienza giuridica ecclesiastica. I canoni forniscono sempre la chiave per un corretto orientamento nei problemi reali della vita ecclesiale.
La competenza dei Consigli, la loro composizione
Uno di questi problemi è legato al chiarimento della competenza dei Vescovi e dei Consigli locali. La Chiesa russa è attualmente in attesa della convocazione di un Consiglio dei Vescovi. In connessione con il fatto che era prevista la convocazione di un nuovo Consiglio locale, il destino della comunità ecclesiale ha suscitato timori che il prossimo Consiglio dei Vescovi non sarebbe stato competente per prendere decisioni che il Consiglio locale potrebbe prendere. Se procediamo dal concetto dell'attuale Carta sull'amministrazione della Chiesa ortodossa russa, allora in essa, senza dubbio, il Consiglio dei vescovi è posto in una posizione subordinata rispetto al Consiglio locale. Ma canonicamente, il Consiglio dei Vescovi non ha minimamente sminuito la pienezza del potere nella Chiesa locale.
I canonici, in sostanza, conoscono solo il consiglio dei vescovi della regione, cioè la Chiesa locale. Sì, 19 è corretto. IV Universo. Inc. recita: «Perciò il santo concilio stabilì, secondo le regole dei santi padri, che in ogni regione i vescovi due volte l'anno si riunissero in un luogo, dove il vescovo della metropolia nominasse, e correggesse tutto ciò che era stato rivelato. " Come accennato in precedenza, 8 ha ragione. Thrull. Inc. cambiò la frequenza nella convocazione dei concili, ma non ne influì affatto sulla composizione: “Ma poiché a causa delle incursioni dei barbari, e per altri ostacoli casuali, i primati delle chiese non hanno la possibilità di convocare due volte i concili un anno, allora si argomenta: per il probabile sorgere delle faccende ecclesiastiche, in ogni regione, sia in ogni modo il consiglio dei suddetti vescovi una volta all'anno. La stessa composizione esclusivamente episcopale della cattedrale è prevista in 6 diritti. VII Universo. Inc. e 14 diritti. Karf. Inc. A 27 a destra. Karf Sob. si tratta del fatto che nei concili della Chiesa africana, il cui episcopato era particolarmente numeroso - contando molte centinaia di vescovi, ogni metropoli era rappresentata non da tutti i vescovi, ma da rappresentanti speciali e, ovviamente, immancabilmente in il grado episcopale: consiglio, in modo che, secondo le regole del Concilio di Nicea, per il bene degli affari ecclesiastici, che spesso sono rinviati a danno del popolo, si convoca ogni anno un concilio, al quale tutti coloro che occupano il prima nelle aree del dicastero manderebbero dai loro consigli due, o quanti ne vogliono, vescovi, al locum tenens, affinché l'assemblea così costituita abbia un mandato perfetto». Diritti 14, 87, 141.142 parlano anche della composizione esclusivamente episcopale dei concili. Karf. Cattedrale. 40 giusto. Laod. Inc. dice: «Non conviene che i vescovi chiamati al concilio trascurino, ma vadano ad ammonire, o ad essere ammoniti per il bene della Chiesa, e così via. In una parola, ovunque i canonici parlino di cattedrale, si sottintende il consiglio dei vescovi. I canoni non prevedono concili ai quali partecipino presbiteri, diaconi e laici.
La questione della composizione del Concilio è stata discussa sulla nostra stampa ecclesiastica all'inizio del XX secolo, quando nel 1905 la preparazione alla convocazione del Concilio divenne il tema principale della chiesa. Poi c'era disaccordo su questo tema. Un "gruppo di 32" sacerdoti si è formato a San Pietroburgo, proclamando il compito di rinnovare le basi stesse della vita ecclesiale. Questo gruppo chiedeva in una nota pubblicata sulla Gazzetta della Chiesa il 17 marzo 1905, un'ampia rappresentanza del clero e dei laici al prossimo Concilio e che allo stesso tempo clero e laici ricevessero uguali diritti con i vescovi al Concilio. In questa tendenza si manifestavano apertamente gli interessi di partito di classe dei rinnovazionisti, il desiderio di garantire maggiori diritti e privilegi al clero bianco a spese dell'episcopato e del monachesimo; i rappresentanti del "gruppo dei 32" generalmente consideravano inopportuno i monaci non vescovi e persino non canonici da chiamare al Concilio. “Non considerando l'idea corretta che il primo Concilio, per le difficoltà incontrate per la sua perfetta organizzazione, possa essere composto da soli vescovi, riteniamo che, in primo luogo, dovrebbe avere il carattere di una rappresentanza tutta ecclesiastica”, la nota del "gruppo di 32" ha dichiarato. ", depositato dal metropolita Anthony (Vadkovsky) di San Pietroburgo nel maggio 1905 - l'assenza di duecento anni di consigli e l'attuale posizione della gerarchia superiore, non eletta, come in passato , dalle stesse Chiese, cioè dal clero e dal popolo delle stesse Chiese vedove, richiede necessariamente la partecipazione della gerarchia inferiore ai consigli e ai laici».
I rinnovazionisti spaventarono i loro oppositori con uno scisma ecclesiastico che si sarebbe verificato se le loro richieste di un'eguale partecipazione del clero e dei laici al Concilio non fossero state accolte. "I vescovi elaboreranno e approveranno in consiglio un progetto di dispensa; ma la loro decisione non trarrà forza solo dal fatto che sarà il desiderio unanime di tutti i vescovi. La Chiesa dirà, o almeno può dire che non approva una tale dispensazione degli affari, non la vuole e riconosce che non corrisponde né alle sue effettive necessità né alla Tradizione da essa conservata.Questa Chiesa, involontariamente estraniata dai vescovi, avrà ragione o torto, ma una scissione accadrà", ha scritto N.P. Aksakov.
L'arcivescovo Anthony (Khrapovitsky) (poi metropolita) aveva convinzioni completamente opposte sulla natura delle imminenti trasformazioni della massima autorità ecclesiastica. “I vescovi”, scrisse poi, “non solo hanno il patriarca su di loro, ma esprimono anche la loro disponibilità a sottomettersi ai metropoliti (l'arcivescovo Anthony procedeva dal progetto di stabilire distretti metropolitani nella Chiesa russa - V. Ts.). Dopo tutti, uno solo riceverà il potere del Patriarca, e gli altri diverranno suoi novizi: sette (intendendo i metropoliti a capo dei distretti metropolitani) diretti, e gli altri 92 - novizi del metropolita Questo è altrettanto lodevole sul parte dei vescovi in quanto è utile per la Chiesa, poiché con l'indebolimento della disciplina generale della Chiesa, tutti noi hanno bisogno di un fermo potere». L'arcivescovo Anthony ha sostenuto una composizione esclusivamente episcopale dell'atteso Concilio. Nello stesso spirito fu redatta la relazione del Santo Sinodo, presentata al Sovrano nel 1905.
Monsignor Sergius di Finlandia (futuro Patriarca) ha approfondito la questione della composizione del Consiglio locale. Scrive: "E' possibile, stando in un'ottica strettamente canonica, affermare che clero e laici hanno il diritto, alla pari dei vescovi, di partecipare con voto decisivo ai consigli regionali. La risposta non può che essere negativa Che il clero e i laici fossero necessariamente presenti ai concili e che alcuni di loro prendessero la parte più notevole nelle deliberazioni del concilio, questo è vero... Ma è impossibile dire che tale fosse il diritto della Chiesa, obbligatorio per tutti, che ciò fosse richiesto dalle norme del Santo Apostolo e dei Santi Concili Ecumenici e Locali... è impossibile». Il Libro delle Regole non contiene alcuna legalizzazione per la partecipazione di chierici e laici ai Consigli regionali e , al contrario, dove si parla di concili, si parla solo di vescovi e mai di preti, chierici e laici. Tuttavia, nell'interesse dell'accordo e della pace ecclesiale, l'arcivescovo Sergio ha ritenuto lecito invitare chierici e laici a partecipare al prossimo Concilio: "Ma", ha osservato, "questa partecipazione deve essere organizzata in modo tale da non distruggere... il principio fondamentale del sistema canonico”. Per far ciò, proponeva di introdurre nel regolamento sul Consiglio la seguente condizione: «Ogni decisione del Consiglio generale, sia essa assunta votando o senza di essa, riceve forza di legge, ma può essere impugnata, indicando motivazioni e deferito al Consiglio di uno dei vescovi. Se la decisione ha carattere dogmatico-canonico, basta un voto per protesta, non importa a chi appartenga. In tutti gli altri casi, è necessario che la protesta sia dichiarata o sostenuta da almeno un quarto di tutti i presenti».
L'episcopato nel suo insieme si ergeva allora su posizioni canonicamente sane, espresse nei discorsi degli arcivescovi Antonio e Sergio. Il vero progetto del Consiglio Locale del 1917-1918. nel complesso corrispondeva al progetto delineato nell'opuscolo dell'arcivescovo Sergio. Vescovi, chierici e laici furono chiamati al Concilio, ma le decisioni in esso furono poste sotto il controllo della Conferenza Episcopale.
In connessione con le argomentazioni canonicamente irreprensibili dell'arcivescovo Sergio sopra delineate, va sottolineato che la legittimità delle decisioni del Consiglio locale è condizionata dalla sanzione su di esse da parte dell'episcopato della Chiesa locale partecipante al Concilio. Questo principio si riflette in una certa misura nell'attuale Carta. Contiene una disposizione che tutti i vescovi - membri del Consiglio - costituiscono la Conferenza episcopale. È convocato dal Presidente del Consiglio, dal Consiglio del Consiglio, o su proposta di 1/3 dei vescovi. Il suo compito è di discutere quelle decisioni che sono particolarmente importanti e discutibili da un punto di vista dogmatico e canonico. Se la decisione del Sobor è respinta dai 2/3 dei vescovi presenti, viene nuovamente sottoposta all'esame conciliare. Se, dopo questo, i 2/3 dei vescovi lo rifiutano, perde la sua forza.
Sembra, tuttavia, che la presente disposizione dello Statuto non attribuisca all'episcopato un controllo completo sull'andamento degli atti conciliari. Del resto, solo i 2/3 dei vescovi possono revocare una decisione adottata dal Consiglio al completo, in conformità con essa, anche se la decisione è presa a maggioranza semplice di almeno un voto. E i 2/3 dei vescovi meno un voto non potranno, secondo la procedura stabilita, annullare una decisione che sembra loro illegittima, non canonica o non utile al bene della Chiesa. Allo stato attuale, un tale rischio non può essere considerato puramente teorico.
Consiglio Locale 1917-1918 È noto per la più ampia partecipazione alla discussione di tutte le questioni che lo fronteggiano, clero e laici, mentre il corso degli atti conciliari è stato posto su di lui sotto un più efficace controllo gerarchico. La Carta conciliare prevedeva la responsabilità speciale dell'episcopato per le sorti della Chiesa. Le questioni di natura dogmatica e canonica, secondo le idee espresse un tempo dall'arcivescovo Sergio, dopo essere state esaminate dall'intera composizione del Concilio, erano soggette all'approvazione della Conferenza episcopale, poiché, secondo l'insegnamento di S. Giovanni di Damasco, la Chiesa è stata affidata. Allo stesso tempo, la Conferenza episcopale non ha restituito il documento al riesame dell'intera composizione del Consiglio locale, ma ha apportato le modifiche ritenute necessarie e ha adottato le definizioni finali. In sostanza, i poteri legislativi della Conferenza episcopale al Concilio del 1917-1918. erano superiori ai poteri della piena composizione del Concilio, e il principio della piena responsabilità dell'episcopato per la Chiesa è stato preservato nella massima misura, nonostante quantitativamente al Concilio i vescovi fossero meno di un quinto dei suoi partecipanti.
La modifica corrispondente, incentrata sullo statuto del Concilio del 1917-1918. avrebbe potuto essere introdotto nell'attuale "Carta sul governo della Chiesa ortodossa russa" dallo stesso Consiglio episcopale, così come i Consigli episcopali hanno già apportato altre modifiche alla "Carta". In tal caso vi sarebbero garanzie attendibili per la conservazione della pienezza canonica della responsabilità dell'episcopato per la Chiesa, a prescindere dalla composizione del Consiglio locale.
Magistratura della Chiesa
In 1 nota alla "Carta sull'amministrazione della Chiesa ortodossa russa" si dice che "in appendice alla... Carta, dovrebbe essere redatta una "Procedura dei procedimenti legali della Chiesa". La Chiesa russa non è solo l'adozione della "Procedura", ma anche l'istituzione di organi del potere giudiziario, che presumibilmente non ha. Nel frattempo, questo, ovviamente, non è così. "La Carta sull'amministrazione della Chiesa ortodossa russa" veste giudiziaria poteri nel Locale e "Il Sinodo e il Consiglio Diocesano, presieduto dal vescovo al potere, e questi organi agiscono effettivamente, prendendo le decisioni più responsabili, compreso lo svincolo e persino l'anatematizzazione. Ma il punto qui, a quanto pare, non è un semplice malinteso In sostanza, si pone la questione dell'istituzione di organi giurisdizionali speciali distinti.
Ma la loro esistenza è legale? Una digressione storica è qui opportuna. Già alla fine del 1860. Procuratore capo del Santo Sinodo Conte D.A. Tolstoj ha sollevato la questione della riforma del tribunale ecclesiastico. La stessa formulazione della domanda parla dell'approccio non ecclesiastico del procuratore capo alla prevista riforma: non dovrebbero essere riorganizzati anche i tribunali ecclesiastici secondo i principi su cui è stata fondata la parte giudiziaria dei dipartimenti civili, militari e navali trasformati - come se la Chiesa non avesse leggi proprie - canoni, indipendenti dal diritto statale. Nel progetto di D.A. Tostoj, si trattava dell'istituzione di tribunali ecclesiastici separati, e i tribunali inferiori dovevano essere tribunali diocesani, diversi in ciascuna diocesi, poiché i giudici in essi avrebbero dovuto nominare sacerdoti per autorità del vescovo diocesano. La seconda istanza d'appello doveva essere il tribunale distrettuale spirituale, uno per diverse diocesi, i cui giudici sarebbero stati eletti nelle diocesi e approvati dai vescovi. La terza istanza doveva essere il ramo giudiziario del Santo Sinodo, che avrebbe incluso vescovi e sacerdoti nominati dall'imperatore. E infine, la quarta e più alta istanza doveva essere rappresentata dalla Presenza congiunta del Santo Sinodo e del suo Ramo Giudiziario. Pertanto, il principio elettivo è stato inserito nella formazione della magistratura a livello di secondo grado; in termini procedurali, i nuovi tribunali ecclesiastici avrebbero dovuto ispirarsi all'esempio dei tribunali civili riformati, compresi i processi con giuria con il loro principio del contraddittorio.
Queste idee hanno suscitato unanimemente aspre critiche da parte dell'episcopato, che ha visto nella bozza proposta una minaccia per l'ordine creato da Dio della Chiesa di Cristo e ha insistito per mantenere intatto il monopolio canonico dell'episcopato sul potere giudiziario nella Chiesa. Per soddisfare i desideri del governo, rappresentato dal procuratore capo, erano pronti a partire solo due vescovi dell'intero episcopato russo. L'arcivescovo Agafangel (Soloviev) di Volinia, nella sua risposta al progetto, ha chiamato uno di loro, il vescovo Pavel (Dobrokhotov) di Pskov, "Giuda un traditore". Nessun altro progetto del governo nel campo della politica ecclesiastica ha incontrato una resistenza così dura e unanime da parte della Gerarchia nell'era sinodale. L'iniziatore della riforma giudiziaria dovette abbandonare il suo piano anticanonico.
La Chiesa, infatti, ha poi affrontato un'invasione dei fondamenti fondamentali del suo ordinamento canonico. Se ci rivolgiamo alle regole in cui si parla del potere giudiziario ecclesiastico, allora in tutte troviamo che si tratta o dei successori personali degli apostoli - vescovi, o dei consigli episcopali. Tutta la pienezza del potere giudiziario nella diocesi, secondo i canoni, è concentrata nella persona del suo supremo pastore e sovrano: il vescovo diocesano. Quindi, secondo 32 Apost. giusto, «se un presbitero, o un diacono, è scomunicato da un vescovo, non conviene che sia accolto in comunione per essere diverso, ma proprio colui che lo ha scomunicato, a meno che non muoia il vescovo che lo ha scomunicato .” I canoni consentono di impugnare le decisioni giudiziarie del tribunale episcopale al consiglio regionale dei vescovi (14 a destra. Sard. Sob., 9 a destra. Halk. Sob.). Lo stesso vescovo in primo grado è soggetto al tribunale del consiglio episcopale: «Il vescovo che è accusato di qualcosa da persone degne di probabilità, deve essere chiamato egli stesso dai vescovi: e se si manifesta e si confessa, o è condannato, sia sia determinata la penitenza»... (74 Apostolo .destra.)
In stretta conformità con i canoni, l'attuale "Carta sul governo della Chiesa ortodossa russa" conferisce al vescovo diocesano il potere di approvare tutte le decisioni prese dal tribunale di primo grado per clero e laici - il consiglio diocesano, mentre la "Carta "Assimila il Vescovo e l'unica autorità giudiziaria. Il Santo Sinodo è dotato nella "Carta" dei diritti di tribunale di secondo grado per i casi di chierici e laici e di tribunale di primo grado per i casi di vescovi, per i quali la corte d'appello di secondo grado è il Consiglio dei Vescovi.
Poiché, tuttavia, non esistono canoni che attribuiscano potere giudiziario nella Chiesa, personalmente o collettivamente, al clero e ai laici, sembra che le disposizioni statutarie che descrivono la competenza giudiziaria del Consiglio locale possano essere riviste sia attraverso la sua completa abolizione, sia ponendo le decisioni giudiziarie del Consiglio Locale sotto il controllo dei partecipanti a tale Consiglio dell'Episcopato. Appare altresì accettabile e perfino opportuno modificare la formulazione relativa al potere giudiziario del Santo Sinodo nei casi di chierici e laici, che nella "Carta" è attribuita in tali casi allo status di "ultima risorsa". Sarebbe più corretto chiamarla solo "la seconda istanza", ma non "l'ultima", lasciando non solo ai vescovi, ma anche al clero e ai laici almeno l'opportunità teorica di appellarsi al Consiglio dei Vescovi, ma in linea di principio anche più alto. Così, nella lettera canonica dei Padri del Concilio Africano (Cartaginese) a Celestino, Papa di Roma, che respinge le pretese di Roma di accogliere gli appelli del clero della Chiesa africana, si dice in particolare: , e si vede ragionevolmente e si tiene fermamente, e specialmente quando ciascuno, se c'è dubbio sulla giustizia della decisione dei giudici più vicini, è autorizzato a procedere ai consigli della propria regione, e anche al Concilio ecumenico.
Il tribunale ecclesiastico come organo separato dell'autorità ecclesiastica ora esiste solo nella Chiesa serba. Ma il tribunale della Grande Chiesa serba, che comprende vescovi e chierici, è stato posto in posizione subordinata rispetto al Santo Sinodo dei Vescovi, non violando così il principio del monopolio dell'episcopato sul potere giudiziario nella Chiesa. Sulla base delle considerazioni qui presentate, possiamo supporre che non sia necessario riformare il potere giudiziario ecclesiastico, tutte le istanze giudiziarie previste dall'attuale "Carta" occupano il loro posto proprio, canonicamente motivato, e la mancanza di tali istanze, e da qui la necessità di costituire nuovi organismi n. Ma c'è una reale necessità, da un lato, per l'elaborazione e l'approvazione di atti che regolano le procedure giudiziarie, come indicato in 1 nota al testo della "Carta", e dall'altro, per l'organizzazione di attività consultive e di lavoro organismi operanti su base continuativa, a cui potrebbe essere affidato il supporto professionale dei processi ecclesiastici e la preparazione di progetti di decisioni giudiziarie. È ovvio che la qualifica per attirare clero e laici per il ministero corrispondente dovrebbe essere un'impeccabile confessione della fede ortodossa, nonché un'educazione canonica o giuridica.
Parrocchia, i suoi confini
Un altro problema della struttura della chiesa è legato alla costituzione della parrocchia. "Una parrocchia", secondo la definizione data nell'attuale "Carta", è una comunità di cristiani ortodossi, composta da clero e laici uniti nella Chiesa. Tale comunità fa parte di una diocesi, è sotto l'amministrazione canonica della sua Vescovo diocesano e sotto la guida di un sacerdote da lui nominato sacerdote”. Confrontiamo questa definizione con quella data di parrocchia nella "Definizione di parrocchia ortodossa" del Consiglio locale del 1917-1918: "Una parrocchia nella Chiesa ortodossa è una comunità di cristiani ortodossi, composta da clero e laici, residente in una determinata località e unito al tempio, costituendo parte della diocesi e sotto l'amministrazione canonica del suo Vescovo diocesano, sotto la direzione del past parroco-rettore. La differenza di formulazione è quasi esclusivamente editoriale, salvo un punto significativo. Dalla formulazione dell'attuale "Carta" è stato tolto il riferimento alla permanenza del clero e dei laici della parrocchia "in una determinata località". La nuova definizione di parrocchia riflette lo stato reale delle cose, quando di fatto non vi è alcuna condizionalità di appartenenza ad una parrocchia da parte del luogo di residenza del parrocchiano, almeno nelle grandi città.
La realtà è una cosa seria, ma è anche oggetto di valutazione da un punto di vista canonico. La divisione amministrativa della Chiesa si costruisce, come è noto, su un principio territoriale, e non nazionale, linguistico, sociale, culturale o di altro genere. In condizioni normali, i cristiani ortodossi di qualsiasi nazionalità che vivono nello stesso territorio costituiscono una parrocchia e sono amministrati da un vescovo diocesano, appartengono a una Chiesa locale, poiché, secondo le parole dell'apostolo Paolo, in Cristo "non c'è né greco né Giudeo, né circoncisione né incirconcisione, barbaro, scita, schiavo, libero» (Colossesi 3, II). Allo stesso tempo, nella loro delimitazione territoriale, le Chiese, le diocesi e le parrocchie locali sono coerenti con la divisione politica e amministrativa, con i confini statali e amministrativi stabiliti. Oltre alle ovvie convenienze, questo principio trova giustificazione indiretta nei canoni stessi. Quindi, 38 è giusto. Thrull. Inc. si legge: "... Se una città viene ricostruita o continuerà a essere costruita dal potere reale, allora la distribuzione degli affari della chiesa segua la distribuzione civile e zemstvo". A livello delle Chiese locali, nonostante tutta la dolorosa acutezza e turbamento del problema della diaspora, questo principio è ancora riconosciuto come fondamentale, si osserva anche nella divisione delle diocesi, ma con la divisione della diocesi in parrocchie, le cose sono diversi ora.
Naturalmente, anche in epoca sinodale, ogni ortodosso poteva pregare, confessarsi o fare la comunione in qualsiasi, e non solo nella sua parrocchia, e in qualsiasi chiesa cattedrale o monastero. Ma i requisiti più importanti: battesimo, matrimonio, servizio funebre - il parrocchiano era legato alla sua parrocchia, in modo che le deviazioni dall'ordine stabilito in questo senso potessero essere consentite solo se seriamente motivate. La distruzione della struttura dei confini parrocchiali è avvenuta nel nostro Paese per tre ragioni principali. L'eliminazione delle parrocchie dalla tenuta dei registri delle nascite, avvenuta agli albori della storia sovietica, di fatto eliminò la procedura precedentemente sostenuta dalle autorità statali per avanzare richieste relative ad atti di stato civile. Inoltre, la persecuzione della Chiesa in epoca sovietica ha incoraggiato i cristiani deboli di cuore o, più delicatamente, cauti a coprire le tracce della loro partecipazione alla vita ecclesiale ea tal fine visitare diverse chiese. Infine, le condizioni di vita in una grande città con il suo complesso sistema di trasporti, con il fatto che il luogo di servizio per la maggior parte dei suoi abitanti si trova lontano dal luogo di residenza, rendono il tempio vicino non sempre il più accessibile. Riassumendo, tutte queste circostanze hanno cancellato dalla coscienza di molti cristiani moderni la stessa esigenza di appartenere a una determinata comunità parrocchiale, o, pur mantenendo la coscienza di tale esigenza, di concedersi piena libertà di scelta in questo considerazione, spesso motivata da predilezioni soggettive.
Naturalmente, non c'è né la necessità né la reale possibilità di abolire questa libertà di scelta o di limitarla in modo significativo assegnando tutti gli ortodossi a determinate parrocchie, come avveniva in epoca sinodale. Ma oltre alle considerazioni canoniche fondamentali, c'è anche una reale necessità, causata da considerazioni pastorali, che i confini tra le parrocchie siano ancora marcati, anche nelle grandi città. L'urgenza di questa esigenza diventa particolarmente evidente se si considera la situazione con le chiamate dei sacerdoti ai cristiani gravemente malati o morenti. L'introduzione dell'ordine nella delimitazione delle parrocchie potrebbe ridurre notevolmente i casi in cui un sacerdote deve recarsi dall'altra parte della città da un moribondo, rischiando di non trovarlo vivo e mettendo chi si rivolge alla propria chiesa parrocchiale per una simile richiesta e non ho tempo di trovarlo in una situazione difficile o disperata, parroco nella sua stessa parrocchia, perché era andato in quella di qualcun altro. Il primo passo per ripristinare la corretta struttura territoriale delle parrocchie potrebbe essere l'inserimento nella definizione statutaria di parrocchia di un'indicazione del suo vincolo territoriale, ovvero di una menzione di appartenenza ad una parrocchia di cristiani ortodossi residenti in una determinata area, come indicato nella "Determinazione di una parrocchia ortodossa" del Consiglio locale 1917-1918
Chiesa e matrimonio civile
Una questione molto rilevante è relativa alla sfera del diritto matrimoniale ecclesiastico, che in sostanza non è stato interessato dalla legislazione ecclesiastica dai tempi del Consiglio locale del 1917-1918. e quindi ora necessita di una tale regolamentazione che corrisponda all'attuale situazione giuridica, che è radicalmente diversa da quella avvenuta nel periodo sinodale. La novità fondamentale risiede nell'esistenza di una giurisdizione secolare dei rapporti matrimoniali, parallela alla giurisdizione ecclesiastica, ed anche nel fatto che la cerimonia nuziale non ha conseguenze giuridiche civili. La Chiesa, nel suo atteggiamento verso il matrimonio civile, assume l'unica posizione ambivalente possibile, rispettandola e considerandola, allo stesso tempo, non la identifica con il matrimonio ecclesiastico. Ma questo approccio fondamentalmente chiaro e indiscutibile serve solo come guida per risolvere i numerosi conflitti che sorgono nella pratica giudiziaria pastorale ed ecclesiastica, e di per sé non fornisce risposte univoche.
Non c'è dubbio che il pastore non deve rifiutare la Comunione una cristiana, o più spesso, una donna cristiana con l'accusa di fornicazione, se ha un matrimonio civile, quando il matrimonio non può essere celebrato per incredulità, eterodossia o almeno ostinata riluttanza a farlo dall'altra parte. Ma la stessa indulgenza è appropriata quando entrambi i coniugi appartengono alla Chiesa ortodossa, si confessano e ricevono la comunione, ma tuttavia rimandano il matrimonio per molto tempo o lo evitano chiaramente? D'altra parte, in alcuni casi è proprio il non riconoscimento del matrimonio civile per matrimonio che può servire come base per prendere una decisione in spirito economico, e non acrivia. Ad esempio, in una situazione in cui persone che sono in un terzo matrimonio civile, che è consentito nella Chiesa solo a determinate condizioni - di età inferiore ai 40 anni e senza figli, o in un quarto matrimonio, che è del tutto inaccettabile nella Chiesa ( Tomos of Unity), desiderano sposarsi, allora è possibile non rifiutare loro questo solo a condizione che i loro precedenti matrimoni civili non siano riconosciuti validi. Diversamente, se viene riconosciuta la validità dei loro precedenti matrimoni civili, il matrimonio diventa impossibile, anche se una delle parti è nel primo matrimonio.
Al momento, le soluzioni a tali incidenti devono essere trovate in ogni caso specifico, ed è possibile che i sacerdoti e persino le autorità diocesane prendano decisioni diverse su casi simili a causa della mancanza di un quadro normativo ecclesiastico. Dalle considerazioni qui presentate, l'importanza di sviluppare la legislazione ecclesiastica nel campo del diritto matrimoniale, tenendo conto della situazione attuale, la cui caratteristica principale al riguardo rispetto al periodo sinodale, come già accennato, nella parallela esistenza di giurisdizione civile dei matrimoni, diventa del tutto evidente.
Abbiamo sviluppato una pratica completamente ragionevole e solo ammissibile di sposare solo quelle persone il cui matrimonio civile è già stato registrato, poiché il diritto del matrimonio civile non conosce tali ostacoli al matrimonio che non significherebbero nulla nel diritto ecclesiastico. Ma tale coerenza di norme è, ovviamente, parziale e unilaterale, ed è dovuta all'estremo liberalismo del diritto del matrimonio civile in materia di ostacoli al matrimonio, perché in molti casi un matrimonio civile si registra in presenza di indubbi ostacoli al matrimonio da dal punto di vista del diritto ecclesiastico: ad esempio, matrimonio dopo lo scioglimento del quarto matrimonio, matrimonio in presenza di consanguineità, diciamo, di 4° grado, in presenza di un patrimonio almeno di 1° grado. È ovvio che un sacerdote o un vescovo non possono decidere sull'ammissibilità di un matrimonio in tutti i casi in cui vi sia un matrimonio civile. Inoltre, in alcuni casi, soprattutto in stretta consanguineità, ed in generale in presenza di ostacoli dissolventi, ha senso insistere sulla cessazione della convivenza incestuosa, ad esempio, tra cugini e sorella (54 destra. Trull. Sob.), ovvero la convivenza con una figliastra dopo la cessazione del matrimonio con la madre, anche se vi è la registrazione civile del matrimonio, o il matrimonio con la sorella della prima moglie (78 diritto. Vas. Vel.).
Questo argomento solleva la questione della possibilità per la Gerarchia di chiedere alle autorità civili tali modifiche della legislazione matrimoniale che tengano conto almeno in parte delle norme del diritto matrimoniale ecclesiastico, non solo religiosamente condizionato, ma anche ragionevole da un punto di vista biologico e morale: sul divieto di contrarre matrimonio a persone consanguinei fino al 4° grado compreso, o ai gradi patrimoniali più prossimi. Sembra anche che non sia completamente senza speranza cercare il riconoscimento da parte dello stato delle conseguenze di diritto civile del matrimonio ecclesiastico, in altre parole, il riconoscimento della sua realtà di diritto civile. Nessuna contraddizione con il principio costituzionale di uno stato laico potrebbe essere vista nel corrispondente atto del potere legislativo statale. Solo in caso di adozione di un atto del genere sarebbe possibile sposarsi senza previa iscrizione nell'ordine civile.
Nella relazione presentata sono indicati a trattini solo alcuni dei problemi più urgenti della vita giuridica della Chiesa. Ma anche un semplice elenco di essi parla dell'urgenza di intensificare il processo legislativo della chiesa. Allo stesso tempo, per escludere l'adozione di decisioni avventate, l'emanazione di qualsiasi nuovo atto legislativo-ecclesiastico richiede un solido studio ed esame preliminare. Il filo conduttore della legislazione ecclesiastica non possono essere che i canoni, letti e interpretati non letteralmente, ma tenendo conto di tutte le circostanze del tempo della loro pubblicazione e del tempo presente con le sue altre specificità, letti non per lettera, ma nello spirito che fu guidato dai Padri, che agirono sempre secondo l'esempio Colui che, secondo le parole del Profeta, «non spezzerà una canna ammaccata, né spegnerà il lino fumante» (Is 42,3).
Pagina generata in 0,02 secondi!