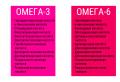Cosa sono le macchie solari? Quello che la scienza sa delle macchie solari. Macchie scure al sole
Il fatto che ci siano delle macchie sul Sole, le persone lo sanno da molto tempo. Nelle antiche cronache russe e cinesi, così come nelle cronache di altri popoli, c'erano spesso riferimenti alle osservazioni delle macchie solari. Nelle cronache russe è stato notato che i punti erano visibili "unghie Aki". I registri hanno contribuito a confermare lo schema stabilito successivamente (nel 1841) di un aumento periodico del numero di macchie solari. Per notare un oggetto del genere con un occhio semplice (soggetto, ovviamente, a misure precauzionali - attraverso un vetro densamente affumicato o una pellicola negativa illuminata), è necessario che la sua dimensione sul Sole sia di almeno 50 - 100 mila chilometri, ovvero decine di volte maggiore del raggio della Terra.
Il sole è costituito da gas caldi che si muovono e si mescolano costantemente, e quindi non c'è nulla di costante e immutabile sulla superficie solare. Le formazioni più stabili sono le macchie solari. Ma il loro aspetto cambia di giorno in giorno, e anche loro ora appaiono, poi scompaiono. Al momento della comparsa, una macchia solare è solitamente piccola, può scomparire, ma può anche aumentare notevolmente.
I campi magnetici svolgono il ruolo principale nella maggior parte dei fenomeni osservati sul Sole. Il campo magnetico solare ha una struttura molto complessa ed è in continua evoluzione. L'azione combinata della circolazione del plasma solare nella zona convettiva e della rotazione differenziale del Sole eccita costantemente il processo di amplificazione di deboli campi magnetici e l'emergere di nuovi. Apparentemente, questa circostanza è la ragione della comparsa delle macchie solari sul Sole. I punti appaiono e scompaiono. Il loro numero e le dimensioni variano. Ma, approssimativamente, ogni 11 anni il numero di spot diventa il più grande. Allora si dice che il Sole sia attivo. Con lo stesso periodo (~ 11 anni) si verifica anche l'inversione di polarità del campo magnetico solare. È naturale presumere che questi fenomeni siano interconnessi.
Lo sviluppo della regione attiva inizia con un aumento del campo magnetico nella fotosfera, che porta alla comparsa di aree più luminose: le torce (la temperatura della fotosfera solare è in media di 6000 K, nella regione delle torce è di circa 300 K più alto). Un ulteriore rafforzamento del campo magnetico porta alla comparsa di macchie.
All'inizio del ciclo di 11 anni, le macchie iniziano ad apparire in piccolo numero a latitudini relativamente elevate (35 - 40 gradi), quindi la zona di formazione delle macchie scende gradualmente all'equatore, a una latitudine di più 10 - meno 10 gradi , ma proprio all'equatore delle macchie, di regola, non può essere.
Galileo Galilei fu uno dei primi a notare che le macchie non si osservano ovunque sul Sole, ma principalmente alle medie latitudini, all'interno delle cosiddette "zone reali".
In primo luogo, di solito compaiono singoli punti, ma poi ne deriva un intero gruppo, in cui si distinguono due grandi punti: uno sul bordo occidentale, l'altro sul bordo orientale del gruppo. All'inizio del nostro secolo è apparso chiaro che le polarità della macchia orientale e occidentale sono sempre opposte. Formano, per così dire, due poli di un magnete, e quindi un tale gruppo è chiamato bipolare. Una tipica macchia solare misura diverse decine di migliaia di chilometri.
Galileo, disegnando dei punti, segnò un bordo grigio attorno ad alcuni di essi.
In effetti, la macchia è costituita da una parte centrale più scura - l'ombra e una zona più chiara - la penombra.
Le macchie solari sono talvolta visibili sul suo disco anche ad occhio nudo. L'apparente oscurità di queste formazioni è dovuta al fatto che la loro temperatura è di circa 1500 gradi inferiore alla temperatura della fotosfera circostante (e, di conseguenza, la radiazione continua da esse è molto inferiore). Un unico punto sviluppato è costituito da un ovale scuro, la cosiddetta ombra del punto, circondato da una penombra fibrosa più chiara. I piccoli punti non sviluppati senza penombra sono chiamati pori. Macchie e pori spesso formano gruppi complessi.
Un tipico gruppo di macchie solari appare inizialmente come uno o più pori nella regione della fotosfera indisturbata. La maggior parte di questi gruppi di solito scompare dopo 1-2 giorni. Ma alcuni crescono e si sviluppano costantemente, formando strutture piuttosto complesse. Le macchie solari possono avere un diametro maggiore della Terra. Spesso formano gruppi. Si formano in pochi giorni e di solito scompaiono entro una settimana. Alcuni punti grandi, tuttavia, possono persistere fino a un mese. Grandi gruppi di macchie solari sono più attivi rispetto a piccoli gruppi o singole macchie solari.
Il Sole cambia lo stato della magnetosfera e dell'atmosfera terrestre. Campi magnetici e flussi di particelle che provengono dalle macchie solari raggiungono la Terra e colpiscono principalmente il cervello, il sistema cardiovascolare e circolatorio di una persona, il suo stato fisico, nervoso e psicologico. Un alto livello di attività solare, i suoi rapidi cambiamenti eccitano una persona, e quindi la collettività, la classe, la società, soprattutto quando ci sono interessi comuni e un'idea comprensibile e percepita.
Rivolgendosi al Sole con l'uno o l'altro del suo emisfero, la Terra riceve energia. Questo flusso può essere rappresentato come un'onda itinerante: dove cade la luce - la sua cresta, dove è buio - un fallimento. In altre parole, l'energia va e viene. Mikhail Lomonosov ha parlato di questo nella sua famosa legge naturale.
La teoria della natura ondulatoria della fornitura di energia alla Terra spinse Alexander Chizhevsky, il fondatore dell'eliobiologia, a prestare attenzione alla connessione tra l'aumento dell'attività solare e i cataclismi terrestri. La prima osservazione fatta dallo scienziato risale al giugno 1915. Nel nord brillavano le aurore, osservate sia in Russia che in Nord America, e "tempeste magnetiche interrompevano continuamente il movimento dei telegrammi". Proprio durante questo periodo, lo scienziato attira l'attenzione sul fatto che l'aumento dell'attività solare coincide con lo spargimento di sangue sulla Terra. Infatti, subito dopo la comparsa di grandi macchie sul Sole, le ostilità si intensificarono su molti fronti della prima guerra mondiale.
Ora gli astronomi dicono che la nostra stella sta diventando sempre più luminosa e più calda. Ciò è dovuto al fatto che negli ultimi 90 anni l'attività del suo campo magnetico è più che raddoppiata, con il più grande aumento verificatosi negli ultimi 30 anni. A Chicago, alla conferenza annuale dell'American Astronomical Society, c'è stato un avvertimento da parte degli scienziati sui problemi che minacciano l'umanità. Proprio come i computer intorno al pianeta si adatteranno alle condizioni operative nell'anno 2000, la nostra stella entrerà nella fase più turbolenta del suo ciclo ciclico di 11 anni.Ora gli scienziati saranno in grado di prevedere con precisione i brillamenti solari, il che consentirà di prepararsi in anticipo per eventuali guasti al funzionamento delle reti radio ed elettriche. Ora la maggior parte degli osservatori solari ha confermato l'"avviso di tempesta" per il prossimo anno, perché. il picco dell'attività solare si osserva ogni 11 anni e la tempesta precedente è stata osservata nel 1989.
Ciò può portare al fatto che le linee elettriche sulla Terra si guasteranno, le orbite dei satelliti, che garantiscono il funzionamento dei sistemi di comunicazione, degli aerei "diretti" e dei transatlantici, cambieranno. Una "rivolta" solare è solitamente caratterizzata da potenti bagliori e dalla comparsa di molti di quegli stessi punti.
Alexander Chizhevsky negli anni '20. ha scoperto che l'attività solare influenza eventi terrestri estremi - epidemie, guerre, rivoluzioni ... La Terra non ruota solo attorno al Sole - tutta la vita sul nostro pianeta pulsa nei ritmi dell'attività solare, - ha stabilito.
Lo storico e sociologo francese Hippolyte Tarde definì la poesia una premonizione della verità. Nel 1919 Chizhevsky scrisse una poesia in cui prevedeva il suo destino. Fu dedicato a Galileo Galilei:
E risorgere ancora e ancora
macchie solari,
E le menti sobrie si oscurarono,
E il trono cadde, ed erano inevitabili
La pestilenza affamata e gli orrori della peste
E il volto della vita si trasformò in una smorfia:
La bussola correva, il popolo si ribellava,
E sulla Terra e sulla massa umana
Il Sole stava facendo la sua mossa legittima.
O tu che hai visto le macchie solari
Con splendida audacia,
Non sapevi come mi sarebbero stati chiari
E i tuoi dolori sono vicini, Galileo!
Nel 1915-1916, in seguito a quanto stava accadendo sul fronte russo-tedesco, Alexander Chizhevsky fece una scoperta che colpì i suoi contemporanei. L'aumento dell'attività solare registrato attraverso il telescopio ha coinciso nel tempo con l'intensificarsi delle ostilità. Incuriosito, ha condotto uno studio statistico tra parenti e amici sul tema di una possibile connessione tra reazioni neuropsichiche e fisiologiche con la comparsa di brillamenti e macchie solari. Elaborando matematicamente le tavolette ricevute, è giunto a una conclusione sbalorditiva: il Sole influenza l'intera nostra vita in modo molto più sottile e profondo di quanto sembrava prima. Nel fangoso e sanguinoso pasticcio di fine secolo, vediamo una chiara conferma delle sue idee. E nei servizi speciali di diversi paesi, ora interi dipartimenti sono impegnati nell'analisi dell'attività solare ... In sostanza, è stato dimostrato il sincronismo dei massimi di attività solare con periodi di rivoluzioni e guerre, periodi di maggiore attività delle macchie solari spesso coincidevano con ogni tipo di agitazione pubblica.
Recentemente, diversi satelliti spaziali hanno registrato un'espulsione di protuberanze solari, caratterizzata da un livello insolitamente elevato di emissione di raggi X. Tali fenomeni rappresentano una seria minaccia per la Terra e i suoi abitanti. Un lampo di questa portata ha il potenziale per destabilizzare le reti elettriche. Fortunatamente, il flusso di energia non ha influenzato la Terra e non si sono verificati problemi previsti. Ma l'evento stesso è foriero del cosiddetto "massimo solare", accompagnato dal rilascio di una quantità di energia molto maggiore che può disabilitare comunicazioni, comunicazioni e linee elettriche, trasformatori, astronauti e satelliti spaziali che si trovano al di fuori del campo magnetico terrestre e non sono protetti saranno a rischio l'atmosfera del pianeta. Ci sono più satelliti della NASA in orbita oggi che mai. C'è anche una minaccia per gli aerei, espressa nella possibilità di interrompere le comunicazioni radio, disturbare i segnali radio.
I massimi solari sono difficili da prevedere, si sa solo che si ripetono circa ogni 11 anni. Il prossimo dovrebbe avvenire a metà dell'anno 2000 e la sua durata sarà da uno a due anni. Così dice David Hathaway, eliofisico al Marshall Space Flight Center, NASA.
Le protuberanze durante il massimo solare possono verificarsi quotidianamente, ma non si sa esattamente quale forza avranno e se influenzeranno il nostro pianeta. Negli ultimi mesi, le esplosioni di attività solare ei conseguenti flussi di energia verso la Terra sono stati troppo deboli per causare danni. Oltre ai raggi X, questo fenomeno comporta altri pericoli: il Sole espelle un miliardo di tonnellate di idrogeno ionizzato, un'onda del quale viaggia alla velocità di un milione di miglia orarie e può raggiungere la Terra in pochi giorni. Un problema ancora più grande sono le onde di energia dei protoni e delle particelle alfa. Si muovono a velocità molto più elevate e non lasciano tempo per prendere contromisure, a differenza delle onde di idrogeno ionizzato, che possono allontanare satelliti e aerei dalla loro traiettoria.
In alcuni dei casi più estremi, tutte e tre le onde possono raggiungere la Terra improvvisamente e quasi simultaneamente. Non c'è protezione, gli scienziati non sono ancora in grado di prevedere con precisione un tale rilascio, e ancor di più le sue conseguenze.
Per comprendere la natura fisica dei processi che avvengono sul Sole, è importante stabilire le ragioni della minore temperatura delle macchie rispetto alla fotosfera, il ruolo dei fenomeni magnetici nel loro sviluppo ed esistenza, e il meccanismo dell'11 (22 )-ciclicità annuale dell'attività solare.
Tabella 6. Modello delle macchie solari di Mishard (1953). In ogni doppia colonna, la prima si riferisce alla fotosfera, la seconda alla macchia solare. La pressione è espressa in dine/cm2. I valori incerti sono tra parentesi. La profondità ottica a viene scelta come argomento.

La temperatura delle macchie, come accennato in precedenza, è molto inferiore alla temperatura della fotosfera, il che è confermato dalla loro relativa oscurità e da un grado di ionizzazione ed eccitazione molto più basso, come risulta dai loro spettri. Una diminuzione del numero di elettroni nelle macchie provoca una diminuzione dell'opacità della materia solare (principalmente a causa di una forte diminuzione del numero di ioni). Pertanto, nei punti "guardiamo" in profondità geometriche maggiori rispetto alla fotosfera. Tuttavia, queste profondità sono ancora estremamente insignificanti, come si può vedere dalla Tabella 6.
Pertanto, tenendo conto dell'effetto Wilson, il punto visibile può essere paragonato a una piccola piastra. È molto difficile tracciare in profondità il colpo dello spot, poiché dipende dalla distribuzione del campo magnetico con la profondità. Infatti, come si può vedere dalla Tabella 6, la pressione allo stesso livello nello spot è circa din/cm2 (circa 0,2 atm) inferiore rispetto alla fotosfera vicina. L'equilibrio può essere mantenuto solo con una pressione aggiuntiva, creata da un campo magnetico [vedi. § 2, formula (2.26)]. La pressione è uguale e questo valore sarà uguale a dyne/cm2 se . Solo un tale campo magnetico è solitamente per il livello superiore dei punti. Le seguenti caratteristiche numeriche sono tipiche di una macchia solare media:

Data l'ampia scala dei movimenti nella fotosfera solare e al di sotto di essa, l'attenuazione dei campi magnetici sul Sole procede molto lentamente (sono necessari centinaia di anni). Per questo motivo, le regioni attive del Sole hanno una lunga esistenza e i campi magnetici o affondano nelle profondità della fotosfera o galleggiano sulla sua superficie. In prossimità della superficie, dove la densità della materia diventa bassa, viene violata la condizione di uguaglianza dell'energia cinetica e dell'energia del campo magnetico a favore di quest'ultima, e la convezione è fortemente soppressa, mentre normalmente i flussi convettivi trasportano calore con loro. Inoltre, a livello subfotosferico delle macchie solari, è vietato anche l'afflusso di calore convettivo dalla periferia, poiché scorre attraverso le linee del campo magnetico. È l'assenza di convezione che è la ragione della bassa temperatura dei punti. Tuttavia, questo non è l'unico motivo. È anche possibile portare via il calore dall'ombra mediante onde magnetoidrodinamiche.
I campi magnetici a lungo termine sul Sole sono apparentemente associati all'esistenza di grandi moti di circolazione nella zona convettiva del Sole fino a una profondità di diverse decine di migliaia di chilometri, che sorgono a causa della disomogeneità della rotazione del Sole. La circolazione plasmatica genera vortici magnetici e quando vengono in superficie compaiono gruppi bipolari, semplici o complessi, la cui espressione visibile sono le macchie (Fig. 40). Allo stesso tempo, ci sono molti di questi vortici sul Sole su diversi meridiani. Probabilmente, durante il ciclo, si spostano verso l'equatore, mentre nuovi vortici si originano ai poli e sostituiscono quelli vecchi. Naturalmente, la direzione dei vortici è diversa in entrambi gli emisferi. La velocità con cui grandi vortici scendono verso l'equatore determina la durata del ciclo di attività solare.
Il ciclo di 22 anni rimane poco chiaro. Naturalmente, le linee di forza magnetiche vanno ben oltre la superficie del Sole, nella cromosfera e nella corona, ma devono essere portate da determinate masse di materia. Vedremo ulteriori segni dell'interferenza delle forze magnetiche nei processi cromosferici e coronali.

Riso. 40. Regioni magnetiche sul Sole (schema)
Piccoli campi magnetici, come quelli che esistono alla periferia delle macchie solari, invece di sopprimere la convezione, la aumentano. Questo perché il campo debole, non potendo interferire con una vigorosa convezione, sopprime la turbolenza relativamente debole e quindi riduce la viscosità del gas, che accelera il moto convettivo. Uscendo negli strati superiori della fotosfera, il flusso di calore in eccesso dovuto alla convezione riscalda il gas, e quindi si osservano bagliori intorno ai punti e si osservano flocculi, calcio e idrogeno sopra le torce. Il confine dei flocculi di calcio determina generalmente il confine della regione attiva, mentre i flocculi di idrogeno si accalcano più vicino al punto, dove il campo magnetico è alquanto più forte: 10–15 flussi Oe. (lungo le linee di forza), che è coerente con il fenomeno di afflusso di materia nello spot ad alta quota osservato con l'ausilio di velocità radiali.

Riso. 41. L'uscita del campo magnetico sulla superficie del Sole (schema)
Sebbene nelle regioni inattive del Sole il campo magnetico abbia un'intensità di 1-2 Oe, in alcuni punti, di piccole dimensioni, può raggiungere 100 Oe. Negli stessi punti si osservano poi piccoli nodi luminosi nella fotosfera.
Superiore alla temperatura ambiente, insieme al campo magnetico, genera un eccesso di pressione sulla materia circostante, per cui il nodo deve dissiparsi rapidamente e, per la sua lunga esistenza, è necessario un afflusso di gas dall'esterno, che può verificarsi se la base del nodo nella fotosfera è più fredda e la pressione è inferiore rispetto all'ambiente.
Un quadro più dettagliato dei moti orizzontali a diversi livelli dell'atmosfera solare in connessione con la struttura fine dei campi magnetici è fornito da osservazioni spettroeliografiche modificate utilizzando il metodo di Leighton. Questo metodo consiste nell'ottenere simultaneamente immagini spettroeliografiche su larga scala di un'area priva di macchie solari nei raggi dell'ala a lunghezza d'onda corta e lunga dell'una o dell'altra linea spettrale. Come accennato in precedenza (p. 47), allontanandosi dal centro della linea, osserviamo strati sempre più profondi dell'atmosfera solare, mentre le ali destra e sinistra della linea corrispondono in un caso principalmente all'avvicinamento, e nell'altro a masse di gas in ritirata. Il confronto di entrambi gli spettroeliogrammi rivela flussi sulla superficie del Sole che si muovono verso e lontano dall'osservatore. Si è scoperto che sono localizzati all'interno di celle con un diametro di circa 30 mila km, in modo che in ogni cella vi sia un movimento sistematico di masse di gas dal centro alla periferia. Queste cellule sono chiamate supergranuli. Sono molto più durevoli dei pellet convenzionali, con una durata media di 40 ore. Hanno una forma angolare simile ai poligoni.
La supergranulazione riflette il fenomeno della convezione sul Sole su una scala molto più ampia della granulazione, coprendo non solo grandi aree, ma anche grandi profondità. Secondo le condizioni di osservazione (nelle ali di varie linee), è possibile tracciare questa convezione solo negli strati superiori della fotosfera solare. La rete cellulare osservata negli spettroeliogrammi appartiene già alla cromosfera superiore e non coincide con la rete di supergranulazione. Al contrario, il fenomeno dei granuli osservato nella luce integrata si riferisce a profondità leggermente maggiori rispetto alle aree di supergranulazione osservate. Ma sia in base alla distribuzione delle velocità nei supergranuli, sia in base allo studio del movimento dei singoli granuli, tutti gli spostamenti del plasma solare vanno ai confini dei supergranuli, portando con sé il campo magnetico. Qui, incontrando un flusso simile di un supergranulo vicino, il plasma va più in profondità, il che ne garantisce la circolazione costante. Allo stesso tempo, il campo magnetico rimane (poiché il plasma si muove lungo le linee di forza), e qui la sua intensità raggiunge valori di diverse decine e persino centinaia di oersted, e negli angoli delle cellule anche fino a 1,5- 2mila oersted, come si evince dalle osservazioni effetto Zeeman. Pertanto, ogni supergranulo ha una barriera magnetica che lo limita e lo protegge. Ma oltre a questo, il confine del supergranulo ha una temperatura più alta del suo centro di circa il 2-4%, che deriva dall'aumento della luminosità di quelle righe spettrali che sono migliorate nei punti, cioè le righe a bassa eccitazione. Un aumento della luminosità nelle linee indica una diminuzione del numero di atomi assorbenti, che in questo caso si verifica a causa di un aumento dell'eccitazione o della ionizzazione.
Si presume che nella profondità della fotosfera i supergranuli si fondano parzialmente, poiché, ad eccezione degli angoli delle celle, le pareti dei supergranuli rappresentano una barriera magnetica piuttosto debole con l'aumento della densità del gas.
L'influenza della struttura della supergranulazione si estende maggiormente verso l'alto. Nelle osservazioni vicino al bordo solare, i supergranuli coincidono con le cellule dei pennacchi. Qui, nella fotosfera, solo in questo caso è visibile la supergranulazione. Al contrario, nella cromosfera, la supergranulazione si manifesta come una rete di flocculi, che appare chiaramente sugli spettroeliogrammi nei raggi Ca II K. 72, che si irradiano sopra la cromosfera nello strato di transizione, ma scompaiono nei raggi delle linee coronali, come le linee . Bisogna pensare che anche i campi magnetici dei supergranuli che li circondano si estendono così lontano. Solo alle altezze coronali acquisiscono una forma ordinata: linee magnetiche corrono radialmente, definendo canali lungo i quali si muovono gli elettroni termoconduttori. Il loro movimento è così vincolato, la conducibilità termica dello strato di transizione diminuisce e il suo spessore diventa maggiore che in assenza di campo. Naturalmente, tutto quanto sopra si applica alla cromosfera e alla corona silenziose.
Macchie solari
Il sole è l'unico di tutte le stelle che vediamo non come un punto scintillante, ma come un disco splendente. Grazie a ciò, gli astronomi hanno l'opportunità di studiare vari dettagli sulla sua superficie.
Cosa è macchie solari?
Le macchie solari sono lontane dalle formazioni stabili. Sorgono, si sviluppano e scompaiono e ne compaiono di nuovi invece di quelli che sono scomparsi. Occasionalmente si formano macchie giganti. Così, nell'aprile del 1947, fu osservata una macchia complessa sul Sole: la sua area superava di 350 volte la superficie del globo! Era chiaramente visibile ad occhio nudo.
Macchie solari
Tali grandi macchie solari sono state notate fin dai tempi antichi. Nella cronaca Nikon del 1365, si può trovare una menzione di come i nostri antenati in Russia vedessero "macchie scure, come chiodi" sul Sole attraverso il fumo degli incendi boschivi.
Apparendo sul bordo orientale (sinistra) del Sole, muovendosi lungo il suo disco da sinistra a destra e scomparendo dietro il bordo occidentale (destra) della luce diurna, le macchie solari forniscono un'eccellente opportunità non solo per verificare la rotazione del Sole attorno al suo asse , ma anche per determinare il periodo di questa rotazione (più precisamente, è determinato dallo spostamento Doppler delle righe spettrali). Le misurazioni hanno mostrato: il periodo di rotazione del Sole all'equatore è di 25,38 giorni (rispetto all'osservatore sulla Terra in movimento - 27,3 giorni), alle medie latitudini - 27 giorni e ai poli circa 35 giorni. Pertanto, il Sole ruota più velocemente all'equatore che ai poli. Rotazione zonale i luminari testimoniano il suo stato gassoso. La parte centrale di un grande punto nel telescopio appare completamente nera. Ma le macchie appaiono scure solo perché le osserviamo sullo sfondo di una fotosfera luminosa. Se lo spot potesse essere considerato separatamente, allora vedremmo che brilla più intensamente di un arco elettrico, poiché la sua temperatura è di circa 4500 K, cioè 1500 K in meno rispetto alla temperatura della fotosfera. Una macchia solare di medie dimensioni contro il cielo notturno apparirà luminosa come la luna durante la luna piena. Solo i punti emettono luce non gialla, ma rossastra.
Di solito il nucleo scuro di una grande macchia è circondato da una penombra grigia, costituita da fibre radiali chiare poste su uno sfondo scuro. Tutta questa struttura è ben visibile anche in un piccolo telescopio.
macchie al sole
Già nel 1774, l'astronomo scozzese Alexander Wilson (1714-1786), osservando i punti ai margini del disco solare, concluse che i punti grandi sono depressioni nella fotosfera. Ulteriori calcoli hanno mostrato che il "fondo" della macchia solare si trova al di sotto del livello della fotosfera in media di 700 km. In una parola, gli spot sono enormi imbuti nella fotosfera.
Intorno alle macchie nei raggi di idrogeno, la struttura a vortice della cromosfera è chiaramente visibile. Questa struttura a vortice indica l'esistenza di violenti movimenti del gas attorno al punto. Lo stesso motivo è creato dalla limatura di ferro cosparsa su un foglio di cartone, se sotto di essi viene posizionato un magnete. Questa somiglianza portò l'astronomo americano George Hale (1868-1938) a sospettare che le macchie solari fossero enormi magneti.
Hale sapeva che le righe spettrali si dividono quando il gas che emette viene posto in un campo magnetico (il cosiddetto Zeeman spaccatura). E quando l'astronomo ha confrontato l'entità della scissione osservata nello spettro delle macchie solari con i risultati di esperimenti di laboratorio Con gas in un campo magnetico, scoprì che i campi magnetici delle macchie sono migliaia di volte maggiori dell'induzione del campo magnetico terrestre. L'intensità del campo magnetico sulla superficie terrestre è di circa 0,5 oersted. E nelle macchie solari sono sempre più di 1500 oersted - a volte raggiunge i 5000 oersted!
La scoperta della natura magnetica delle macchie solari è una delle scoperte più importanti dell'astrofisica all'inizio del XX secolo. Per la prima volta è stato scoperto che non solo la nostra Terra, ma anche altri corpi celesti hanno proprietà magnetiche. Il sole è venuto alla ribalta in questo senso. Solo il nostro pianeta ha un campo magnetico dipolo permanente con due poli e il campo magnetico del Sole ha una struttura complessa e, inoltre, "si gira", cioè cambia segno o polarità. E sebbene le macchie solari siano magneti molto potenti, il campo magnetico totale del Sole raramente supera 1 oersted, che è parecchie volte maggiore del campo medio della Terra.
Forte campo magnetico in un gruppo di macchie solari bipolari

Il forte campo magnetico degli spot è proprio il motivo della loro bassa temperatura. Dopotutto, il campo crea uno strato isolante sotto il punto e per questo rallenta drasticamente il processo di convezione - riduce l'afflusso di energia dalle profondità della stella.
I punti grandi preferiscono apparire in coppia. Ciascuna di queste coppie si trova quasi parallela all'equatore solare. Il punto iniziale, o di testa, di solito si muove un po' più velocemente del punto finale (coda). Pertanto, durante i primi giorni, le macchie si allontanano l'una dall'altra. Allo stesso tempo, la dimensione delle macchie aumenta.
Spesso appare una "catena" di piccoli punti tra i due punti principali. Dopo che ciò accade, il punto di coda può subire un rapido decadimento e scomparire. Rimane solo il punto di testa, che diminuisce più lentamente e vive in media 4 volte più a lungo del suo compagno. Un simile processo di sviluppo è caratteristico di quasi tutti i grandi gruppi di macchie solari. La maggior parte degli spot vive solo per pochi giorni (anche poche ore!), mentre altri durano diversi mesi.
I punti, il cui diametro raggiunge i 40-50 mila km, possono essere visti attraverso un filtro luminoso (vetro densamente fumé) ad occhio nudo.
Cosa sono i brillamenti solari?
Il 1 settembre 1859, due astronomi inglesi, Richard Carrington e S. Hodgson, osservando indipendentemente il Sole alla luce bianca, videro all'improvviso qualcosa come un lampo tra un gruppo di macchie solari. Questa fu la prima osservazione di un nuovo fenomeno ancora sconosciuto sul Sole; in seguito fu chiamato brillamento solare.
Cos'è un brillamento solare? In breve, questa è l'esplosione più forte sul Sole, a seguito della quale viene rilasciata rapidamente un'enorme quantità di energia accumulata in un volume limitato dell'atmosfera solare.
Molto spesso, i lampi si verificano in regioni neutre situate tra grandi punti di polarità opposta. Di solito, lo sviluppo di un bagliore inizia con un improvviso aumento della luminosità dell'area del bagliore, una regione di una fotosfera più luminosa e quindi più calda. Quindi si verifica un'esplosione catastrofica, durante la quale il plasma solare si riscalda fino a 40-100 milioni di K. Ciò si manifesta in un aumento multiplo della radiazione a onde corte del Sole (ultravioletti e raggi X), nonché in un aumento nella "voce radio" della luce del giorno e nel rilascio di corpuscoli solari accelerati (particelle). E in alcuni dei bagliori più potenti vengono generati anche raggi cosmici solari, i cui protoni raggiungono velocità pari alla metà della velocità della luce. Tali particelle hanno un'energia mortale. Sono in grado di penetrare quasi liberamente nel veicolo spaziale e distruggere le cellule di un organismo vivente. Pertanto, i raggi cosmici solari possono rappresentare un serio pericolo per l'equipaggio colto durante il volo da un lampo improvviso.
Pertanto, i brillamenti solari emettono radiazioni sotto forma di onde elettromagnetiche e sotto forma di particelle di materia. L'amplificazione della radiazione elettromagnetica si verifica in un'ampia gamma di lunghezze d'onda, dai raggi X duri e dai raggi gamma alle onde radio chilometriche. In questo caso, il flusso totale di radiazione visibile rimane sempre costante entro frazioni di percentuale. Si verificano quasi sempre deboli bagliori sul Sole e grandi, una volta ogni pochi mesi. Ma durante gli anni di massima attività solare, si verificano grandi eruzioni solari più volte al mese. Solitamente un piccolo lampo dura 5-10 minuti; il più potente - poche ore. Durante questo periodo, una nuvola di plasma con una massa fino a 10 miliardi di tonnellate viene espulsa nello spazio quasi solare e viene rilasciata energia equivalente all'esplosione di decine o addirittura centinaia di milioni di bombe all'idrogeno! Tuttavia, la potenza anche dei più grandi bagliori non supera i centesimi di percento della potenza della radiazione solare totale. Pertanto, durante un lampo, non c'è un aumento evidente della luminosità della nostra luce diurna.
Durante il volo del primo equipaggio sulla stazione orbitale americana Skylab (maggio-giugno 1973), riuscirono a fotografare il flash alla luce dei vapori di ferro ad una temperatura di 17 milioni di K, che dovrebbe essere più calda che al centro di un reattore a fusione solare. E negli ultimi anni sono stati registrati impulsi di radiazioni gamma da diversi bagliori.

Tali impulsi probabilmente devono la loro origine a annientamento coppie elettrone-positrone. Il positrone è noto per essere l'antiparticella dell'elettrone. Ha la stessa massa di un elettrone, ma ha la carica elettrica opposta. Quando un elettrone e un positrone si scontrano, cosa che può accadere nei brillamenti solari, vengono immediatamente annientati, trasformandosi in due fotoni di raggi gamma.
Come ogni corpo riscaldato, il Sole emette continuamente onde radio. termico emissione radio dal sole tranquillo, quando non ci sono punti e lampi su di esso, proviene costantemente dalla cromosfera sia ad onde millimetriche che centimetriche, e dalla corona ad onde metriche. Ma non appena compaiono grandi macchie, si verifica un lampo, forte la radio esplode... E poi l'emissione radio del Sole aumenta bruscamente di migliaia o addirittura milioni di volte!
I processi fisici che portano al verificarsi di brillamenti solari sono molto complessi e ancora poco conosciuti. Tuttavia, il fatto stesso della comparsa di brillamenti solari quasi esclusivamente in grandi gruppi di macchie solari testimonia la relazione dei brillamenti con forti campi magnetici sul Sole. E un lampo non è, a quanto pare, altro che una grandiosa esplosione causata da un'improvvisa compressione del plasma solare sotto la pressione di un forte campo magnetico. È l'energia dei campi magnetici, in qualche modo rilasciata, che genera un bagliore solare.
Le radiazioni dei brillamenti solari raggiungono spesso il nostro pianeta, avendo un forte effetto sugli strati superiori dell'atmosfera terrestre (ionosfera). Portano anche all'emergere di tempeste magnetiche e aurore, ma questa è una storia avanti.
Ritmi del Sole
Nel 1826, l'astronomo dilettante tedesco, il farmacista Heinrich Schwabe (1789-1875) di Dessau, iniziò le osservazioni sistematiche e gli schizzi delle macchie solari. No, non avrebbe affatto studiato il Sole: era interessato a qualcosa di completamente diverso. A quel tempo, si pensava che un pianeta sconosciuto si stesse muovendo tra il Sole e Mercurio. E poiché era impossibile vederlo vicino a una stella luminosa, Schwabe decise di osservare tutto ciò che era visibile sul disco solare. Dopotutto, se un tale pianeta esiste davvero, prima o poi passerà sicuramente attraverso il disco del Sole sotto forma di un piccolo cerchio o punto nero. Ed eccola finalmente "catturata"!
Tuttavia, Schwabe, nelle sue stesse parole, "è andato alla ricerca degli asini di suo padre, ha trovato un regno". Nel 1851 Cosmos di Alexander Humboldt (1769-1859) pubblicò i risultati delle osservazioni di Schwabe, che mostravano che il numero delle macchie solari aumentava e diminuiva abbastanza regolarmente in un periodo di 10 anni. Questa periodicità nella variazione del numero delle macchie solari, in seguito chiamata Ciclo di 11 anni di attività solare, fu scoperto da Heinrich Schwabe nel 1843. Osservazioni successive hanno confermato questa scoperta e l'astronomo svizzero Rudolf Wolf (1816-1893) ha chiarito che i massimi del numero di macchie solari si ripetono in media dopo 11,1 anni.
Quindi, il numero di spot varia di giorno in giorno e di anno in anno. Per giudicare il grado di attività solare in base al conteggio delle macchie solari, nel 1848 Wolf introdusse il concetto del numero relativo di macchie solari, o il cosiddetto Numeri di lupo. Se indichiamo con g il numero di gruppi di macchie e con f il numero totale di macchie, allora il numero di Wolf - W - è espresso dalla formula:
Questo numero, che determina la misura dell'attività di formazione delle macchie del Sole, tiene conto sia del numero di gruppi di macchie solari che del numero di macchie solari stesse osservate in un determinato giorno. Inoltre, ogni gruppo è equiparato a dieci unità e ogni punto è considerato come un'unità. Il punteggio totale della giornata - il relativo numero Wolf - è la somma di questi numeri. Diciamo che osserviamo 23 macchie sul Sole, che formano tre gruppi. Quindi il numero del Lupo nel nostro esempio sarà: W = 10 3 + 23 = 53. Durante i periodi di attività solare minima, quando non c'è una sola macchia sul Sole, diventa zero. Se si osserva una singola macchia solare sul Sole, il numero del Lupo sarà pari a 11 e nei giorni di massima attività solare a volte è superiore a 200.
La curva del numero medio mensile di macchie solari mostra chiaramente la natura della variazione dell'attività solare. Tali dati sono disponibili dal 1749 ad oggi. Una media di oltre 200 anni ha determinato che il periodo di cambiamento delle macchie solari è di 11,2 anni. È vero, negli ultimi 60 anni, il corso dell'attività di formazione di macchie della nostra stella diurna è leggermente accelerato e questo periodo è sceso a 10,5 anni. Inoltre, la sua durata varia notevolmente da ciclo a ciclo. Pertanto, non si dovrebbe parlare di periodicità dell'attività solare, ma di ciclicità. Il ciclo di undici anni è la caratteristica più importante del nostro Sole.
Avendo scoperto il campo magnetico delle macchie solari nel 1908, George Hale scoprì e la legge di alternanza della loro polarità. Abbiamo già detto che nel gruppo sviluppato ci sono due grandi punti: due grandi magneti. Hanno polarità opposta. Anche la sequenza delle polarità negli emisferi nord e sud del Sole è sempre opposta. Se nell'emisfero settentrionale il punto principale (testa) ha, ad esempio, la polarità settentrionale e il punto finale (coda) ha polarità meridionale, nell'emisfero sud della luce diurna, l'immagine sarà l'opposto: il punto principale è con polarità meridionale e il punto finale è con polarità settentrionale. Ma la cosa più notevole è che nel prossimo ciclo di 11 anni, le polarità di tutte le macchie in gruppi in entrambi gli emisferi del Sole sono invertite e, con l'inizio di un nuovo ciclo, ritornano al loro stato originale. In questo modo, ciclo magnetico solare ha circa 22 anni. Pertanto, molti astronomi solari considerano il principale ciclo di 22 anni dell'attività solare associato a un cambiamento nella polarità del campo magnetico nelle macchie solari.
È stato a lungo stabilito che con il cambiamento del numero di punti sul Sole, le aree dei siti delle torce e la potenza dei brillamenti solari cambiano. Questi e altri fenomeni che si verificano v atmosfera del Sole, ora chiamata attività solare. Il suo elemento più accessibile per le osservazioni sono i grandi gruppi di macchie solari.
Ora è il momento di rispondere forse alla domanda più intrigante: "Da dove viene l'attività solare e come spiegarne le caratteristiche?"
Poiché il campo magnetico è il fattore determinante dell'attività solare, l'emergere e lo sviluppo di un gruppo bipolare di macchie - una regione attiva sul Sole - può essere rappresentato come il risultato di una graduale ascesa nell'atmosfera solare di un enorme fascio magnetico o tubo che fuoriesce da un punto e, formando un arco, entra in un altro punto. Nel punto in cui il tubo lascia la fotosfera, c'è un punto con una polarità del campo magnetico e dove rientra nella fotosfera - con la polarità opposta. Dopo qualche tempo, questo tubo magnetico collassa e i resti della corda magnetica ricadono sotto la fotosfera e la regione attiva sul Sole scompare. In questo caso, parte delle linee del campo magnetico va nella cromosfera e nella corona solare. Qui il campo magnetico, per così dire, ordina il plasma in movimento, a seguito del quale la materia solare si muove lungo le linee del campo magnetico. Questo conferisce alla corona un aspetto radioso. Il fatto che le regioni attive del Sole siano determinate da tubi di forza magnetica non è più in dubbio tra gli scienziati. Gli effetti magnetoidrodinamici spiegano anche l'inversione della polarità del campo nei gruppi bipolari di macchie solari. Ma questi sono solo i primi passi verso la costruzione di una teoria scientificamente fondata che possa spiegare tutte le caratteristiche osservate dell'attività del grande luminare.
Numeri medi annuali di Wolf dal 1947 al 2001


fotosfera del sole
Spiegazione della presenza di regioni magnetiche bipolari sul Sole. Un enorme tubo magnetico emerge dalla zona convettiva nell'atmosfera solare
Quindi, sul Sole c'è un'eterna lotta tra le forze di pressione del gas caldo e la gravità mostruosa. E i campi magnetici aggrovigliati ostacolano le radiazioni. Nelle loro reti, le macchie sorgono e vengono distrutte. Il plasma ad alta temperatura vola verso l'alto o scivola verso il basso dalla corona lungo le linee di forza magnetiche. Dove altro puoi trovare qualcosa del genere?! Solo su altre stelle, ma sono terribilmente lontane da noi! E solo sul Sole possiamo osservare questa eterna lotta delle forze della natura, che va avanti da 5 miliardi di anni. E solo la gravità vincerà!
"Echi" di brillamenti solari
Il 23 febbraio 1956, le stazioni del Servizio del Sole notarono un potente lampo alla luce del giorno. Un'esplosione di una forza senza precedenti ha lanciato gigantesche nubi di plasma incandescente nello spazio quasi solare, ciascuna molte volte più grande della Terra! E con una velocità di oltre 1000 km / s, si sono precipitati verso il nostro pianeta. I primi echi di questa catastrofe ci raggiunsero rapidamente attraverso l'abisso cosmico. Circa 8,5 minuti dopo l'inizio dell'epidemia, un flusso notevolmente aumentato di raggi ultravioletti e raggi X ha raggiunto gli strati superiori dell'atmosfera terrestre - la ionosfera, aumentandone il riscaldamento e la ionizzazione. Ciò ha portato a un forte deterioramento e persino a una temporanea cessazione delle comunicazioni radio a onde corte, perché invece di essere riflesse dalla ionosfera, come da uno schermo, hanno iniziato ad essere intensamente assorbite da essa ...
Modifica della polarità magnetica delle macchie solari

A volte, con lampi molto forti, l'interferenza radio dura diversi giorni di seguito, fino a quando il luminare irrequieto "torna alla normalità". La dipendenza è qui tracciata così chiaramente che la frequenza di tale interferenza può essere utilizzata per giudicare il livello di attività solare. Ma le principali perturbazioni causate sulla Terra dall'attività di brillamento della stella sono avanti.
A seguito della radiazione a onde corte (ultravioletti e raggi X) del nostro pianeta, arriva un flusso di raggi cosmici solari ad alta energia. È vero, il guscio magnetico della Terra ci protegge in modo abbastanza affidabile da questi raggi mortali. Ma per gli astronauti che lavorano in spazi aperti, rappresentano un pericolo molto serio: l'esposizione può facilmente superare la dose consentita. Ecco perché circa 40 osservatori del mondo partecipano costantemente al servizio di pattugliamento del Sole: conducono osservazioni continue dell'attività di brillamento della stella diurna.
Un ulteriore sviluppo dei fenomeni geofisici sulla Terra può essere previsto in un giorno o due giorni dopo lo scoppio. È questo tempo - 30-50 ore - necessario affinché le nuvole di plasma raggiungano le "vicinanze" della terra. Dopotutto, un brillamento solare è qualcosa come un cannone spaziale che spara nello spazio interplanetario con corpuscoli - particelle di materia solare: elettroni, protoni (nuclei di atomi di idrogeno), particelle alfa (nuclei di atomi di elio). La massa di corpuscoli eruttati dall'epidemia nel febbraio 1956 ammontava a miliardi di tonnellate!
Non appena le nuvole di particelle solari si scontrarono con la Terra, gli aghi della bussola guizzarono e il cielo notturno sopra il pianeta fu decorato con lampi multicolori dell'aurora. Tra i pazienti, gli attacchi di cuore sono diventati più frequenti e il numero di incidenti stradali è aumentato.

Tipi di impatti di un brillamento solare sulla Terra
Perché ci sono tempeste magnetiche, aurora boreale... Letteralmente l'intero globo rabbrividì sotto la pressione di gigantesche nubi corpuscolari: terremoti si sono verificati in molte zone sismiche 2 . E, per così dire, per finire, la durata della giornata è cambiata bruscamente di ben 10 ... microsecondi!
La ricerca spaziale ha dimostrato che il globo è circondato da una magnetosfera, cioè un guscio magnetico; all'interno della magnetosfera, l'intensità del campo magnetico terrestre prevale sull'intensità del campo interplanetario. E affinché il bagliore abbia un impatto sulla magnetosfera terrestre e sulla Terra stessa, deve verificarsi in un momento in cui la regione attiva sul Sole si trova vicino al centro del disco solare, cioè è orientata verso il nostro pianeta. In caso contrario, tutte le radiazioni dei bagliori (elettromagnetiche e corpuscolari) si riverseranno lateralmente.
Il plasma, che si precipita dalla superficie del Sole nello spazio esterno, ha una certa densità ed è in grado di esercitare pressione su tutti gli ostacoli incontrati sul suo cammino. Un ostacolo così significativo è il campo magnetico terrestre: la sua magnetosfera. Contrasta il flusso di materia solare. Arriva il momento in cui entrambe le pressioni sono equilibrate in questo confronto. Quindi il confine della magnetosfera terrestre, compresso dal flusso di plasma solare dal lato diurno, è posto a una distanza di circa 10 raggi terrestri dalla superficie del nostro pianeta, e il plasma, incapace di muoversi dritto, inizia a fluire attorno al magnetosfera. In questo caso, le particelle della materia solare allungano le sue linee di campo magnetico e sul lato notturno della Terra (nella direzione opposta al Sole) si forma un lungo pennacchio (coda) vicino alla magnetosfera, che si estende oltre il orbita della Luna. La terra con il suo guscio magnetico è all'interno di questo flusso corpuscolare. E se il solito vento solare, che scorre costantemente intorno alla magnetosfera, può essere paragonato a una brezza leggera, allora il rapido flusso di corpuscoli generato da un potente brillamento solare è come un terribile uragano. Quando un tale uragano colpisce il guscio magnetico del globo, viene compresso ancora più fortemente dal lato del girasole e tempesta magnetica.
Pertanto, l'attività solare influisce sul magnetismo terrestre. Con il suo rafforzamento, aumenta la frequenza e l'intensità delle tempeste magnetiche. Ma questa connessione è piuttosto complessa e consiste in un'intera catena di interazioni fisiche. Il collegamento principale in questo processo è il flusso potenziato di corpuscoli che si verifica durante i brillamenti solari.
Parte dei corpuscoli energetici alle latitudini polari esce dalla trappola magnetica nell'atmosfera terrestre. E poi, ad altitudini comprese tra 100 e 1000 km, protoni ed elettroni veloci, scontrandosi con le particelle d'aria, le eccitano e le fanno brillare. Di conseguenza, c'è Luci polari.
Il periodico "risveglio" del grande luminare è un fenomeno naturale. Quindi, ad esempio, dopo un grandioso brillamento solare osservato il 6 marzo 1989, i flussi corpuscolari hanno eccitato letteralmente l'intera magnetosfera del nostro pianeta. Di conseguenza, sulla Terra scoppiò una potente tempesta magnetica. Era accompagnato da una stupefacente aurora boreale, che ha raggiunto la zona tropicale nella regione della penisola californiana! Tre giorni dopo si verificò una nuova potente epidemia e nella notte tra il 13 e il 14 marzo anche gli abitanti della costa meridionale della Crimea ammirarono gli incantevoli bagliori che si stendevano nel cielo stellato sopra i denti rocciosi di Ai-Petri. Era uno spettacolo unico, simile al bagliore di un fuoco che inghiottì immediatamente metà del cielo.
Tutti gli effetti geofisici qui menzionati - tempeste ionosferiche e magnetiche e aurore - sono parte integrante del più complesso problema scientifico chiamato il problema Sole-Terra. Tuttavia, l'influenza dell'attività solare sulla Terra non si limita a questo. Il "respiro" della luce del giorno si manifesta costantemente nei cambiamenti del tempo e del clima.
Il clima non è altro che un regime meteorologico a lungo termine in una determinata area ed è determinato dalla sua posizione geografica sul globo e dalla natura dei processi atmosferici.
Gli scienziati di Leningrado dell'Istituto di ricerca dell'Artico e dell'Antartico sono riusciti a scoprire che durante gli anni di attività solare minima prevale la circolazione dell'aria latitudinale. In questo caso, il tempo nell'emisfero settentrionale è relativamente calmo. Negli anni di massimo, invece, si intensifica la circolazione meridionale, cioè c'è un intenso scambio di masse d'aria tra le regioni tropicali e polari. Il tempo diventa instabile, ci sono deviazioni significative dalle norme climatiche a lungo termine.
Europa occidentale: isole britanniche nell'area di un forte ciclone. Girato dallo spazio

1 Tutti dovrebbero ricordare che in nessun caso dovresti guardare il Sole senza proteggerti gli occhi con filtri scuri. Quindi puoi perdere di vista all'istante
2Scienziato del ramo di Murmansk della Società Astronomica e Geodetica della Russia (il suo presidente) Viktor Evgenyevich Troshenkov ha studiato l'impatto dell'attività solare sulla tettonica del globo. La rianalisi dell'attività sismica del nostro pianeta per 230 anni (1750-1980), da lui effettuata a livello globale, ha mostrato la presenza di una relazione lineare tra la sismicità della Terra (terremoti) e le tempeste solari.
Storia di studio
Le prime notizie di macchie solari risalgono all'800 a.C. e. in Cina .
Schizzi di macchie dalla cronaca di John of Worcester
Le macchie furono tracciate per la prima volta nel 1128 nella cronaca di Giovanni di Worcester.
La prima menzione nota delle macchie solari nell'antica letteratura russa è contenuta nella Nikon Chronicle, in documenti risalenti alla seconda metà del XIV secolo:
c'era un segno in cielo, il sole era come sangue, e secondo esso i luoghi sono neri
sii un segno al sole, i luoghi sono neri al sole, come chiodi, e l'oscurità era grande
I primi studi si sono concentrati sulla natura delle macchie e sul loro comportamento. Nonostante il fatto che la natura fisica delle macchie sia rimasta poco chiara fino al 20° secolo, le osservazioni sono continuate. Nel 19° secolo c'era già una serie abbastanza lunga di osservazioni delle macchie solari per notare variazioni periodiche nell'attività del Sole. Nel 1845 D. Henry e S. Alexander (ing. S Alessandro ) dell'Università di Princeton ha condotto osservazioni del Sole utilizzando uno speciale termometro (en:thermopile) e ha determinato che l'intensità dell'emissione di macchie, rispetto alle aree circostanti del Sole, è ridotta.
emergenza
L'emergere di una macchia solare: le linee magnetiche penetrano nella superficie del Sole
Le macchie sorgono come risultato di perturbazioni in singole sezioni del campo magnetico solare. All'inizio di questo processo, i tubi del campo magnetico "sfondano" attraverso la fotosfera nella regione della corona e il campo forte sopprime il movimento convettivo del plasma nei granuli, impedendo il trasferimento di energia dalle regioni interne all'esterno in questi posti. Per prima cosa, in questo luogo appare una torcia, un po' più avanti e ad ovest, un piccolo punto chiamato è tempo, di diverse migliaia di chilometri. Nel giro di poche ore cresce il valore dell'induzione magnetica (a valori iniziali di 0,1 Tesla), aumenta la dimensione e il numero dei pori. Si fondono tra loro e formano uno o più punti. Durante il periodo di massima attività delle macchie, l'intensità dell'induzione magnetica può raggiungere 0,4 Tesla.
La durata delle macchie raggiunge diversi mesi, ovvero è possibile osservare singoli gruppi di macchie durante diverse rivoluzioni del Sole. Fu questo fatto (il movimento delle macchie osservate lungo il disco solare) che servì come base per provare la rotazione del Sole e permise di effettuare le prime misurazioni del periodo di rivoluzione del Sole attorno al suo asse.
Le macchie di solito si formano in gruppi, ma a volte c'è un singolo punto che vive solo pochi giorni, o un gruppo bipolare: due punti di diversa polarità magnetica, collegati da linee di campo magnetico. Il punto occidentale in un tale gruppo bipolare è chiamato "leader", "head" o "P-spot" (dall'inglese. precedente), orientale - "slave", "tail" o "F-spot" (dall'inglese. a seguire).
Solo la metà degli spot vive più di due giorni e solo un decimo - più di 11 giorni.
All'inizio del ciclo di 11 anni di attività solare, le macchie sul Sole compaiono ad alte latitudini eliografiche (dell'ordine di ±25-30°) e con il progredire del ciclo le macchie migrano verso l'equatore solare, raggiungendo latitudini di ±5-10° a fine ciclo. Questo modello è chiamato "legge di Spörer".
I gruppi di macchie solari sono orientati approssimativamente parallelamente all'equatore solare, tuttavia vi è una certa inclinazione dell'asse del gruppo rispetto all'equatore, che tende ad aumentare per i gruppi situati più lontano dall'equatore (la cosiddetta "legge di Joy").
Proprietà
La temperatura media della superficie del Sole è di circa 6000 K (la temperatura effettiva è 5770 K, la temperatura di radiazione è 6050 K). L'area centrale, più scura, delle macchie ha una temperatura di soli 4000 K circa, le aree esterne delle macchie che confinano con la superficie normale vanno da 5000 a 5500 K. Nonostante la temperatura delle macchie sia inferiore, la loro sostanza emette ancora luce, anche se in misura minore rispetto al resto della superficie. È a causa di questa differenza di temperatura che quando osservate, si ha l'impressione che le macchie siano scure, quasi nere, sebbene in realtà splendano anche, ma il loro bagliore si perde sullo sfondo di un disco solare più luminoso.
La parte scura centrale della macchia è chiamata ombra. Di solito il suo diametro è di circa 0,4 del diametro del punto. All'ombra, l'intensità del campo magnetico e la temperatura sono abbastanza uniformi e l'intensità del bagliore nella luce visibile è del 5-15% della magnitudine fotosferica. L'ombra è circondata da penombra, costituita da fibre radiali chiare e scure con un'intensità luminosa dal 60 al 95% di quella fotosferica.
La superficie del Sole nell'area in cui si trova lo spot si trova a circa 500-700 km al di sotto della superficie della fotosfera circostante. Questo fenomeno è chiamato depressione wilsoniana.
Le macchie solari sono le aree di maggiore attività sul Sole. Se ci sono molti punti, allora c'è un'alta probabilità che le linee magnetiche si ricolleghino: le linee che passano all'interno di un gruppo di punti si ricombinano con le linee di un altro gruppo di punti che hanno polarità opposta. Il risultato visibile di questo processo è un brillamento solare. Un'esplosione di radiazioni, che raggiunge la Terra, provoca forti disturbi nel suo campo magnetico, interrompe il funzionamento dei satelliti e colpisce persino oggetti situati sul pianeta. A causa delle violazioni del campo magnetico terrestre, aumenta la probabilità di aurora boreale a basse latitudini geografiche. Anche la ionosfera terrestre è soggetta alle fluttuazioni dell'attività solare, che si manifesta in un cambiamento nella propagazione delle onde radio corte.
Classificazione
I punti sono classificati in base alla durata della vita, alle dimensioni, alla posizione.
Fasi di sviluppo
L'aumento locale del campo magnetico, come accennato in precedenza, rallenta il movimento del plasma nelle celle di convezione, rallentando così il trasferimento di calore alla superficie del Sole. Il raffreddamento dei granuli interessati da questo processo (di circa 1000 °C) porta al loro scurimento e alla formazione di un'unica macchia. Alcuni di loro scompaiono dopo pochi giorni. Altri si sviluppano in gruppi bipolari di due punti con linee magnetiche di polarità opposta. Da loro possono formarsi gruppi di molti spot, che, in caso di un ulteriore aumento dell'area penombra uniscono fino a centinaia di punti, raggiungendo dimensioni di centinaia di migliaia di chilometri. Dopo questo, c'è una lenta (per diverse settimane o mesi) diminuzione dell'attività delle macchie e la loro dimensione si riduce a piccoli punti doppi o singoli.
I gruppi di macchie solari più grandi hanno sempre un gruppo associato nell'altro emisfero (nord o sud). Le linee magnetiche in questi casi escono da punti in un emisfero ed entrano in punti nell'altro.
Dimensioni dei gruppi di spot
La dimensione di un gruppo di macchie è solitamente caratterizzata dalla sua estensione geometrica, nonché dal numero di macchie incluse in esso e dalla loro area totale.
In un gruppo possono esserci da uno a un centinaio e mezzo o più punti. Le aree del gruppo, che sono convenientemente misurate in milionesimi dell'area dell'emisfero solare (m.s.p.), variano da diversi m.s.p. fino a diverse migliaia di m.s.p.
L'area massima per l'intero periodo di osservazione continua dei gruppi di macchie solari (dal 1874 al 2012) aveva il gruppo n. 1488603 (secondo il catalogo di Greenwich), apparso sul disco solare il 30 marzo 1947, al massimo del 18 Ciclo di 11 anni di attività solare. Entro l'8 aprile, la sua superficie totale ha raggiunto 6132 m.s.p. (1,87 10 10 km², che è più di 36 volte l'area del globo). Nella fase del suo massimo sviluppo, questo gruppo era composto da più di 170 singole macchie solari.
ciclicità
Il ciclo solare è correlato alla frequenza delle macchie solari, alla loro attività e durata. Un ciclo copre circa 11 anni. Durante i periodi di minima attività delle macchie solari, le macchie solari sono pochissime o del tutto assenti, mentre durante i periodi di massima possono essercene diverse centinaia. Alla fine di ogni ciclo, la polarità del campo magnetico solare si inverte, quindi è più corretto parlare di ciclo solare di 22 anni.
Durata del ciclo
Sebbene il ciclo medio di attività solare duri circa 11 anni, ci sono cicli da 9 a 14 anni. Anche le medie cambiano nel corso dei secoli. Pertanto, nel 20° secolo, la durata media del ciclo era di 10,2 anni.
La forma del ciclo non è costante. L'astronomo svizzero Max Waldmeier ha affermato che il passaggio dall'attività solare minima a quella massima avviene più velocemente, maggiore è il numero massimo di macchie solari registrate in questo ciclo (la cosiddetta "regola di Waldmeier").
Inizio e fine ciclo
In passato, l'inizio del ciclo era considerato il momento in cui l'attività solare era al suo punto minimo. Grazie ai moderni metodi di misurazione, è diventato possibile determinare il cambiamento nella polarità del campo magnetico solare, quindi ora il momento del cambiamento nella polarità dei punti viene preso come inizio del ciclo.
La numerazione dei cicli è stata proposta da R. Wolf. Il primo ciclo, secondo questa numerazione, iniziò nel 1749. Nel 2009 è iniziato il 24° ciclo solare.
- Dati dell'ultima riga - previsione
Vi è una variazione periodica del numero massimo di macchie solari con un periodo caratteristico di circa 100 anni ("ciclo secolare"). Gli ultimi minimi di questo ciclo furono intorno al 1800-1840 e al 1890-1920. C'è un'ipotesi sull'esistenza di cicli di durata ancora maggiore.
Guarda anche
Appunti
Collegamenti
Animazioni-schemi del processo di origine delle macchie solari
- United Database of Sunspot Magnetic Fields - include immagini di macchie solari del periodo 1957-1997
- Immagini delle macchie solari dall'Osservatorio Monti di Locarno - copre il periodo 1981-2011
- Fisica spaziale. Piccola Enciclopedia M.: Enciclopedia sovietica, 1986
- come si formano le macchie solari? (Come si formano le macchie solari?)
Il Sole Struttura Nucleo · Zona di trasferimento radiante · zona convettiva Atmosfera Fotosfera · Cromosfera · corona solare Esteso
strutturaEliosfera (foglio corrente eliosferica · confine dell'onda d'urto) · mantello eliosferico · eliopausa · onda d'urto di prua relativo al sole
fenomeniEclissi solare · Attività solare ( macchie solari · brillamenti solari · eiezioni di massa coronale) · Radiazione solare (Variazioni della radiazione solare) · fori coronali · Anse coronali · torce · Granuli · flocculi · Protuberanze e fibre · Spicole · Supergranulazione · vento soleggiato · Onda mortale argomenti correlati sistema solare · dinamo solare · Evoluzione stellare
Come, ad esempio, a metà dell'ultimo millennio. Ogni abitante del nostro pianeta è consapevole che sulla principale fonte di calore e luce ci sono piccoli oscuramenti difficili da vedere senza dispositivi speciali. Ma non tutti sanno il fatto che sono loro che portano a che possono influenzare notevolmente il campo magnetico terrestre.
Definizione
In parole povere, le macchie solari sono macchie scure che si formano sulla superficie del Sole. È un errore credere che non emettano luce intensa, ma rispetto al resto della fotosfera sono davvero molto più scuri. La loro caratteristica principale è la bassa temperatura. Pertanto, le macchie solari sul Sole sono più fresche di circa 1500 Kelvin rispetto alle altre aree circostanti. In effetti, sono le stesse aree attraverso le quali i campi magnetici vengono in superficie. Grazie a questo fenomeno, possiamo parlare di un processo come l'attività magnetica. Di conseguenza, se ci sono pochi punti, questo è chiamato periodo tranquillo e quando ce ne sono molti, tale periodo sarà chiamato attivo. Durante quest'ultimo, il bagliore del Sole è leggermente più luminoso a causa delle torce e dei flocculi situati intorno alle aree scure.

Studio di
L'osservazione delle macchie solari va avanti da molto tempo, le sue radici risalgono all'era aC. Quindi, Teofrasto d'Aquino nel IV secolo a.C. e. menzionato la loro esistenza nelle sue opere. Il primo schizzo di oscuramento sulla superficie della stella principale fu scoperto nel 1128, appartiene a John Worcester. Inoltre, nelle antiche opere russe del XIV secolo vengono menzionate le macchie solari nere. La scienza iniziò rapidamente a studiarli nel 1600. La maggior parte degli scienziati di quel periodo aderiva alla versione secondo cui le macchie solari sono pianeti che si muovono attorno all'asse del Sole. Ma dopo l'invenzione del cannocchiale da parte di Galileo, questo mito fu sfatato. Fu il primo a scoprire che le macchie sono parte integrante della struttura solare stessa. Questo evento ha dato origine a una potente ondata di ricerche e osservazioni che da allora non si sono fermate. Lo studio moderno è sorprendente nella sua portata. Per 400 anni, i progressi in quest'area sono diventati tangibili e ora l'Osservatorio reale belga sta contando il numero di macchie solari, ma la rivelazione di tutti gli aspetti di questo fenomeno cosmico è ancora in corso.

Aspetto esteriore
Anche a scuola ai bambini viene raccontata l'esistenza di un campo magnetico, ma di solito viene menzionata solo la componente poloidale. Ma la teoria delle macchie solari prevede anche lo studio di un elemento toroidale, ovviamente stiamo già parlando del campo magnetico del Sole. Vicino alla Terra, non può essere calcolato, poiché non appare in superficie. Un'altra situazione è con il corpo celeste. In determinate condizioni, il tubo magnetico fuoriesce attraverso la fotosfera. Come hai intuito, questa espulsione provoca la formazione di macchie solari sulla superficie. Molto spesso ciò accade in massa, motivo per cui i gruppi di macchie di gruppo sono più comuni.

Proprietà
In media raggiunge i 6000 K, mentre per gli spot si aggira sui 4000 K. Questo però non impedisce loro di produrre comunque una potente quantità di luce. Le macchie solari e le regioni attive, cioè i gruppi di macchie solari, hanno vite diverse. Il primo live da un paio di giorni a diverse settimane. Ma questi ultimi sono molto più tenaci e possono rimanere nella fotosfera per mesi. Per quanto riguarda la struttura di ogni singolo spot, sembra essere complicata. La sua parte centrale è chiamata ombra, che esternamente sembra monofonica. A sua volta, è circondato da penombra, che si distingue per la sua variabilità. Come risultato del contatto tra un plasma freddo e uno magnetico, si notano fluttuazioni di materia su di esso. Le dimensioni delle macchie solari, così come il loro numero in gruppi, possono essere molto diverse.

Cicli di attività solare
Tutti sanno che il livello è in continua evoluzione. Questa disposizione ha portato all'emergere del concetto di ciclo di 11 anni. Le macchie solari, il loro aspetto e il loro numero sono strettamente correlati a questo fenomeno. Tuttavia, questa domanda rimane controversa, poiché un ciclo può variare da 9 a 14 anni e il livello di attività cambia inesorabilmente di secolo in secolo. Pertanto, possono esserci periodi di calma, in cui i punti sono praticamente assenti per più di un anno. Ma può succedere anche il contrario, quando i loro numeri sono considerati anormali. In precedenza, il conto alla rovescia dell'inizio del ciclo iniziava dal momento della minima attività solare. Ma con l'avvento delle tecnologie migliorate, il calcolo viene effettuato dal momento in cui cambia la polarità degli spot. I dati sulle attività solari passate sono disponibili per lo studio, ma è improbabile che siano l'assistente più fedele nella predizione del futuro, perché la natura del Sole è molto imprevedibile.

Impatto sul pianeta
Non è un segreto che il Sole interagisca a stretto contatto con la nostra vita quotidiana. La Terra è costantemente esposta agli attacchi di vari irritanti dall'esterno. Dai loro effetti distruttivi, il pianeta è protetto dalla magnetosfera e dall'atmosfera. Ma, sfortunatamente, non riescono a resistergli del tutto. Pertanto, i satelliti possono essere disabilitati, le comunicazioni radio vengono interrotte e gli astronauti sono esposti a un pericolo maggiore. Inoltre, le radiazioni influenzano i cambiamenti climatici e persino l'aspetto umano. C'è un tale fenomeno come le macchie solari sul corpo che appaiono sotto l'influenza delle radiazioni ultraviolette.

Questo problema non è stato ancora adeguatamente studiato, così come l'impatto delle macchie solari sulla vita quotidiana delle persone. Un altro fenomeno che dipende dalle perturbazioni magnetiche può essere chiamato Le tempeste magnetiche sono diventate una delle conseguenze più famose dell'attività solare. Rappresentano un altro campo esterno attorno alla Terra, che è parallelo alla costante. Gli scienziati moderni associano persino l'aumento della mortalità, così come l'esacerbazione delle malattie del sistema cardiovascolare, alla comparsa di questo stesso campo magnetico. E tra la gente cominciò anche gradualmente a trasformarsi in superstizione.