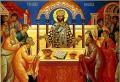Caratteristiche linguistiche dello stile conversazionale. Confronto dello stile di discorso conversazionale con altri stili
Un'atmosfera informale, rilassata e rilassata è tipica del discorso quotidiano. Le caratteristiche specifiche dello stile colloquiale di solito si manifestano più chiaramente quando parliamo di oggetti, situazioni e argomenti rilevanti nell'uso quotidiano. Nella comunicazione conversazionale prevale un tipo di pensiero speciale e quotidiano. Il discorso colloquiale occupa una posizione eccezionale nel sistema della moderna lingua russa. Questo è lo stile originale e originale della lingua nazionale, mentre tutti gli altri sono fenomeni di formazione secondaria successiva. Il discorso colloquiale era spesso caratterizzato come vernacolare, considerato al di fuori del quadro della lingua letteraria. In realtà, è un tipo di lingua letteraria.
Lo stile di conversazione è in contrasto con gli stili di libro. Forma un sistema che presenta caratteristiche a tutti i livelli della struttura linguistica: fonetica, vocabolario, fraseologia, formazione delle parole, morfologia e sintassi.
Lo stile colloquiale trova la sua espressione sia in forma scritta che orale.
"Il discorso colloquiale è caratterizzato da condizioni operative speciali, che includono: l'assenza di pensiero preliminare sull'enunciazione e la relativa mancanza di selezione preliminare del materiale linguistico, l'immediatezza della comunicazione verbale tra i suoi partecipanti, la facilità dell'atto linguistico associato al mancanza di formalità nei rapporti tra loro e nella natura dell'enunciato. Un ruolo importante è giocato dalla situazione (l’ambiente della comunicazione verbale) e dall’uso di mezzi extralinguistici (espressioni facciali, gesti, reazione dell’interlocutore). Le caratteristiche puramente linguistiche del linguaggio quotidiano includono l'uso di mezzi extralessicali come l'intonazione frasale, lo stress emotivo ed espressivo, le pause, la velocità del discorso, il ritmo, ecc. Nel linguaggio quotidiano c'è un ampio uso del vocabolario e della fraseologia quotidiana, del vocabolario espressivo-emotivo (comprese particelle, interiezioni), diverse categorie di parole introduttive, originalità della sintassi (frasi ellittiche e incomplete di vario tipo, parole di indirizzo, parole di frasi , ripetizioni di parole, rottura di frasi con costruzioni inserite, indebolimento e interruzione di forme di connessione sintattica tra parti di un'affermazione, costruzioni di collegamento, ecc.).
Oltre alla sua funzione diretta - un mezzo di comunicazione, il discorso colloquiale svolge anche altre funzioni nella narrativa, ad esempio viene utilizzato per creare un ritratto verbale, per una rappresentazione realistica della vita di un particolare ambiente, nella narrazione dell'autore serve come mezzo di stilizzazione e quando entra in collisione con elementi del discorso del libro può creare un effetto comico.
§ 2. Caratteristiche linguistiche dello stile conversazionale
Pronuncia. Spesso le parole e le forme nello stile colloquiale hanno un'enfasi che non coincide con l'enfasi negli stili di discorso più severi: DO parlare(cfr.: normativa Grandi danesiO R).
Vocabolario. Il vocabolario colloquiale e quotidiano, essendo parte del vocabolario del discorso orale, è utilizzato in conversazioni informali ed è caratterizzato da varie sfumature di colorazione espressiva.
Questi includono:
Nomi: bugie, sciocchezze, dispettosi, bravo ragazzo, trambusto, sciocchezze e così via.;
Aggettivi nominali: meticoloso, sofisticato, laborioso, negligente e così via.;
Verbi: essere sarcastico, essere avido, essere riservato, essere malato, chiacchierare, disturbare e così via.;
avverbi: ecco fatto, in silenzio, perdutamente, istantaneamente, poco a poco, lentamente, completamente e così via.
Esistono anche pronomi colloquiali (una specie di), sindacati (una volta - nel significato Se), parti (forse laggiù nel senso che è improbabile Lee), METODI INTERMEDI (beh, eh).
La fraseologia occupa un posto significativo nel discorso quotidiano. Ciò è dovuto al predominio di un modo di pensare specifico nella sfera della comunicazione quotidiana. Il pensiero concreto non rifugge dall’astrazione. Una persona generalizza le sue osservazioni specifiche, evidenziando qualcosa di significativo e astraendo da alcuni particolari. Ad esempio: no fumare senza fuoco. Non puoi nascondere una cucitura in una borsa. Il leopardo cambia le sue macchie. Per me la matematica è una foresta oscura. Più silenzioso dell'acqua, sotto l'erba. Invece di dire Vivono in modo ostile, litigano - Dicono: Masticano come cani.
La fraseologia colloquiale è il grande custode della forma tradizionale. Memorizza molte unità fraseologiche sorte nei tempi antichi.
Formazione delle parole. Nella categoria dei sostantivi, i seguenti suffissi vengono utilizzati con un grado maggiore o minore di produttività, conferendo alle parole un carattere colloquiale:
- ak (-yak) - di buon carattere, sano, sempliciotto;
- un (-yan) - rude, vecchio;
- ah - uomo barbuto;
"- cenere - commerciante;
- aka (-yak-a) per parole di genere generale: festaiolo, prepotente, spettatore;
- szhk-a- condividere, stipare, nutrire;
En è un tesoro;
- la-a- magnate, delinquente, crammer;
- n-io- confusione, litigi;
- rel-i - correre in giro, sporcarsi;
- tai- pigro, sciatto;
- un - chiacchierone, chiacchierone, urlatore;
- uh-ah - sporco, grasso;
- sì - sciocco, nudo, forte, bambino;
- yag-a - poveretto, gran lavoratore, gran lavoratore.
Il vocabolario colloquiale include anche parole con il suffisso - merda, che denota le donne in base alla professione, alla posizione ricoperta, al lavoro svolto, all'occupazione, ecc .: direttore, segretario, bibliotecario, cassiere.
Nella maggior parte dei casi, i suffissi di valutazione soggettiva conferiscono alle parole una colorazione colloquiale: ladro, ragazza cattiva, casetta; sporco, barba; enorme, furioso; la sera, in un sussurro eccetera.
Per gli aggettivi di natura colloquiale si può notare l'uso del suffisso -ast-: con gli occhi grandi, con i denti, con la lingua e così via.; così come i prefissi pre-: gentile, simpatico, molto sgradevole e così via.
Molti verbi in -nitchit appartengono al vocabolario colloquiale quotidiano: comportarsi male, vagare, imbrogliare.
Caratteristiche morfologiche del discorso colloquiale sono caratterizzati da quanto segue:
Forma preposizionale dei sostantivi: Sono in vacanza, in officina (cfr.: in vacanza, in officina);
Forma nominativo plurale: accordi, settori (cfr.: accordi, settori);
Genitivo plurale: arancia, pomodoro (cfr.: arance, pomodori);
Versione colloquiale dell'infinito: vedere, udire (cfr.: vedere, udire).
Caratteristiche sintattiche del discorso colloquiale sono davvero unici. Questo:
Uso predominante della forma dialogica;
Predominanza di frasi semplici; Tra quelli complessi, vengono più spesso utilizzati i composti composti e non sindacali;
Ampio uso di frasi interrogative ed esclamative;
Uso di parole-frasi (affermativa, negativa, incentivante, ecc.);
Ampio uso di frasi incomplete;
Interruzioni nel discorso causate da vari motivi (eccitazione di chi parla, passaggio inaspettato da un pensiero all'altro, ecc.);
Usare parole e frasi introduttive di significati diversi;
L'uso di costruzioni plug-in che spezzano la frase principale e introducono in essa informazioni aggiuntive, commenti, chiarimenti, spiegazioni, modifiche, ecc.;
Uso diffuso di interiezioni emotive e imperative;
Ripetizioni lessicali: - Sì sì sì.
- inversioni di vario genere per enfatizzare il ruolo semantico della parola evidenziata nel messaggio: Mi piacciono di più le scarpe bianche;
- forme particolari del predicato.
Nel discorso colloquiale ci sono frasi complesse, parti delle quali sono collegate da mezzi lessicali-sintattici: nella prima parte ci sono parole valutative - ben fatto, intelligente, stupido ecc., e la seconda parte serve da motivazione per questa valutazione: Bravo ad alzarti in piedi.
Prova domande e compiti
Esercizio 1.
Determina a quali stili appartengono questi testi.
Un temporale è un fenomeno atmosferico costituito da scariche elettriche tra le nubi (fulmini e tuoni), accompagnate da pioggia, grandine e violente raffiche di vento.
- Che temporale! È spaventoso andare alla finestra.
Sì, non c'era una tempesta come questa da molto tempo.
Riesci a immaginare di ritrovarti in un campo durante un temporale simile...
3. Un forte vento cominciò improvvisamente a ruggire in alto, gli alberi iniziarono a prendere una tempesta, grandi gocce di pioggia colpirono improvvisamente, schizzarono sulle foglie, lampeggiarono fulmini e scoppiò un temporale. (I. Turgenev).
Compito2.
Determina il tuo stile di conversazione. Indicare le caratteristiche linguistiche dello stile conversazionale.
Ehi, buon uomo! - gli gridò il cocchiere. - Dimmi, sai dov'è la strada?
La strada è qui; Sono su un terreno solido. - rispose il roadie, - qual è il punto?
Ascolta, ometto,” gli dissi, “conosci questa parte? Ti impegni a portarmi al mio alloggio per la notte? (A. Pushkin).
Compito 3.
Quali mezzi linguistici rendono emozionale il testo?
Riguardava l'albero di Natale. La madre ha chiesto un'ascia al guardiano, ma lui non le ha risposto, si è messo sugli sci ed è andato nel bosco. Mezz'ora dopo ritornò.
OK! Anche se i giocattoli non erano molto eleganti, anche se le lepri di straccio sembravano gatti, anche se le bambole si somigliavano tutte - con il naso dritto e gli occhi sporgenti - e, infine, c'erano pigne di abete avvolte in carta argentata, ma un albero di Natale del genere a Mosca, ovviamente, nessuno ce l'aveva. Era una vera bellezza della taiga: alta, spessa, dritta, con rami divergenti alle estremità come stelle.
(A. Gaidar).
Compito 4.
Determinare l'originalità stilistica e semantica delle parole evidenziate.
1. Con questo suo diploma è completamente arrivato. 2. Per cosa sei qui? bazar organizzato? 3. Verrò da te la sera Darò un'occhiata. 4. Non andrò davanti a nessuno arco! 5. Anche il bambino ha bisogno del suo angolo Avere. 6. A proposito, è una figura al lavoro.
Esercizio 5.
Scopri il significato delle metafore colloquiali.
1. Perché sei seduto? gonfiato? Di cosa non sei soddisfatto?
2. È necessario che sia il caposquadra a trentadue denti un ragazzo in modo che potesse parlare con i suoi superiori e fornitori, e rassicurare i suoi stessi compagni.
3. In una famiglia non succede quasi mai nulla liscio. Nadya è offesa dal suo Peter, ma lei stessa ha lo stesso carattere - non zucchero.
4. Se non sviluppi la volontà in te stesso fin dall'infanzia, crescerai non come un uomo, ma come uno straccio.
5. Ora è così ossessionato da questo problema che costringerlo a fare qualcos'altro è completamente inutile.
Compito 6.
Abbina i significati delle parole evidenziate. Determina quali sono stilisticamente neutri e quali sono colloquiali.
1. Nikolai durante l'infanzia era molto balbettò. Della pesca, dimmi tu non balbettare.
2. Sotto cotone idrofilo una coperta ti farà dormire caldo. Cosa stai facendo oggi cotone una sorta.
3. Era addirittura innamorato di me abbinato Mi stanno corteggiando un caposquadra nella nostra officina.
Compito 7. Determina quale dei due sinonimi è neutro e quale è colloquiale.
1. Anche il controllore, carissimi, ha un compito difficile: in primo luogo, clandestino trovare il passeggero e, in secondo luogo, costringerlo a pagare una multa. Oggi non mi sono messo la giacca, ma i soldi erano ancora lì. Beh, dovevo andare a lavorare lepre andare - non c'era tempo per tornare.
2. - Come hai trascorso le vacanze? - Sono andato al fiume Oka, vivevamo nel villaggio. Tutto il giorno andato attraverso la foresta. Oh, che bello! Oggi è mezzogiorno penzolava acquistare regali. Le persone prima delle vacanze - Dio non voglia!
3. - Beh, dimmi onestamente: lo sei ho avuto i piedi freddi Poi? Dimmi onestamente. Beh, ovviamente ero un po' spaventato. E se fossi in me non hai avuto i piedi freddi?
4. Distribuzione di libri dispone Valentina Vasilyevna, dovresti contattarla. - Chi ti sta facendo i test qui? comandi?
Compito 8. Determina il significato delle parole evidenziate.
Mi sveglio la mattina, qualcuno balla-balla sul vetro. 2. C'erano delle torte qui nel frigorifero. E le torte Ciao ciao. 3. Bene, penso che ora mi siederò e studierò. E qui - ding. - Arriva Vovka. 4. - Irina a casa? - Cosa tu! Sono venuto, ho mangiato, mi sono cambiato e whoops! - E Zhenya nuota - oh-oh-oh! Almeno iscrivilo alla squadra di soccorso.
Compito 9 . Spiega il significato delle espressioni evidenziate.
Tu ed io, Artem, nessun paletto, nessun cortile. Alla vicina grande stazione, operai fatto il porridge. Grishutka a questi contrabbandieri mi si fermò sulla gola. Scomparve come se fosse sprofondato nell'acqua. stavo cercando fino al settimo sudore. "È caduto all'improvviso" - Disse Rita ridendo. Di notte lui completamente esaurito. Caso non vale niente. Sono in queste cose uccello colpito. Dimmi, Cvetaev, perché sei tu hai un dente su di me?
Compito 10 . Spiegare il significato delle seguenti unità fraseologiche. In caso di difficoltà, consultare un dizionario fraseologico.
Essere al settimo cielo; non credere ai propri occhi; camminare sulle zampe posteriori; apri la bocca; congelare sul posto; sia il nostro che il tuo; taci come un pesce; andare in giro per circa; dal piccolo al grande; giocare al gatto e al topo; uscire asciutti dall'acqua; condurre una vita da cane e gatto; scritto in bianco e nero; la casa è una tazza piena; i polli non mangiano soldi; solo il latte d'uccello non è sufficiente.
Compito 11 . Annota le unità fraseologiche con la parola occhio. Seleziona unità fraseologiche simili dalla tua lingua madre.
Non distogliere lo sguardo; mangiare con gli occhi; sbatti gli occhi; non riesco a chiudere gli occhi; gettare fumo negli occhi a qualcuno; chiudi (a cosa), apri gli occhi (a chi, cosa); parla ai tuoi occhi; parla alle tue spalle; parlare faccia a faccia; hai bisogno di un occhio e di un occhio; fare a occhio; visione offuscata; girare davanti agli occhi; dagli occhi cadevano scintille; nascondi i tuoi occhi; vai ovunque i tuoi occhi ti conducano; non credere ai tuoi occhi; la paura ha gli occhi grandi.
Compito 12 . Sostituisci le combinazioni evidenziate con unità fraseologiche con la parola occhio.
Queste mele mi sono state spedite ieri dalla Georgia... straordinaria bellezza! 2. Io e il mio amico stiamo facendo intarsi in legno. Ma in modi diversi. Calcola tutto, copia il disegno e poi seleziona esattamente l'albero. E io - senza calcoli precisi. Di conseguenza: lo invidio, lui invidia me. 3. Sergei dovrebbe venire da me adesso. Ti offenderai se andiamo direttamente in camera mia? Dobbiamo davvero parlare solo. 4. Qualcosa Ivan per noi non viene da molto tempo. Forse è andato da qualche parte? 5. Quell'armadio è l'intera stanza. bottino - In un certo senso mi dispiace per lui: ci siamo abituati, è come se fosse un membro della famiglia. 6. Penso: cosa sta cercando di fare Frolov? non uscire con qualcuno Me. E se si incontra, cerca di non farlo Aspetto su di me. Bene, poi è venuto lui stesso e ha raccontato tutto onestamente.
Compito 13.
Nomina unità fraseologiche colloquiali con parole che conosci testa, mani, lingua eccetera. Seleziona unità fraseologiche simili dalla tua lingua madre.
Compito 14.
Usando i suffissi -UN/UN-ya, -UH-a, -USH-a, -USHK-a, -L-a (-LK-a), -K-a, -G-a, -IK, formano nomi colloquiali con il significato " nome di persona basato su una caratteristica eccessivamente manifesta”.
Vantarsi, lamentarsi, camminare, lavorare, sbadigliare, piagnucolare, piagnucolare, chiacchierare.
Compito 15.
Utilizzando i suffissi (-я) Г-а, -УЛ-я, (-я) K (-yak), -YSH, - CHAK, -ACH, ON-ya, -IK, -ITs-a, formano dalla seguono aggettivi sostantivi colloquiali con il significato generale di “nome di persona basato su una caratteristica fortemente manifestata”.
Modesto, sporco, grasso, sano, forte, gentile, allegro, abile, nudo, silenzioso, pulito, stupido, intelligente.
Compito 16.
Spiega da quali parole si formano questi verbi colloquiali.
Essere ozioso, essere franco, essere cauto, essere liberale, essere alla moda, essere modesto, essere capriccioso, essere delicato, essere pigro.
Compito 17.
Determina dal contesto quali sfumature semantiche e stilistiche ha ciascuno dei nomi evidenziati.
1. Alessandro! Sei già maggiorenne e ho intenzione di parlarti come da uomo a uomo. 2. Sasha, ascolti quello che ti dice tuo padre, lui si preoccupa per te e conosce la vita meglio di te. 3. Sasha! Non disturbarmi, non hai questioni urgenti in questo momento. Allora vieni con noi. 4. Ahh, Sashok! Avanti, fratello, entra, stavano proprio parlando di te. Giusto in tempo per il tè. 5. Sasenka, Dovresti riposarti un po'. Vai figliolo, fai una passeggiata all'aria aperta.
Compito 18.
Prova a ricostruire la forma completa delle seguenti frasi colloquiali. Campione: No visto con un passeggino? - Non ho visto donna con bambino passeggino?
1. Hai medicine per la tosse?
2. Con balconi verdi: è tuo?
3. Sono le due e trenta e un bagel?
4. Dietro di me c'è una donna con gli occhiali e un bambino.
5. Non sei venuto qui con una pelliccia grigia?
6. In veste blu, flirta sempre con lui.
Compito 19.
Annota queste combinazioni in due colonne: a sinistra - stilisticamente neutra, a destra - stilisticamente marcata (cioè colloquiale)
Discesa ripida, temperamento ripido; famiglia, bambino domestico; sventola un fazzoletto, saluta fuori città; scivola giù per il pendio, scivola giù per i due; gloria in battaglia, ragazza in battaglia; aggrappati, città, aggrappati ad una sedia; arrampicarsi su un albero, entrare in una storia stupida.
Compito 20.
Sostituisci le unità fraseologiche con sinonimi o combinazioni libere.
Lei e sua suocera vivono in perfetta armonia, lei è solo fortunata con sua suocera. 2. Non faccio boom-boom in questi tavoli. 3. Non preoccuparti! Li accetteremo con onore. 4. Non sapevano che sarebbero venuti qui per lavorare e non per un picnic? Se non vogliono funzionare correttamente, buona liberazione! 5. Non spiegarmelo, è da molto tempo che per me è come fare due più due. 6. – Kostya non si annoia lì? - Cosa tu! Lui e Petka sono come l'acqua, non ha tempo per pensare a noi.
Lo stile conversazionale, come una delle varietà del linguaggio letterario, serve la sfera della comunicazione casuale tra le persone nella vita di tutti i giorni, in famiglia, nonché la sfera delle relazioni informali nella produzione, nelle istituzioni, ecc.
La principale forma di attuazione dello stile conversazionale è il discorso orale, sebbene possa manifestarsi anche in forma scritta (lettere amichevoli informali, appunti su argomenti quotidiani, voci di diario, osservazioni di personaggi nelle opere teatrali, in alcuni generi di narrativa e letteratura giornalistica). . In tali casi, vengono registrate le caratteristiche della forma del discorso orale.
Le principali caratteristiche extralinguistiche che determinano la formazione di uno stile conversazionale sono: facilità (possibile solo nei rapporti informali tra parlanti e in assenza di un atteggiamento verso un messaggio di carattere ufficiale), spontaneità e impreparazione della comunicazione. Sia l'emittente del discorso che il suo destinatario partecipano direttamente alla conversazione, spesso scambiandosi i ruoli; i rapporti tra loro si stabiliscono nell'atto stesso del discorso. Tale discorso non può essere pre-pensato; la partecipazione diretta del destinatario e del destinatario ne determina la natura prevalentemente dialogica, sebbene sia possibile anche un monologo.
Un monologo in stile colloquiale è una forma di racconto casuale su alcuni eventi, qualcosa visto, letto o ascoltato ed è rivolto a un ascoltatore specifico (ascoltatori) con il quale chi parla deve stabilire un contatto. L'ascoltatore reagisce naturalmente alla storia, esprimendo accordo, disaccordo, sorpresa, indignazione, ecc. o chiedere qualcosa all'oratore. Pertanto, un monologo nel discorso parlato non è così chiaramente opposto al dialogo come nel discorso scritto.
Una caratteristica del discorso colloquiale è l'emotività, l'espressività e la reazione valutativa. Sì, alla domanda Ha scritto! invece di No, non hanno scritto di solito seguito da risposte emotivamente espressive come Dove lo hanno scritto? O Direttamente¾ scritto!; Dove hanno scritto!; Questo è quello che hanno scritto!; È facile a dirsi¾ scritto! e così via.
Un ruolo importante nella lingua parlata è giocato dall'ambiente della comunicazione verbale, dalla situazione, nonché dai mezzi di comunicazione non verbale (gesti, espressioni facciali, natura della relazione tra gli interlocutori, ecc.).
Le caratteristiche extralinguistiche dello stile conversazionale sono associate alle sue caratteristiche linguistiche più generali, come la standardità, l'uso stereotipato dei mezzi linguistici, la loro struttura incompleta a livello sintattico, fonetico e morfologico, l'intermittenza e l'incoerenza del discorso da un punto di vista logico, connessioni sintattiche indebolite tra parti dell'enunciato o loro mancanza di formalità , interruzioni di frasi con vari tipi di inserimenti, ripetizioni di parole e frasi, uso diffuso di mezzi linguistici con una pronunciata colorazione emotivo-espressiva, attività di unità linguistiche con un significato specifico e passività di unità con significato astratto-generalizzato.
Il discorso colloquiale ha le sue norme, che in molti casi non coincidono con le norme del discorso librario registrate nei dizionari, nei libri di consultazione e nelle grammatiche (codificate). Le norme del discorso colloquiale, a differenza dei libri, sono stabilite dall'uso (consuetudine) e non sono supportate consapevolmente da nessuno. Tuttavia, i madrelingua li percepiscono e percepiscono come un errore qualsiasi deviazione immotivata da essi. Ciò ha permesso ai ricercatori (O.B. Sirotinina, A.N. Vasilyeva, N.Yu. Shvedova, O.A. Lapteva, ecc.) di affermare che il discorso colloquiale russo moderno è standardizzato, sebbene le norme in esso contenute siano piuttosto uniche. Nel discorso colloquiale, per esprimere contenuti simili in situazioni tipiche e ripetute, vengono create costruzioni già pronte, frasi stabili e vari tipi di cliché linguistici (formule di saluto, addio, appello, scuse, gratitudine, ecc.). Questi mezzi vocali già pronti e standardizzati vengono riprodotti automaticamente e aiutano a rafforzare la natura normativa del discorso colloquiale, che è una caratteristica distintiva della sua norma. Tuttavia, la spontaneità della comunicazione verbale, la mancanza di riflessione preliminare, l'uso di mezzi di comunicazione non verbale e la specificità della situazione linguistica portano ad un indebolimento delle norme.
Pertanto, in uno stile conversazionale, coesistono standard linguistici stabili, riprodotti in situazioni tipiche e ripetute, e fenomeni linguistici letterari generali che possono essere soggetti a vari cambiamenti. Queste due circostanze determinano la specificità delle norme dello stile conversazionale: a causa dell'uso di mezzi e tecniche linguistiche standard, le norme dello stile conversazionale, da un lato, sono caratterizzate da un grado più elevato di vincolo rispetto alle norme di altri stili , dove non sono escluse la sinonimia e la libera manovra con un insieme di mezzi linguistici accettabili. D'altra parte, i fenomeni generali del discorso letterario caratteristici dello stile conversazionale possono, in misura maggiore che in altri stili, essere soggetti a vari cambiamenti.
Nello stile colloquiale, rispetto allo stile commerciale e scientifico, la percentuale di vocabolario neutro è significativamente più alta. Un certo numero di parole stilisticamente neutre sono usate in significati figurativi specifici di un dato stile. Ad esempio, un verbo stilisticamente neutro tagliare("separare qualcosa, parte di qualcosa") in stile colloquiale è usato nel significato di "rispondere bruscamente, volendo interrompere la conversazione" (Disse¾ tagliato e non ripetuto), vola(“muoversi, spostarsi nell’aria con l’aiuto delle ali”) ¾ nel significato di “rompersi, deteriorarsi” (Il motore a combustione interna volò via.) Guarda anche: uscire(“spostare la colpa, la responsabilità su qualcuno”), lanciare("dare, consegnare"), Mettere("nominare una posizione"), decollare("licenziamento dall'incarico"), ecc.
Il vocabolario quotidiano è ampiamente utilizzato: goloso, fastidio, subito, minuscolo, ignaro, serve bene, lentamente, treno, patata, tazza, saliera, scopa, spazzola, piatto e così via.
Nello stile in esame è diffuso l'uso di parole dal significato concreto e limitato da quello astratto; È insolito utilizzare termini e parole straniere che non sono ancora diventate di uso comune. I neologismi dell'autore (occasionalismi) sono attivi, la polisemia e la sinonimia sono sviluppate e la sinonimia situazionale è diffusa. Una caratteristica del sistema lessicale dello stile conversazionale è la ricchezza di vocabolario e fraseologia emotivamente espressivi (un gran lavoratore, un parassita, un vecchio, uno sciocco; uno sciocco, un crespo, che proietta un'ombra su un recinto, lo prende per la gola, si arrampica in una bottiglia, lo fa morire di fame).
I fraseologismi nel discorso colloquiale vengono spesso ripensati, cambiano forma, sono attivi processi di contaminazione e rinnovamento comico del fraseggio. Una parola con un significato fraseologicamente determinato può essere utilizzata come parola indipendente, pur mantenendo il significato dell'intera unità fraseologica: non curiosare¾ immischiarsi¾ ficcando il naso negli affari tuoi, è andata male¾ rotolare via dalla lingua. Ciò esprime la legge dell'economia dei mezzi linguistici e il principio della struttura incompleta. Un tipo speciale di fraseologia colloquiale è costituito da espressioni standard, formule familiari di etichetta vocale come Come stai?; Buongiorno!; Sii gentile!; Grazie per l'attenzione; Mi dispiace e così via.
L'uso di vocaboli non letterari (gergo, volgarismi, parole volgari e ingiuriose, ecc.) non è un fenomeno normativo dello stile conversazionale, ma piuttosto una violazione delle norme, proprio come l'abuso del vocabolario librario, che conferisce al discorso colloquiale un aspetto artificiale carattere.
Espressività e valutatività si manifestano anche nel campo della formazione delle parole. Molto produttive sono le formazioni con suffissi di valutazione soggettiva con il significato di tenerezza, diminutivo, disprezzo, (dis)approvazione, ironia, ecc. (figlia, figlia, figlia, mani, furiosa, enorme). La formazione delle parole con l'aiuto degli affissi è attiva, conferendo un tono colloquiale o vernacolare. Ciò include nomi con suffissi -ak(-yak): debole, di buon carattere; -k-a: stufa, muro; -sh-a: cassiere, segretario; -an(-yan); vecchio, piantagrane; -un: spaccone, chiacchierone; -ish: forte, tesoro; -l-a: immaginato, pezzo grosso; relativo: corsa, trambusto; aggettivi con suffissi magrezza: enorme, sottile; con allegato pre-: molto gentile, molto sgradevole; verbi con formazione prefisso-suffisso: camminare, camminare, dire, sussurrare; verbi dentro - essere alla moda, fare una smorfia, vagare, fare falegname; SU (-a)-nut: spingere, rimproverare, spaventare, borbottare, sussultare. Il discorso colloquiale, in misura maggiore rispetto al discorso del libro, è caratterizzato dall'uso di formazioni verbali con più prefissi (rieleggere, trattenere, riflettere, buttare fuori). Vengono utilizzati verbi riflessivi con prefisso con vivida espressione emotiva, valutativa e figurativa (correre in giro, lavorare, mettersi d'accordo, trovare idee), complicate formazioni di prefisso-ritorno (vestirsi, prendere una decisione, parlare).
Per migliorare l'espressione, viene utilizzato il raddoppio delle parole, a volte con un prefisso (grande-grande, bianco-bianco, veloce-veloce, piccolo-molto-piccolo, alto-altissimo). C'è la tendenza ad abbreviare i nomi, a sostituire nomi che non siano composti da una sola parola con nomi composti da una sola parola (registro dei voti ¾ registro, scuola decennale ¾ dieci anni scuola nautica ¾ marinaio, reparto chirurgico ¾ chirurgia, oculista ¾ oculista, paziente con schizofrenia ¾ schizofrenico). I nomi metonimici sono ampiamente utilizzati (Oggi si terrà la riunione dell'ufficio sindacale¾ Oggi l'ufficio sindacale; Dizionario della lingua russa compilato da S.I. Ozhegov¾ Ozhegov).
Nel campo della morfologia si possono notare, in primo luogo, forme grammaticali che funzionano principalmente in uno stile conversazionale e, in secondo luogo, l'uso di categorie grammaticali stilisticamente non contrassegnate, la loro relazione qui è diversa rispetto ad altri stili funzionali. Questo stile è caratterizzato da forme accese -UN al nominativo plurale, dove negli stili di libro è la forma normativa -s (bunker, incrociatori, proiettori, istruttori), moduli su -y nei casi genitivo e preposizionale (un chilogrammo di zucchero, un bicchiere di tè, un grappolo d'uva, in officina, in vacanza); flessione zero nel genitivo plurale (cinque grammi, dieci chilogrammi, un chilogrammo di pomodoro, confronta libri: grammi, chilogrammi, pomodori).
La distribuzione quantitativa delle forme dei sostantivi è specifica: il caso nominativo è al primo posto in termini di frequenza, il caso genitivo è usato raramente con il significato di confronto, caratteristica qualitativa; Lo strumentale non si usa con il significato dell'oggetto dell'azione.
Vengono utilizzati aggettivi possessivi, sinonimi delle forme indirette dei sostantivi: Le poesie di Pushkin (poesie di Pushkin), la sorella del brigadiere (la sorella del caposquadra), il fratello di Katya (il fratello di Katya). Nella funzione predicativa, di solito non viene utilizzata la forma abbreviata dell'aggettivo, ma la forma completa: La donna era una donna di poche parole; Le conclusioni sono indiscutibili(confronta i libri: La vera saggezza è concisa; Le conclusioni sono indiscutibili). Le forme brevi di aggettivi sono attive solo nell'intensificazione delle costruzioni, dove sono caratterizzate da una colorazione espressiva pronunciata: Che astuto!; È troppo semplice; I tuoi affari vanno male!
Una delle caratteristiche del discorso colloquiale è l'uso diffuso dei pronomi, che non solo sostituiscono nomi e aggettivi, ma vengono anche utilizzati senza fare affidamento sul contesto. Ad esempio, il pronome come può denotare una qualità positiva o servire da intensificatore (È una donna così!¾ bello, magnifico, intelligente; C’è tanta bellezza ovunque!). Un pronome in combinazione con un infinito può sostituire il nome di un oggetto, ad es. escludere il sostantivo. Per esempio: Dammi qualcosa da scrivere; Porta qualcosa da leggere; Hai qualcosa di cui scrivere?; Prendere qualcosa da mangiare. A causa dell'uso dei pronomi nel discorso colloquiale, la frequenza d'uso di nomi e aggettivi è ridotta. La bassa frequenza di quest'ultimo nel discorso colloquiale è dovuta anche al fatto che gli oggetti e i loro segni sono visibili o conosciuti dagli interlocutori.
Nello stile colloquiale i verbi hanno la precedenza sui nomi. L'attività delle forme personali del verbo aumenta a causa della passività dei nomi verbali, così come dei participi e dei gerundi, che non vengono quasi mai usati nel discorso colloquiale. Delle forme dei participi, solo la forma breve del participio passato passivo del neutro singolare è attiva (scritto, affumicato, arato, fatto, detto). Numero significativo di participi aggettiviali (uno specialista esperto, una persona laboriosa, un soldato ferito, uno stivale strappato, patate fritte). Una caratteristica sorprendente del discorso colloquiale è l'uso di verbi ad azione multipla e singola (leggere, sedersi, camminare, girare, frustare, scopare), così come i verbi con il significato di azione ultra-istantanea (bussare, tintinnare, saltare, saltare, scopare, camminare).
La spontaneità e l'impreparazione dell'enunciato, la situazione della comunicazione verbale e altri tratti caratteristici dello stile conversazionale influenzano soprattutto la sua struttura sintattica. A livello sintattico, più attivamente che ad altri livelli del sistema linguistico, si manifesta la struttura incompleta dell'espressione del significato con mezzi linguistici. Incompletezza delle costruzioni, ellitticità ¾ è uno dei mezzi dell'economia del discorso e una delle differenze più sorprendenti tra il discorso colloquiale e altre varietà di linguaggio letterario. Poiché lo stile conversazionale si realizza solitamente in condizioni di comunicazione diretta, tutto ciò che è dato dalla situazione o consegue da ciò che era noto agli interlocutori anche prima viene omesso dal discorso. SONO. Peshkovsky, caratterizzando il discorso colloquiale, ha scritto: “Non finiamo sempre i nostri pensieri, omettendo dal discorso tutto ciò che è dato dalla situazione o dalla precedente esperienza di chi parla. Allora a tavola chiediamo: “Sei caffè o tè?”; Dopo aver incontrato un amico, chiediamo: “Dove vai?”; Avendo ascoltato musica noiosa, diciamo: "Ancora!"; offrendo l’acqua, diremo: “Bollita, non preoccuparti!”, Vedendo che la penna dell’interlocutore non scrive, diremo: “E tu usi una matita!” e così via."
Nella sintassi conversazionale predominano le frasi semplici e spesso mancano di un verbo predicativo, il che rende l'affermazione dinamica. In alcuni casi, le affermazioni sono comprensibili al di fuori della situazione e del contesto, il che indica la loro coerenza linguistica (Io vado al cinema; Lui va in ostello; Vorrei un biglietto; Domani a teatro), in altri ¾ il verbo predicativo mancante è suggerito dalla situazione: (all'ufficio postale) ¾ Busta affrancata, per favore(Dare). Parole della frase utilizzate (affermativa, negativa, motivante): ¾ Comprerai un biglietto?¾ Necessario; Puoi portare un libro?¾ Ovviamente;¾ Hai letto la nota?¾ Non ancora;¾ Preparati! Marzo! Solo il discorso colloquiale è caratterizzato dall'uso di parole speciali e frasi corrispondenti che esprimono accordo o disaccordo (Sì; No; Naturalmente; Naturalmente), sono spesso ripetuti (¾ Andiamo nella foresta?¾ Si si!;¾ Stai comprando questo libro?¾ No no).
Tra le frasi complesse in questo stile, quelle composte e non sindacali sono più attive. Questi ultimi hanno spesso una colorazione colloquiale pronunciata e quindi non vengono utilizzati nel discorso dei libri (Verrai¾ chiamata; Ci sono persone¾ non dispiacersi per se stessi). L'impreparazione dell'espressione e l'incapacità di pensare in anticipo alla frase impediscono l'uso di strutture sintattiche complesse in uno stile conversazionale. L'emotività e l'espressività del discorso colloquiale determina l'uso diffuso di frasi interrogative ed esclamative. (Davvero non hai visto questo film? Vuoi vederlo? Andiamo a “Ottobre” adesso. Perché te ne stai seduto a casa! Con questo tempo!). Le frasi intergettive sono attive (Non importa come!; Andiamo!; Ebbene sì?; Certo!; Oh, davvero?; Wow!); vengono utilizzate strutture di collegamento (Lo stabilimento è ben attrezzato. Con le ultime tecnologie; È una brava persona. Inoltre è allegro).
L'indicatore principale delle relazioni sintattiche nel discorso colloquiale è l'intonazione e l'ordine delle parole, mentre i mezzi di comunicazione morfologici - il trasferimento di significati sintattici utilizzando le forme delle parole - sono indeboliti. L'intonazione, strettamente correlata al tempo del discorso, al tono, alla melodia, al timbro della voce, alle pause, agli accenti logici, ecc., In uno stile conversazionale porta un enorme carico semantico, modale ed emotivamente espressivo, conferendo al discorso naturalezza, facilità, vivacità, espressività . Riempie ciò che non viene detto, accresce l'emotività ed è il mezzo principale per esprimere l'articolazione reale. L'argomento della frase è evidenziato utilizzando l'accento logico, quindi l'elemento che funge da rima può essere posizionato ovunque. Ad esempio, lo scopo del viaggio può essere chiarito utilizzando domande: Vai a Mosca in viaggio d'affari? ¾ Stai andando in viaggio d'affari a Mosca?¾ Stai andando in viaggio d'affari a Mosca? ¾ Stai andando in viaggio d'affari a Mosca? Circostanza (a viaggio di lavoro) può occupare una posizione diversa in un'affermazione, poiché è evidenziata dall'accento logico. Isolare una rima usando l'intonazione ti consente di usare parole interrogative dove, quando, perché, perché ecc. non solo all'inizio di una frase, ma anche in qualsiasi altra posizione (Quando andrai a Mosca? - Quando andrai a Mosca?¾ Quando andrai a Mosca?). Una caratteristica tipica della sintassi conversazionale è la separazione dell'intonazione di tema e rema e la loro formazione in frasi indipendenti (- Come arrivare al circo?¾ Al circo? Giusto; Quanto è bello questo libro?¾ Questo? Cinquantamila).
L'ordine delle parole nel discorso colloquiale, non essendo il mezzo principale per esprimere la divisione effettiva, presenta un'elevata variabilità. È più libero rispetto agli stili dei libri, ma gioca comunque un certo ruolo nell'espressione della divisione effettiva: l'elemento più importante, essenziale che ha il significato principale nel messaggio è solitamente posto all'inizio dell'affermazione: Al mattino nevicava forte; È strano; L'albero di Natale era soffice; Devi correre più veloce. Spesso il sostantivo al nominativo viene prima, poiché serve come mezzo di attualizzazione: Stazione, dove scendere?; Centro commerciale, come arrivarci?; Il libro era qui, non l'hai visto?; La borsa è rossa, per favore mostramelo!
Ai fini dell'enfasi espressiva, una frase complessa spesso inizia con una clausola subordinata nei casi in cui in altri stili la sua posposizione è la norma. Per esempio: Cosa fare¾ Non lo so; Che non avevo paura¾ Ben fatto; Chi è coraggioso¾ uscire.
La simultaneità del pensiero e del discorso durante la comunicazione diretta porta a frequenti riorganizzazioni della frase in movimento. In questo caso, le frasi vengono interrotte, quindi seguono delle aggiunte o la loro struttura sintattica cambia: Ma non vedo alcun motivo particolare per preoccuparsi così tanto... anche se, del resto...; Recentemente hanno comprato un gatto. Così carino e così via.
Tabella delle caratteristiche differenziali degli stili funzionali
caratteristiche generali
Caratteristiche dello stile conversazionale
Lo stile conversazionale (RS) è in contrasto con tutti gli altri stili (libresco) per i seguenti motivi:
1. La funzione principale di RS è comunicativa (funzione di comunicazione), mentre le funzioni degli stili di libro sono informative e d'influenza.
2. La principale forma di esistenza della RS è orale (negli stili dei libri è scritta).
3. Il principale tipo di comunicazione in RS è interpersonale (persona - persona), nei libri - gruppo (oratorio, conferenza, relazione scientifica) e di massa (stampa, radio, televisione).
4. Il tipo principale di discorso in RS è il dialogo o il polilogo, nei libri è il monologo.
5. La RS viene implementata in una situazione di comunicazione informale e si presuppone che i partecipanti al dialogo si conoscano e siano generalmente socialmente uguali (giovani, gente comune, ecc.). Da qui: facilità di comunicazione, maggiore libertà nel comportamento, nell'espressione di pensieri e sentimenti. Molto spesso, la SM viene implementata nella comunicazione quotidiana, si tratta di dialoghi tra familiari, amici, conoscenti, colleghi, compagni di studio, ecc. In questo caso vengono discussi principalmente argomenti di natura quotidiana e non professionale e non ufficiale. Gli stili dei libri sono implementati in condizioni formali e servono alla comunicazione verbale su quasi tutti gli argomenti.
Principali caratteristiche dello stile conversazionale:
1) spontaneità, cioè discorso impreparato, mancanza di selezione preliminare dei mezzi linguistici;
2) automatismo del discorso, ad es. l'uso di formule verbali stabilite caratteristiche di determinate situazioni ( Buon pomeriggio Come va? Stai andando fuori?);
3) espressività (espressività speciale) del discorso, che si ottiene utilizzando parole ridotte ( impazzire, impazzire, impazzire), vocabolario emotivamente espressivo ( ragazzone, kikimora, mocassino), formazioni di suffisso ( figlia, nonna, carina);
4) contenuto di routine;
5) forma prevalentemente dialogica.
La formazione del discorso in uno stile conversazionale è influenzata anche da fattori extralinguistici: lo stato emotivo dei parlanti, la loro età (cfr. il discorso degli adulti tra loro e la loro conversazione con i bambini piccoli), le relazioni dei partecipanti allo stile conversazionale dialogo, la loro famiglia e altri collegamenti, ecc.
Lo stile conversazionale forma un proprio sistema e presenta caratteristiche che lo distinguono dagli stili librari a tutti i livelli del linguaggio.
SU fonetico A livello MS, la SM è caratterizzata da uno stile di pronuncia incompleto (ritmo veloce, riduzione delle vocali fino alla scomparsa delle sillabe: San Sanych, Glebych ecc.), le opzioni di accento colloquiale sono accettabili ( ricotta, cucina, ha dato ecc.), intonazione più libera, affermazioni incompiute, pause di riflessione, ecc.
Vocabolario La SM è eterogenea e differisce per grado di letteratura e caratteristiche emotivo-espressive:
1. Vocabolario neutro del linguaggio quotidiano: mano, gamba, padre, madre, fratello, corri, guarda, ascolta e sotto.
2. Vocabolario colloquiale (il principale dispositivo stilistico) - parole che conferiscono al discorso un carattere informale, ma allo stesso tempo sono prive di maleducazione: filatore, superlativo, guerriero, saccente, torna a casa, sciocco, antidiluviano, prevaricato.
3. Vocabolario valutativo nella composizione di parole colloquiali, che esprime una valutazione emotiva giocosa, umoristica-ironica, ironica, affettuosa, sprezzante: nonna, figlia, figli, bambino, ragazzino; poesie, scarabocchi, lavori di hacking, incalliti.
Nei dizionari, le parole colloquiali sono elencate con la dicitura “colloquiale”. e segni aggiuntivi “scherzante”, “ironico”, “sdegnoso”, “affettuoso”.
4. L'emotività di un gran numero di parole colloquiali è associata al loro significato figurativo : canile(su una stanza angusta, buia e sporca), Torre(su un uomo alto) bastone(infastidire invadentemente con qualcosa) e così via.
5. A causa del fatto che i confini tra vocabolario colloquiale e colloquiale sono spesso fluidi, come evidenziato dal doppio segno “colloquiale-semplice”. nei dizionari, RS include crudamente espressivo parole colloquiali, la cui espressività ti permette di “chiudere gli occhi” davanti alla loro maleducazione: pancia, grande, piagnucoloso, strega, kikimora, lentigginoso, mocassino, trasandato, gironzolare, schiacciare e sotto. Esprimono brevemente e accuratamente un atteggiamento nei confronti di una persona, un oggetto, un fenomeno e spesso contengono una connotazione semantica aggiuntiva che non si trova in una parola neutra, cfr.: “sta dormendo” e “sta dormendo”. La parola “dormire” esprime la condanna di una persona: qualcuno dorme quando dovrebbe andare da qualche parte o fare qualcosa.
Vocaboli simili possono essere elencati nei dizionari esplicativi sotto il titolo principale “semplice”. segni aggiuntivi "fam.", "ramo.", "con un pizzico di disprezzo", "scherzando.", ad esempio: clunker - semplice. scherzando (Dizionario di D.N. Ushakov).
SU fraseologico a livello, lo stile colloquiale è caratterizzato dall'uso di proverbi e detti del linguaggio popolare: anche stare in piedi, anche cadere; sedersi in una pozzanghera; rotto in mille pezzi; storcere il naso; la caccia è peggio della schiavitù e sotto.
Derivativo Il livello dello stile conversazionale è caratterizzato da:
1) suffissi colloquiali
Per i sostantivi: -un, -un(ya): parlatore, parlatore; chiacchierone, chiacchierone;
Sh(a): cassiere, medico, operatore dell'ascensore;
Yag(a): povero ragazzo, bello, bastardo, gran lavoratore;
Il loro): custode, dottore, cuoco;
K(a): grano saraceno, semola, durante la notte, candela,
comprese le parole abbreviate con -к(а): soda, e-reader, asciugatrice, spogliatoio, libretto dei record;autostoppista, "Letteratura";
N(i), -rel(i): correre, agitarsi, litigare, cucinare, trambusto;
Yatin(a): sciocchezze, carne morta, volgarità;
Per i verbi: -icha (t), -nicha (t): essere sarcastico, essere gentile, essere avido;
BENE: dì, gira, afferra;
2) formazioni verbali prefisso-suffisso di tipo conversazionale:
corri in giro, chiacchiera, siediti;
parla, grida, guarda;
ammalarsi, sognare ad occhi aperti, giocare;
3) suffissi di valutazione soggettiva:
Ingrandimento: casa, barba, mani;
Diminutivi: casa, barba, astuzia, in silenzio, in silenzio;
Diminutivi: figlia, figlia, figlio, figlioletto; sole, tesoro;
Denigratorio: piccola cosa, casetta, vecchio, buffone, montanaro, barba;
4) mezzi nomi ( Vanka, Lenka), carezzevole ( Mashenka, Sashok) e nomi balbettanti ( Niki – Nikolay, Zizi – Suzanne).
5) raddoppiare le parole per migliorare l'espressione: grande-grande, nero-nero;
6) formazione di aggettivi con significato valutativo: occhi grandi, magro.
IN morfologia:
1) la predominanza dei verbi sui nomi (natura verbale del discorso), l'attività predominante dei verbi di movimento ( saltare, galoppare), Azioni ( prendere, dare, andare) e afferma ( ferito, piangere); Mercoledì nel NS e nell'ODS i verbi più comuni sono obbligatori ( deve, obbliga) e collegare i verbi ( è, costituisce);
2) un'alta percentuale di uso personale ( io, tu, lui, noi, tu, Essi) e indice ( quello, questo, questo ecc.) pronomi;
3) la presenza di interiezioni ( ah, oh, eh, oh ecc.) e particelle ( ecco, beh, Lei- Quello, Lui de Egli ha detto dicono sega);
4) la presenza di interiezioni verbali ( salta, salta, sbatti, afferra);
5) uso diffuso di aggettivi possessivi ( La sorella di Petya, la moglie di Fedorov);
6) forme colloquiali dei sostantivi: genitivo singolare in -y ( dalla foresta, da casa), caso preposizionale singolare in -у ( all'aeroporto, in vacanza), nominativo plurale in -a ( bunker, anno, ispettore, ancora, cacciatore);
7) i participi e le forme brevi degli aggettivi si trovano raramente, e non si usa il gerundio.
SU sintattico livello:
1) non vengono utilizzate frasi semplici, frasi partecipative e avverbiali, non vengono utilizzate frasi complesse, ad eccezione delle clausole subordinate con una parola congiuntiva Quale;
2) ordine delle parole libere in una frase: Ieri ero al mercato;
3) omissione di parole (puntini di sospensione), soprattutto nel dialogo:
- Sei stato al negozio? - Vado al college. Sei a casa?
- Era.
4) ripetizioni lessicali: Glielo dico e glielo dico, ma lui non ascolta;
5) ripetizioni sintattiche (frasi costruite in modo identico): Sono andato da lui, gli ho detto...;
6) modelli di discorso come “Ben fatto!”, “Che mascalzone sei!”, “Che razza di idiota!”, “Wow!”;
7) disegni come “ Hai qualcosa di cui scrivere?? (cioè matita, penna); " Dammi qualcosa dietro cui nascondermi! (es. coperta, tappeto, lenzuolo);
8) frasi “non fluide”, cioè frasi senza confini netti, che si ottengono come risultato della compenetrazione di due frasi: In autunno cominciano tali tempeste, lì, in mare...;
9) frequenti ristrutturazioni delle strutture durante il dialogo, emendamenti, ripetizioni, chiarimenti;
10) domande retoriche: Mi ascolterà?
11) frasi interrogative, esclamative e di incentivazione;
12) nelle frasi “non fluide”, viene utilizzato l'argomento nominativo, quando la prima parte della frase contiene un sostantivo nel caso nominativo, e la seconda contiene informazioni al riguardo, mentre entrambe le parti sono grammaticalmente indipendenti: Nonna, parlerà con tutti. I fiori non sono mai superflui.
I mezzi di comunicazione non verbale svolgono un ruolo importante nell'attuazione della SM - gesti ed espressioni facciali, che può accompagnare le parole di chi parla, indicando la forma, la dimensione e altre caratteristiche dell'argomento del discorso: Ho comprato questo rotondo(gesto) cappello, ma può agire anche al posto di una pausa, come mezzo di comunicazione autonomo, in funzione di singole linee di dialogo, come risposta a una domanda, a una richiesta: annuisci con il significato di "sì", alza le spalle spalle - esprimere sconcerto.
Confronto dello stile di discorso conversazionale con altri stili. Originalità dello stile conversazionale.
Il discorso parlato funziona solo nella sfera privata della comunicazione: vita quotidiana, professionale quotidiana, amichevole, familiare, ecc. Molto spesso, l'argomento della conversazione è il tempo, la salute, le notizie, eventuali eventi interessanti, gli acquisti, i prezzi... Tuttavia, ciò non significa che lo stile di conversazione sia limitato agli argomenti di tutti i giorni. Il discorso colloquiale può toccare anche altri argomenti: ad esempio, una conversazione tra persone in relazioni informali su arte, scienza, politica, ecc. Ma questi argomenti sono soggetti anche alle regole dello stile conversazionale, alla sua struttura sintattica, sebbene in questi casi il vocabolario delle conversazioni sia arricchito con parole di libri.
Lo stile conversazionale svolge la funzione principale del linguaggio: la funzione della comunicazione, il suo scopo è la trasmissione diretta delle informazioni. Questo stile è utilizzato non solo nella vita di tutti i giorni, ma anche nella sfera professionale. Nella vita di tutti i giorni, ha una forma orale - monologo o discorso dialogico, e una forma scritta - lettere private, appunti, voci di diario. Nella sfera professionale - solo orale. Le caratteristiche linguistiche dello stile conversazionale determinano le condizioni speciali per il suo funzionamento: informalità, facilità, espressività, mancanza di selezione preliminare dei mezzi linguistici, automatismo del discorso, ordinarietà del contenuto. Nella comunicazione quotidiana si realizzano un modo di pensare concreto e associativo e una natura di espressione diretta ed espressiva. Da qui il disordine, la frammentazione delle forme del discorso e l'emotività dello stile.
Una delle caratteristiche più importanti del discorso colloquiale è la sua dipendenza da una situazione extralinguistica, vale a dire il contesto reale e oggettivo del discorso in cui avviene la comunicazione. Ciò consente di abbreviare estremamente un'affermazione in cui potrebbero mancare singoli componenti, il che, tuttavia, non interferisce con la corretta percezione delle frasi colloquiali.
Ad esempio, in una panetteria non troviamo strana la frase:
- Per favore, con la crusca, uno.
In stazione presso la biglietteria:
- Due a Svetlogorsk.
Al di fuori di queste situazioni, queste affermazioni perdono significato.
Nello stile conversazionale, per il quale la forma orale è primordiale, un ruolo importante gioca il lato sonoro del discorso, e soprattutto l'intonazione: è questo (in interazione con una sintassi peculiare) che crea l'impressione di conversatività. Il discorso rilassato è caratterizzato da forti aumenti e diminuzioni del tono, allungamento, "allungamento" delle vocali, scansione delle sillabe, pause e cambiamenti nel tempo del discorso. Una minore tensione negli organi vocali porta a cambiamenti nella qualità dei suoni e talvolta anche alla loro completa scomparsa: “ciao”, non “ciao”, non “dice” ma “grinta”, “buim” invece di “siamo”, eccetera. Questa semplificazione delle norme ortoepiche è particolarmente evidente nelle forme non letterarie dello stile colloquiale, nel linguaggio comune.
Il vocabolario di stile colloquiale è diviso in due grandi gruppi: 1) parole comuni ( giorno, anno, lavoro, presto, possibile, buono, nuovo eccetera.); 2) parole colloquiali ( patata, lettore, libretto, reale, pesce persico). È anche possibile utilizzare parole colloquiali, dialettismi, gergo, ad es. elementi extraletterari. Tutto questo vocabolario è prevalentemente di contenuto quotidiano, specifico. Tuttavia, la diversità tematica del discorso colloquiale, che non si limita agli argomenti quotidiani, comporta l'inclusione di diversi gruppi stilistici di vocabolario: termini, vocabolario astratto, prestiti stranieri (sebbene la loro gamma sia piuttosto ristretta). L'attività del vocabolario espressivo-emotivo (familiare, affettuoso, disapprovante, ironico) è indicativa. Il vocabolario valutativo di solito ha qui una connotazione ridotta ( fantastico, biondo, semplice, loquace e così via.). È interessante usare parole occasionali (neologismi che ci vengono in mente di tanto in tanto) - "opener" - un apriscatole, "adotta" - sul modello di "adotta"» Le metafore sono ampiamente utilizzate ( vinaigrette, porridge, okroshka, - riguardo alla confusione ; gelatina, debole - su una persona pigra e senza carattere) sullo sfondo di un vocabolario neutro. Una caratteristica dei testi in stile colloquiale sono le cosiddette parole vuote, che possono sostituire qualsiasi altra parola. Il loro significato è specificato nella situazione: "cosa", "cosa", "atto", "bandura", "clunker". Per esempio:
-Dove portiamo questa bandura?(A proposito dell'armadio).
- Non ho bisogno dello zucchero, ma con questa cosa(torta).
Nella comunicazione quotidiana è possibile denominare gli oggetti in un modo speciale:
-Dammi qualcosa con cui coprirmi.(coperta).
Nello stile colloquiale si applica la legge del "salvataggio dei mezzi di parola", quindi, invece di nomi costituiti da due o più parole, se ne usa una: giornale della sera - "vecherka", latte condensato - "latte condensato", ripostiglio - " stanza sul retro", edificio di cinque piani - " edificio di cinque piani." In altri casi, vengono trasformate combinazioni stabili di parole: consiglio accademico - "consiglio", congedo per malattia - "congedo per malattia". Lo stile colloquiale è ricco di fraseologia. La maggior parte delle unità fraseologiche russe sono di natura colloquiale ( a un tiro di schioppo, inaspettatamente, come l'acqua dalla schiena di un'anatra ecc.), le espressioni colloquiali sono ancora più espressive ( Non esiste una legge per gli sciocchi, in mezzo al nulla e così via.). Le unità fraseologiche colloquiali e colloquiali danno al discorso immagini vivide. Differiscono dal libro e dalle unità fraseologiche neutre non per il significato, ma per l'espressività e la riduzione speciali. Confrontare: morire è stare al gioco, ingannare è attaccarsi le tagliatelle alle orecchie.
A livello di formazione delle parole, l'emotività e la valutatività dello stile conversazionale sono realizzate con l'aiuto di suffissi di valutazione soggettiva con il significato di tenerezza, disapprovazione, ingrandimento, ecc. ( mamma, tesoro, sole; finzione, volgarità; casa, freddo ecc.), nonché suffissi con una connotazione funzionale di colloquialità (-k -“spogliatoio”, “pernottamento”, “stufa”;- va bene "coltello", "pioggia""; - un " parlatore"; - Yaga " gran lavoratore"). Vengono utilizzate formazioni senza suffisso ( russare, ballare), composto ( teledipendente, ciarlatano). Puoi anche indicare i modi più attivi di formazione delle parole per aggettivi di significato valutativo ( dagli occhi grandi, con i denti, pungente, combattivo; magro, sano ecc.), così come i verbi - prefisso suffisso ( fai il cattivo, parla, gioca), suffissi ( speculare, ciao), prefisso ( è perdere peso, comprare). Per migliorare l'espressione, vengono utilizzate le parole raddoppiate: aggettivi, a volte con prefissazione aggiuntiva ( nero-nero, smart-premium), fungendo da superlativi.
La norma morfologica dello stile conversazionale, da un lato, corrisponde alla norma letteraria generale, dall'altro ha le sue caratteristiche. Ad esempio, qui i verbi sono usati più spesso dei nomi. Indicativo è anche l'uso particolarmente frequente dei pronomi personali e dimostrativi. Come dice il professor G.Ya Solganik, “i pronomi personali sono ampiamente utilizzati a causa della costante necessità di designare i partecipanti a una conversazione. Qualsiasi dialogo (e questa è la forma principale del discorso conversazionale) presuppone io - l'oratore, TU - l'ascoltatore, che assume alternativamente il ruolo di chi parla, e LUI - colui che non è direttamente coinvolto nella conversazione. Qualsiasi contenuto può essere inserito nella formula I – TU – LUI”. I pronomi dimostrativi e altri sono necessari nello stile di conversazione a causa della loro ampiezza intrinseca e della generalità del significato. Si concretizzano in un gesto, e questo crea le condizioni per una trasmissione molto compressa di questa o quella informazione (ad esempio: “Non è qui, ma lì”). Solo lo stile colloquiale consente l’uso di un pronome accompagnato da un gesto senza l’uso preventivo di una parola specifica: “ Non lo prenderò. Questo non mi va bene».
Gli aggettivi possessivi sono usati nel discorso colloquiale ( di mamma vestiti, padre lavoro), ma le forme brevi sono usate raramente. Participi e gerundi non si verificano affatto, e per le particelle e le interiezioni il discorso colloquiale è il loro elemento nativo. ( Cosa posso dire! Questo è il punto! Sorpresa per te!)
Nello stile colloquiale si preferiscono le forme varianti dei sostantivi ( in vacanza; fabbro´), numeri ( cinquanta, cinquecento), verbi ( Leggerò, ma non leggerò; sollevare, non visto, non sentito). Nella conversazione dal vivo si trovano spesso forme troncate di verbi che hanno il significato di azione istantanea e inaspettata: afferrare, saltare, saltare e così via. Per esempio: E questo lo prende per la manica! La cavalletta salta e colpisce l'erba. Usiamo forme colloquiali di gradi di confronto di aggettivi ( meglio, più breve), avverbio ( velocemente, più comodamente). Nel linguaggio colloquiale, le desinenze zero nel genitivo plurale di nomi come grammo, arancia, pomodoro e così via. ( cento grammi di burro, cinque chilogrammi di arancia).
Sotto l'influenza della legge dell'economia dei mezzi linguistici, lo stile conversazionale consente l'uso di nomi reali in combinazione con numeri ( due latti, due caffè– che significa “due porzioni”). Qui sono comuni forme particolari di indirizzo: nomi troncati: Mamma! Papà! Biancheria! Rotolo!
Il discorso colloquiale non è meno originale nella distribuzione delle forme dei casi: qui domina il nominativo, che nelle osservazioni orali sostituisce le forme controllate dal libro. Per esempio: Ha costruito una dacia, una stazione nelle vicinanze; Ho comprato una pelliccia – pelliccia di astrakan grigia. Il caso nominativo è particolarmente coerente nel sostituire tutti gli altri quando si utilizzano i numeri nel discorso: L'importo non supera i trecento rubli (invece di: trecento); Aveva tre cani (tre cani).
La sintassi del discorso colloquiale è davvero unica, grazie alla sua forma orale e alla sua espressione vivida. Qui dominano frasi semplici, spesso incomplete, della struttura più varia (decisamente personale, indefinitamente personale, impersonale e altre) ed estremamente brevi.
Nel discorso orale, spesso non nominiamo un oggetto, ma lo descriviamo: Nel cappello non sei stato qui? Amano guardare fino a sedici(che significa film). Come risultato di un discorso impreparato, compaiono costruzioni di collegamento: Dobbiamo andare a San Pietroburgo. Alla conferenza. Questa frammentazione della frase è spiegata dal fatto che il pensiero si sviluppa in modo associativo, l'oratore sembra ricordare i dettagli e integrare l'affermazione. Le frasi complesse non sono tipiche del discorso colloquiale; se vengono utilizzate, più spesso di altre non sono congiuntive: Se me ne vado, per te sarà più facile; Tu parli, io ascolto.
Anche l'ordine delle parole nel discorso dal vivo è insolito. Di norma, la parola più importante nel messaggio viene messa per prima: Ieri ho visto Oleg; Comprami un computer; Studieremo oggi? Allo stesso tempo, parti di una frase complessa (clausole principali e subordinate) sono talvolta intrecciate: Non so nemmeno dove prendere l'acqua. Le tipiche frasi colloquiali complesse sono caratterizzate da un indebolimento della funzione della proposizione subordinata, dalla sua fusione con quella principale e da una riduzione strutturale: Lavorerai con chiunque ordinino; Chiama chi vuoi.
Numerosi tipi di frasi colloquiali possono combinare costruzioni di domanda-risposta e riflettere le caratteristiche del discorso colloquiale, ad esempio: Chi mi serve sei tu; Chi rispetto sul campo è Ivanov.
Dovrebbero essere notate le seguenti caratteristiche della sintassi conversazionale:
Utilizzando un pronome che duplica il soggetto: Vera, arriva tardi.
Posizionare una parola importante della proposizione subordinata all'inizio della frase: Mi piace che il pane sia sempre fresco.
Uso delle parole della frase: OK; Chiaro; Potere; Certamente.
Attività delle parole introduttive: Forse; Per così dire; Sai.
Lo stile di conversazione è in contrasto con gli stili di libro, poiché funzionano nell'una o nell'altra sfera dell'attività sociale. Tuttavia, il discorso colloquiale include non solo mezzi colloquiali specifici, ma anche neutri, che sono la base della lingua letteraria. Pertanto, questo stile è associato ad altri stili che utilizzano anche mezzi linguistici neutri. All'interno di una lingua letteraria, il discorso colloquiale è in contrasto con il linguaggio codificato nel suo insieme. Ma la lingua letteraria codificata e il discorso colloquiale sono due sottosistemi all'interno della lingua letteraria. Di norma, ogni madrelingua di una lingua letteraria parla entrambe queste varietà di discorso.
Riepilogo
Lo stile colloquiale, in misura maggiore di tutti gli altri stili, ha una sorprendente originalità di caratteristiche linguistiche che vanno oltre l'ambito della lingua letteraria standardizzata. Può servire come prova convincente che la norma stilistica è fondamentalmente diversa da quella letteraria. Ciascuno degli stili funzionali ha sviluppato le proprie norme che dovrebbero essere prese in considerazione e ha le proprie caratteristiche. Nel linguaggio colloquiale questo è:
· impreparazione, spontaneità;
· natura diretta dell'atto linguistico;
· grande influenza di fattori extralinguistici;
· uso diffuso del vocabolario e della fraseologia quotidiana ed emotivamente espressiva;
· implementazione della valutatività e dell'espressività a livello morfologico e sintattico.
Ma ciò non significa che il discorso colloquiale sia sempre in conflitto con le regole della lingua letteraria. Le deviazioni dalla norma possono variare a seconda della stratificazione intra-stile dello stile conversazionale. Contiene varietà di linguaggio ridotto, rude, linguaggio vernacolare che ha assorbito l'influenza dei dialetti locali, ecc. Ma il discorso colloquiale di persone intelligenti e istruite è piuttosto letterario e allo stesso tempo differisce nettamente dal discorso libresco, vincolato dalle rigide norme di altri stili funzionali.
Domande per il controllo e l'autocontrollo
1. In quale area della comunicazione funziona la lingua parlata?
2. Quali condizioni per il funzionamento di uno stile conversazionale determinano le sue caratteristiche linguistiche?
3. Che ruolo giocano i fattori extralinguistici nella formazione della lingua parlata?
4. In quali forme viene implementata la funzione principale dello stile conversazionale?
Cosa è caratteristico dell'ortoepia nel discorso colloquiale?
5. Come vengono determinate l'espressività e la valutatività dello stile di discorso colloquiale nel vocabolario e nella formazione delle parole?
6. Qual è l'unicità della morfologia dello stile conversazionale?
7. Quali strutture sintattiche sono caratteristiche del discorso colloquiale?
8. Qual è la relazione tra lo stile di conversazione e gli altri stili di discorso?
9. Lo stile di discorso colloquiale è incluso nella lingua letteraria?
LETTERATURA
1. Golub I.B. Lingua russa e cultura della parola: libro di testo, - M .: Logos, 2004.
2. Vvedenskaya L.A., Pavlova L.G., Kashaeva E.Yu. Lingua russa e cultura vocale per ingegneri: libro di testo, - Rostov-sul-Don: Phoenix, 2003.
3. Maksimov V.I. e altri Lingua e cultura vocale russa: libro di testo. - M.: Gardariki, 2001.
4. Zemskaya E.A. Discorso colloquiale russo: analisi linguistica e problemi di apprendimento. – M., 1997.
5. Golub I.B., Rosenthal D.E. Segreti del buon discorso. – M., 1993.
Stilistica
Caratteristiche stilistiche dello stile di discorso conversazionale
Un'elevata cultura del discorso parlato e scritto, una buona conoscenza e sviluppo di un talento per la lingua madre, la capacità di utilizzare i suoi mezzi espressivi, la sua diversità stilistica sono il miglior supporto, l'aiuto più sicuro e la raccomandazione più affidabile per ogni persona nella sua vita sociale e attività creativa.
V.A. Vinogradov
introduzione
Il mio lavoro è dedicato allo studio dello stile di discorso conversazionale.
L'obiettivo principale è identificare le caratteristiche stilistiche di un dato stile di discorso, per capire in che modo il colloquiale differisce dagli altri stili. Il mio compito è definire lo stile di discorso colloquiale, dividerlo in tipologie, determinare le specificità e le caratteristiche intra-stili dello stile colloquiale.
La lingua è un mezzo di comunicazione tra le persone, uno strumento per la formazione e l'espressione di pensieri e sentimenti, un mezzo per assimilare nuove informazioni, nuove conoscenze. Ma per influenzare efficacemente la mente e i sentimenti, il madrelingua di una determinata lingua deve parlarla fluentemente, cioè avere una cultura del linguaggio.
M. Gorky ha scritto che la lingua è l'elemento primario, il materiale principale della letteratura, ad es. quel vocabolario, la sintassi, l'intera struttura del discorso è l'elemento primario, la chiave per comprendere le idee e le immagini di un'opera. Ma la lingua è anche uno strumento della letteratura: “La lotta per la purezza, per la precisione semantica, per l'acutezza del linguaggio è una lotta per uno strumento di cultura. Quanto più affilata è quest’arma, quanto più accuratamente viene mirata, tanto più vittoriosa sarà”.
La stilistica (la parola “stile” deriva dal nome dell'ago o stiletto con cui gli antichi greci scrivevano sulle tavolette cerate) è una branca della scienza del linguaggio che studia gli stili della lingua letteraria (stili funzionali del discorso), gli schemi del funzionamento del linguaggio in diverse sfere di utilizzo, le peculiarità dell'uso dei mezzi linguistici a seconda della situazione, del contenuto e dello scopo dell'affermazione, della sfera e delle condizioni della comunicazione. La stilistica introduce il sistema stilistico della lingua letteraria a tutti i suoi livelli e l'organizzazione stilistica del discorso corretto (nel rispetto delle norme della lingua letteraria), accurato, logico ed espressivo. La stilistica insegna l'uso consapevole e intenzionale delle leggi del linguaggio e l'uso dei mezzi linguistici nel discorso.
Esistono due direzioni nella stilistica linguistica: stilistica del linguaggio e stilistica del discorso (stilistica funzionale). La stilistica linguistica esamina la struttura stilistica del linguaggio, descrive i mezzi stilistici del vocabolario, della fraseologia e della grammatica. La stilistica funzionale studia, prima di tutto, diversi tipi di discorso, la loro dipendenza da diversi scopi di espressione. M. N. Kozhina dà la seguente definizione: “La stilistica funzionale è una scienza linguistica che studia le caratteristiche e i modelli del funzionamento del linguaggio in vari tipi di discorso corrispondenti a determinate sfere dell'attività e della comunicazione umana, nonché la struttura del discorso degli stili funzionali risultanti e “norme” “selezione e combinazione di mezzi linguistici” 1. Fondamentalmente, la stilistica deve essere costantemente funzionale. Dovrebbe rivelare la connessione tra i diversi tipi di discorso con l'argomento, lo scopo dell'affermazione, con le condizioni di comunicazione, il destinatario del discorso e l'atteggiamento dell'autore nei confronti dell'argomento del discorso. La categoria più importante della stilistica sono gli stili funzionali: varietà di discorso letterario (linguaggio letterario) che servono vari aspetti della vita pubblica. Gli stili sono modi diversi di utilizzare la lingua durante la comunicazione. Ogni stile di discorso è caratterizzato dall'originalità della selezione dei mezzi linguistici e dalla loro combinazione unica tra loro.
La classificazione degli stili si basa su fattori extralinguistici: l'ambito di utilizzo della lingua, l'argomento da essa determinato e gli obiettivi della comunicazione. Le aree di applicazione del linguaggio sono correlate a tipi di attività umana corrispondenti a forme di coscienza sociale (scienza, diritto, politica, arte). Le aree di attività tradizionali e socialmente significative sono: scientifica, aziendale (amministrativa e legale), socio-politica, artistica. Di conseguenza, distinguono anche tra gli stili del discorso ufficiale (libro): scientifico, commerciale ufficiale, giornalistico, letterario e artistico (artistico).
Lo stile funzionale ¾ è una varietà storicamente consolidata e socialmente consapevole di una lingua letteraria (il suo sottosistema), funzionante in una determinata sfera dell'attività e della comunicazione umana, creata dalle peculiarità dell'uso dei mezzi linguistici in questa sfera e dalla loro organizzazione specifica.
Capitolo 1. Stile di discorso conversazionale
Lo stile conversazionale è uno stile di discorso funzionale che serve per la comunicazione informale, quando l'autore condivide i suoi pensieri o sentimenti con gli altri, scambia informazioni su questioni quotidiane in un ambiente informale. Utilizza spesso un vocabolario colloquiale e colloquiale.
La forma abituale di implementazione dello stile conversazionale è il dialogo; questo stile è più spesso usato nel discorso orale. Non è prevista una selezione preliminare del materiale linguistico. In questo stile di discorso, i fattori extralinguistici giocano un ruolo importante: le espressioni facciali, i gesti e l'ambiente.
Lo stile di conversazione è caratterizzato da emotività, immagini, concretezza e semplicità di parola. Ad esempio, in una panetteria non sembra strano dire: “Per favore, con la crusca, una”.
L'atmosfera rilassata della comunicazione porta a una maggiore libertà nella scelta di parole ed espressioni emotive: le parole colloquiali sono usate più ampiamente ( essere sciocco, loquace, loquace, ridacchiare, ridacchiare), volgare ( nitrito, debole, stupendo, spettinato), gergo ( genitori: antenati, ferro, mondo).
Nello stile di discorso conversazionale, soprattutto a ritmo veloce, è possibile una minore riduzione delle vocali, fino alla loro completa eliminazione e semplificazione dei gruppi di consonanti. Caratteristiche della formazione delle parole: i suffissi di valutazione soggettiva sono ampiamente utilizzati. Per migliorare l'espressività, viene utilizzato il raddoppio delle parole.
Il discorso orale è una forma di attività vocale, inclusa la comprensione del discorso parlato e l'implementazione delle espressioni vocali in forma sonora (parlare). Il discorso orale può realizzarsi attraverso il contatto diretto tra gli interlocutori oppure può essere mediato da un mezzo tecnico (telefono, ecc.) se la comunicazione avviene a notevole distanza. Il discorso orale, a differenza del discorso scritto, è caratterizzato da:
- ridondanza (presenza di ripetizioni, chiarimenti, spiegazioni);
- uso di mezzi di comunicazione non verbale (gesti, espressioni facciali),
- economia delle espressioni vocali, ellissi (l'oratore potrebbe non nominare, saltare ciò che è facile da indovinare).
Il discorso orale è sempre determinato dalla situazione linguistica. Ci sono:
- discorso orale non preparato (conversazione, intervista, discorso in una discussione) e discorso orale preparato (lezione, relazione, discorso, relazione);
- discorso dialogico (scambio diretto di dichiarazioni tra due o più persone) e discorso monologo (un tipo di discorso rivolto a uno o un gruppo di ascoltatori, a volte a se stessi).
· Stile colloquiale letterario
Il linguaggio letterario può essere diviso in due varietà funzionali: libresco e parlato.
Definendo questa divisione della lingua letteraria "la più generale e la più indiscutibile", D.N. Shmelev ha scritto a questo proposito: “In tutte le fasi dello sviluppo di una lingua letteraria, anche quando si supera l'alienazione della lingua scritta in un modo o nell'altro, quando l'alone della semplice alfabetizzazione e competenza in una lingua speciale del libro svanisce, i parlanti in generale non perdere mai la sensazione della differenza tra “come si può dire” e “come scrivere”.
Il livello successivo di divisione della lingua letteraria è la divisione di ciascuna delle sue varietà - libri e lingue parlate - in stili funzionali. La varietà parlata di una lingua letteraria è un sistema indipendente e autosufficiente all'interno del sistema generale di una lingua letteraria, con un proprio insieme di unità e regole per combinarle tra loro, utilizzato dai madrelingua di una lingua letteraria in condizioni di comunicazione diretta e impreparata nelle relazioni informali tra parlanti.
Una lingua letteraria parlata non è codificata: possiede certamente alcune norme (grazie alle quali, ad esempio, è facile distinguere il discorso orale di un madrelingua di una lingua letteraria dal discorso orale di un madrelingua di un dialetto o di una lingua volgare) ), ma queste norme si sono sviluppate storicamente e non sono regolate consapevolmente da nessuno o sancite sotto forma di regole e raccomandazioni.
Pertanto, la codificazione - non codificazione è un'altra caratteristica, molto significativa, che distingue le varietà librarie e colloquiali di una lingua letteraria. Lo stile conversazionale è un tipo speciale di linguaggio utilizzato da una persona nella comunicazione quotidiana e quotidiana.
La differenza principale tra lo stile di conversazione e gli stili dei libri in lingua russa è il diverso modo di presentare le informazioni. Quindi, negli stili dei libri, questo modo è soggetto alle regole della lingua registrate nei dizionari. Lo stile di conversazione è soggetto alle proprie norme e ciò che non è giustificato nel discorso del libro è abbastanza appropriato nella comunicazione naturale.
· Stile colloquiale
Lo stile colloquiale funziona nella sfera della comunicazione quotidiana. Questo stile è implementato sotto forma di discorso casuale (monologo o dialogo) su argomenti quotidiani, nonché sotto forma di corrispondenza privata e informale. Per facilità di comunicazione si intende l'assenza di un atteggiamento nei confronti di un messaggio di carattere ufficiale (lezione, discorso, risposta a un esame, ecc.), Relazioni informali tra i relatori e assenza di fatti che violano l'informalità della comunicazione, ad esempio , estranei. Il discorso colloquiale funziona solo nella sfera privata della comunicazione, nella vita di tutti i giorni, tra amici, familiari, ecc. Nel campo della comunicazione di massa, il discorso colloquiale non è applicabile. Tuttavia, ciò non significa che lo stile colloquiale sia limitato agli argomenti di tutti i giorni. Il discorso colloquiale può toccare anche altri argomenti: una conversazione con la famiglia o una conversazione tra persone in relazioni informali: su arte, scienza, politica, sport, ecc.; conversazione tra amici sul lavoro relativa alla professione dell'oratore, conversazioni in istituzioni pubbliche, come cliniche, scuole, ecc.
Lo stile colloquiale e quotidiano è in contrasto con gli stili dei libri, poiché funzionano nelle stesse aree dell'attività sociale. Il discorso colloquiale comprende non solo mezzi linguistici specifici, ma anche neutri, che sono la base della lingua letteraria. Pertanto, questo stile è associato ad altri stili che utilizzano anche mezzi linguistici neutri.
Lo stile colloquiale e quotidiano è in contrasto con gli stili dei libri, poiché funzionano in determinate aree dell'attività sociale. Tuttavia, il discorso colloquiale comprende non solo mezzi linguistici specifici, ma anche neutri, che sono la base della lingua letteraria. 3
All'interno di una lingua letteraria, il discorso colloquiale è in contrasto con il linguaggio codificato. (La lingua si dice codificata perché in relazione ad essa si lavora per preservarne le norme, la purezza). Ma la lingua letteraria codificata e il discorso colloquiale sono due sottosistemi all'interno della lingua letteraria. Di norma, ogni madrelingua di una lingua letteraria parla entrambe queste varietà di discorso. Con
Le caratteristiche principali dello stile di conversazione quotidiano sono la già citata natura rilassata e informale della comunicazione, nonché la colorazione emotivamente espressiva del discorso. Pertanto, nel discorso colloquiale viene utilizzata tutta la ricchezza dell'intonazione, delle espressioni facciali e dei gesti. Una delle sue caratteristiche più importanti è la dipendenza dalla situazione extralinguistica, cioè dalla situazione extralinguistica. il contesto immediato del discorso in cui avviene la comunicazione. Ad esempio: (Donna prima di uscire di casa) Cosa dovrei indossare? (riguardo al cappotto) È questo o cosa? O quello? (riguardo alla giacca) Non mi congelerò? Ascoltando queste dichiarazioni e non conoscendo la situazione specifica, è impossibile indovinare di cosa stiano parlando. Così, nel discorso colloquiale, la situazione extralinguistica diventa parte integrante dell'atto comunicativo.
3 - Lingua russa e cultura della parola: Libro di testo (a cura del Prof. V. I. Maksimov. - M.: Gardariki, 2002. - 89 - 93 p.
Lo stile di discorso conversazionale quotidiano ha le sue caratteristiche lessicali e grammaticali. Una caratteristica del discorso colloquiale è la sua eterogeneità lessicale. Qui puoi trovare i più diversi gruppi tematici e stilistici di vocabolario: vocabolario generale dei libri, termini, prestiti stranieri, parole di alta colorazione stilistica, nonché fatti di volgare, dialetti, gerghi. Ciò è spiegato, in primo luogo, dalla diversità tematica del discorso colloquiale, che non si limita agli argomenti quotidiani e alle osservazioni quotidiane; in secondo luogo, l'implementazione del discorso colloquiale in due toni: serio e giocoso, e in quest'ultimo caso è possibile utilizzare una varietà di elementi.
Anche le costruzioni sintattiche hanno le loro caratteristiche. Per il discorso colloquiale, sono tipiche le costruzioni con particelle, con interiezioni, costruzioni di natura fraseologica: "Te lo dicono e te lo dicono, ma tutto è inutile!", "Dove stai andando? C'è sporcizia!" e così via.
· Volgare
Le parole colloquiali sono caratteristiche del discorso colloquiale. Servono come caratteristiche di un fenomeno nell'ambito delle relazioni quotidiane; non vanno oltre le norme dell'uso letterario, ma conferiscono facilità alla parola. Il discorso vernacolare è caratteristico del discorso colloquiale urbano non letterario, che contiene molte parole dialettali recenti, parole di origine colloquiale, nuove formazioni che sorgono per caratterizzare vari fenomeni quotidiani e varianti di formazione delle parole del vocabolario neutro. Una parola colloquiale viene utilizzata nel linguaggio letterario come mezzo stilistico per conferire al discorso un tono umoristico, sprezzante, ironico, scortese, ecc. Spesso queste parole sono sinonimi espressivi ed espressivi di parole nel vocabolario neutro. Il discorso vernacolare è una delle forme della lingua nazionale, insieme al discorso dialettale, gergale e alla lingua letteraria: insieme ai dialetti e ai gerghi popolari, costituisce la sfera orale e non codificata della comunicazione vocale nazionale - la lingua colloquiale; ha un carattere sovradialettale. Il linguaggio vernacolare, a differenza dei dialetti e dei gerghi, è un linguaggio generalmente comprensibile ai madrelingua della lingua nazionale.
Questa è una varietà della lingua nazionale russa, il cui parlante è la popolazione urbana non istruita e scarsamente istruita. Questo è il sottosistema più singolare della lingua russa, che non ha analoghi diretti in altre lingue nazionali. La lingua vernacolare differisce dai dialetti territoriali in quanto non è localizzata in un particolare contesto geografico, e dalla lingua letteraria (compresa la parlata colloquiale, che ne è la varietà) in quanto non è codificata, ma normativa, e la natura mista della lingua significa usato. In termini di ruolo funzionale e in relazione alla lingua letteraria, il volgare è una sfera linguistica unica all'interno di ogni lingua nazionale. Funzionalmente opposto alla lingua letteraria, il volgare, come la lingua letteraria, è comunicativamente significativo per tutti i parlanti della lingua nazionale. Essendo una categoria universale per le lingue nazionali, il volgare in ciascuna di esse ha caratteristiche specifiche e un proprio rapporto speciale con la lingua letteraria. Le unità di tutti i livelli linguistici sono rappresentate nel linguaggio comune; Sullo sfondo della lingua letteraria, la lingua vernacolare si rivela nelle aree dell'accento, della pronuncia, della morfologia, del vocabolario, della fraseologia, dell'uso delle parole ("stendersi" invece di "mettere giù", "indietro" nel significato di "di nuovo" ). L'originalità della lingua vernacolare si manifesta particolarmente chiaramente nell'uso di elementi della lingua letteraria (cfr. “si mostrano in TV”), nella struttura grammaticale e fonetica delle parole del vocabolario generale (“pantofole”, “dopo”, “ qui” invece di “pantofola”, “dopo”, “qui”). Il linguaggio comune è caratterizzato da parole valutative espressamente “ridotte” con una gamma di sfumature dalla familiarità alla maleducazione, per le quali esistono sinonimi neutri nella lingua letteraria (cfr. le coppie “rabbrividire” - “colpire”, “dormire” - “dormire”) ”, “trascina” - “scappa” "). Nella lingua russa, il volgare è un sistema linguistico storicamente stabilito, la cui formazione e sviluppo sono strettamente legati alla formazione della lingua nazionale russa (la parola "vernacolare" stessa è stata formata dalla frase "discorso semplice" usata nel XVI secolo). -XVII secolo). Quando il discorso colloquiale si formò e iniziò a funzionare nel quadro della lingua letteraria russa, i confini del discorso volgare si stabilizzarono. Sono emerse forme di correlazione e interazione tra il volgare e la lingua letteraria, a seguito delle quali è emerso un volgare letterario, che funge da confine tra la lingua letteraria e la lingua colloquiale - uno speciale strato stilistico di parole, unità fraseologiche, forme , figure retoriche, accomunate dalla brillante colorazione espressiva di “bassezza”, maleducazione, familiarità. La norma del loro utilizzo è che sono ammessi nella lingua letteraria con compiti stilistici limitati: come mezzo di caratterizzazione socialmente verbale dei personaggi, per una caratterizzazione espressiva “ridotta” di persone, oggetti, eventi. Il volgare letterario comprende solo quegli elementi del discorso che si sono radicati nella lingua letteraria a seguito del loro uso a lungo termine nei testi letterari, dopo una lunga selezione, elaborazione semantica e stilistica. Insieme alle parole colloquiali, nel volgare letterario sono inclusi dialettismi e gerghi che hanno perso il loro attaccamento locale e socialmente limitato. Anche le parole che denotano realtà per le quali non esistono nomine nella lingua letteraria, ad esempio “verde”, dovrebbero essere classificate come volgare letterario. Le etichette nei dizionari esplicativi sono “semplici”. e "regione" significa che la parola o unità fraseologica corrispondente si riferisce al volgare letterario. La composizione del volgare letterario è fluida e costantemente aggiornata; Molte parole ed espressioni hanno acquisito lo status di "colloquiale" e persino "libresco", ad esempio "andrà tutto bene", "studio", "inchino", "tempo libero", "piagnucolone", "pettine". Alcuni fenomeni compaiono in slogan e citazioni letterarie (“Vogliono mettere in mostra la loro educazione”, “Ogni volta in questo posto”). Nel discorso letterario generale, il termine "vernacolare" è spesso usato come designazione di una parola o frase separata di una colorazione "ridotta" ruvida o approssimativamente familiare.
· Fattori extralinguistici che determinano le specificità dello stile di discorso conversazionale
Espressioni facciali(Greco: μιμιχοζ - imitatore) - movimenti espressivi dei muscoli facciali, che sono una delle forme di manifestazione di alcuni sentimenti umani - gioia, tristezza, delusione, soddisfazione, ecc. Inoltre, gli animali durante la biocomunicazione, ad esempio i primati, usano spesso espressioni facciali per esprimere determinati sentimenti. Le espressioni facciali sono uno dei modi ausiliari di comunicazione tra le persone. Discorso di accompagnamento, contribuisce alla sua espressività. Per molto tempo l'umanità ha familiarità con la fisionomia. L'arte di leggere i volti si sviluppò soprattutto in Giappone e in Cina durante il Medioevo. In questi paesi furono scritti enormi trattati sulla fisionomia, furono create scuole dove veniva studiata con pazienza e attenzione. Nelle scuole dove si studiava fisionomia, il volto umano veniva studiato letteralmente millimetro per millimetro, dando significato ad ogni protuberanza, ad ogni rossore o pallore della pelle. Sulla base del materiale accumulato, i fisionomisti hanno cercato di determinare il carattere e interpretare il suo destino. La prima spiegazione corretta della connessione tra espressione facciale stabile e movimenti ripetuti dei muscoli facciali fu fatta da Leonardo da Vinci. Per le sue ricerche nel campo della fisiognomica scelse gli anziani, poiché le loro rughe e i cambiamenti dei lineamenti del viso parlavano delle sofferenze e dei sentimenti che avevano vissuto. Ci sono:

Riso. 1 Le espressioni facciali dei bambini sono involontarie
- espressioni facciali volontarie (coscienti) come elemento dell'arte della recitazione, che consiste nel trasmettere lo stato d'animo del personaggio attraverso movimenti espressivi dei muscoli facciali. Aiuta l'attore nella creazione di un'immagine scenica, nel determinare le caratteristiche psicologiche, lo stato fisico e mentale del personaggio.
Le espressioni facciali, proprio come il linguaggio, possono essere utilizzate da una persona per trasmettere informazioni false (cioè per mostrare emozioni che non sono quelle che una persona prova effettivamente in un momento o nell'altro). Il viso è la caratteristica più importante dell’aspetto fisico di una persona. “Grazie al controllo corticale, una persona può controllare ogni singolo muscolo del suo viso. Il controllo corticale delle componenti esterne delle emozioni si è sviluppato particolarmente intensamente in relazione alle espressioni facciali. Ciò è determinato, come osserva P.K. Anokhin, dalle sue caratteristiche adattive e dal suo ruolo nella comunicazione umana. L'imitazione sociale, come una delle condizioni per lo sviluppo delle espressioni facciali, è possibile proprio grazie alla sua regolamentazione volontaria. In generale, la socializzazione delle espressioni facciali viene effettuata come l'uso di manifestazioni organiche per influenzare un partner e come la trasformazione delle reazioni emotive adeguate alla situazione. La società può incoraggiare l’espressione di alcune emozioni e condannarne altre, e può creare un “linguaggio” di espressioni facciali che arricchisce i movimenti espressivi spontanei. A questo proposito parliamo di segni facciali universali o specifici, di espressioni facciali convenzionali o spontanee. Di solito vengono analizzate le espressioni facciali:
- lungo la linea delle sue componenti volontarie e involontarie;
- in base ai suoi parametri fisiologici (tono, forza, combinazione di contrazioni muscolari, simmetria - asimmetria, dinamica, ampiezza);
- in termini sociali e socio-psicologici (tipi di espressione interculturali, espressioni appartenenti a una particolare cultura, espressioni accettate in un gruppo sociale, stile di espressione individuale);
- in termini fenomenologici (“topografia del campo facciale”): analisi frammentaria, differenziale e olistica delle espressioni facciali;
- in termini di quei fenomeni mentali a cui corrispondono questi segni facciali.
Puoi anche analizzare le espressioni facciali in base a quegli standard di impressioni che si formano nel processo di percezione di una persona delle immagini facciali che circondano le persone. Le immagini standard reali includono caratteristiche che non solo caratterizzano il modello, ma sono sufficienti per la sua identificazione”.
Gesto(dal lat. gesto- movimento del corpo) - qualche azione o movimento del corpo umano o parte di esso, che ha un certo significato o significato, cioè è un segno o simbolo. La lingua dei segni è ricca di modi in cui le persone esprimono un'ampia varietà di emozioni e significati, come insulto, ostilità, cordialità o approvazione verso gli altri. La maggior parte delle persone quando parla usa i gesti e il linguaggio del corpo oltre alle parole. Molti gesti vengono utilizzati dalle persone inconsciamente.

Si ritiene che alcuni gruppi etnici utilizzino i gesti più di altri e la quantità di gesti culturalmente accettabile varia da un luogo all'altro. Ad esempio, in Germania o nei paesi scandinavi lo stesso gesto può essere espresso con un leggero movimento della mano, mentre in Italia o in Spagna lo stesso gesto può essere espresso con un movimento ampio dell'intero braccio. I gesti ampiamente utilizzati includono azioni come indicare qualcosa o qualcuno (questo è uno dei pochi gesti il cui significato varia poco da paese a paese) e usare le mani e il corpo in sincronia con i ritmi della parola per enfatizzare determinate parole o frasi. Molti gesti apparentemente simili hanno significati diversi in paesi diversi. Lo stesso gesto può essere innocuo in un Paese e volgare in un altro. Inoltre, anche gesti uguali o simili potrebbero differire leggermente nei diversi paesi. Ad esempio, quando un russo conta qualcosa sulle dita, di solito piega le dita all'interno del palmo, mentre un tipico americano, al contrario, raddrizza le dita quando conta. In Occidente, le dita allargate a forma di lettera latina V significano vittoria. Ma prima della seconda guerra mondiale, le dita aperte a forma di V latina, sollevate sopra l'interlocutore, significavano un appello al silenzio. In Italia è un riferimento offensivo all'adulterio. Ma per noi è una “capra”, cioè un’espressione di minaccia in un ambiente marginale. I gesti per natura e funzione possono essere suddivisi in:
1) indici;
2) visivo;
3) simbolico;
4) emotivo;
5) ritmico;
6) meccanico. I gesti dimostrativi chiariscono i pronomi dimostrativi che, quello, quello. I gesti fini vengono utilizzati quando non ci sono abbastanza parole, quando si vuole dimostrare "visivamente" la forma di un oggetto, le sue dimensioni, ecc.
I gesti simbolici sono convenzionali, sono associati all'astrazione (ad esempio, gli artisti si inchinano al pubblico dopo uno spettacolo). I gesti emotivi servono come espressione di emozioni e sentimenti. I gesti ritmici riflettono il ritmo della parola. Questi gesti enfatizzano il rallentamento e l'accelerazione del discorso ed evidenziano anche lo stress logico.
Capitolo 2 Caratteristiche intra-stili del discorso colloquiale
La parola, come mezzo per organizzare la comunicazione tra un piccolo numero di persone vicine e ben conosciute tra loro, ha una serie di caratteristiche distintive. Questo è un discorso colloquiale, caratterizzato da:
1) personalizzazione dell'indirizzamento, ad es. indirizzo individuale degli interlocutori tra loro, tenendo conto degli interessi reciproci e delle possibilità di comprendere l'argomento del messaggio; maggiore attenzione all'organizzazione del feedback con i partner, poiché il destinatario del discorso colloquiale è sempre presente, ha lo stesso grado di realtà di chi parla, influenza attivamente la natura della comunicazione verbale, la posizione del partner viene continuamente riflessa, ripensata, reagita , anticipare e valutare;
2) spontaneità e facilità: le condizioni della comunicazione diretta non consentono di pianificare in anticipo la conversazione; gli interlocutori interferiscono nel discorso dell'altro, chiarendo o cambiando l'argomento della conversazione; chi parla può interrompersi, ricordando qualcosa, tornando a quanto già detto;
3) la natura situazionale del comportamento linguistico - il contatto diretto tra i parlanti, il fatto che gli oggetti in questione sono più spesso visibili o conosciuti dai loro interlocutori, consente loro di utilizzare espressioni facciali e gesti come un modo per compensare l'inesattezza delle espressioni che sono inevitabili nel discorso informale;
4) emotività: la natura situazionale, la spontaneità e la facilità di parola nella comunicazione diretta aumentano inevitabilmente la sua colorazione emotiva, portando in primo piano la percezione emotiva e individuale da parte dei parlanti sia dell'argomento della conversazione che dell'interlocutore, che si ottiene con l'aiuto delle parole , l'organizzazione strutturale delle frasi, le intonazioni; il desiderio di essere compresi incoraggia gli interlocutori a esprimere privatamente valutazioni personali, preferenze emotive e opinioni.
5) L'insufficienza suscita INTERESSE in una persona. Nel momento in cui una persona è interessata, pensa attivamente a questo eufemismo, cerca di sceglierne lui stesso la continuazione, disegnando per sé un numero enorme di opzioni. Nella sua testa sorgono tante domande e molte possibili risposte. In altre parole, una persona che incuriosisce fa riflettere e interrogare l'altra persona.
6) Incompletezza. Il vocabolario della lingua russa è un sistema unico e complesso. In questo caso, un sistema lessicale è un insieme organizzato internamente di elementi linguistici che sono naturalmente interconnessi da relazioni relativamente stabili e interagiscono costantemente. Questa definizione combina due aspetti interdipendenti della sistematicità del vocabolario: il sistema lessicale come insieme di mezzi nominativi, e il sistema lessicale come forma di organizzazione e interazione di questi elementi. Pertanto, deve essere considerato il concetto di incompletezza delle affermazioni dal punto di vista sia del vocabolario che della semantica, la sintassi della struttura del linguaggio. L'incompletezza lessicale delle espressioni si manifesta principalmente nel discorso colloquiale (in frasi incomplete ed ellittiche). E, secondo la definizione di Fomina M.I. “la struttura sintattica ridotta, giustificata dal sottofondo semantico sorto grazie al sistema lessicale integrale del dialogo.” Nel dialogo, di regola, le parole già nominate non vengono ripetute; le osservazioni precedenti e successive sono strettamente correlate, quindi, molto spesso nel discorso colloquiale, è giustificata l'incompletezza lessicale delle affermazioni. Ma il sottosviluppo dell'apparato vocale di una persona non può essere preso per l'incompletezza lessicale delle affermazioni.. In questo caso, A.V. Prudnikova introduce un nuovo concetto: inferiorità lessicale di un'affermazione, che implica una distorsione della struttura semantica, lessicale e sintattica di una frase.Le caratteristiche elencate definiscono le funzioni più importanti del discorso nella comunicazione interpersonale. Questi includono emotivo e conativo. Funzione emotivaè connesso con il mondo soggettivo di chi si rivolge (parlante), con l'espressione delle sue esperienze, il suo atteggiamento verso ciò che viene detto, riflette l'autostima di chi parla, il suo bisogno di essere ascoltato e compreso. Funzione conativaè associato ad un orientamento verso il destinatario (ascoltatore), con il desiderio di influenzarlo, di formare una certa natura di relazioni, riflette il bisogno di una persona di raggiungere obiettivi e influenzare altre persone; Questa funzione si manifesta nell'organizzazione strutturale della conversazione e nell'orientamento target del discorso.
A titolo illustrativo, presentiamo un breve estratto dal racconto di V. Shukshin "Stivali", vale a dire una scena di discussione in un'azienda maschile sull'acquisto di stivali da donna da parte di Sergei.
«.. - Per chi è questo?
- A mia moglie.
Poi tutti tacquero.
- A cui ? - chiese Rasp
- Klavke.
-BENE?
Lo stivale passava di mano in mano; tutti hanno anche spiegazzato lo stivale, hanno cliccato sulla suola...
- Quanti sono?
- Sessantacinque.
Tutti guardarono Sergei sbalorditi, Sergei era leggermente confuso.
- Sei pazzo?
Sergei ha preso lo stivale da Rasp.
- Oh! - esclamò Raspa. - Orecchino... ha dato! Perché ha bisogno di questi?
- Indossare.
Sergei voleva essere calmo e fiducioso, ma tremava dentro...
- Ha ordinato di comprare questi stivali?
- Cosa c'entra questo con gli ordini? L'ho comprato e basta.
- Dove li metterà? - Sergei è stato torturato allegramente. - Il fango è pesante e ha stivali da sessantacinque rubli.
- Questi sono quelli invernali!
- Dove vanno in inverno? ?
- Poi è sulla tappa cittadina. Klavkina non scalerà mai... Che taglia è? ? E' solo sul naso.
- Che tipo di vestiti indossa? ?
- Vaffanculo!. - Mi sono arrabbiato completamente. Sergey. -Di cosa sei preoccupato?
- Riso
- È un peccato, Seryozha! Non li hai trovati, sessantacinque rubli.
- Guadagnavo soldi, li spendevo dove volevo. Perché parlare invano?
- Probabilmente ti ha detto di comprare quelli di gomma?
- Gomma... Sergei era arrabbiato con tutte le sue forze...
- Come questi... sedete, puttane, a contare i soldi degli altri. - Sergei si alzò. - Non c'è più niente da fare?
- Perché stai entrando nella bottiglia? Hai fatto qualcosa di stupido, te lo hanno detto. E non essere così nervoso...
- Non sono nervoso. Perché sei preoccupato per me?! Wow, è stato trovato un sopravvissuto! Almeno potrei prenderlo in prestito da lui o qualcosa del genere...
- Sono preoccupato perché non riesco a guardare con calma gli sciocchi. Mi dispiace per loro.
- È un peccato, è nel culo dell'ape. Mi dispiace per lui!
- Abbiamo chiacchierato ancora un po’ e siamo tornati a casa...”
L'estratto di cui sopra non solo riproduce vividamente le caratteristiche e le tecniche inerenti al discorso colloquiale (tra cui: un costante cambiamento delle posizioni degli oratori-ascoltatori; interesse personale e attività degli oratori; l'uso di frasi incomplete, frasi brevi, un gran numero di pronomi , vocabolario quotidiano, assenza di participi e gerundi e così via), ma anche le funzioni del discorso nella comunicazione interpersonale si manifestano superbamente: nel processo del suo svolgersi, la conversazione diventa sempre più emotiva, il che costringe gli interlocutori a chiarire il proprio atteggiamento all'argomento della conversazione, per verificare la stabilità della propria posizione e delle posizioni occupate dagli altri, in tal modo la parola risulta essere un fattore nell'autodeterminazione personale dei partecipanti alla comunicazione conversazionale.
Conclusione
Quindi, abbiamo appreso che lo stile colloquiale, come una delle varietà della lingua letteraria, serve la sfera della comunicazione rilassata tra le persone nella vita di tutti i giorni, in famiglia, nonché la sfera delle relazioni informali nella produzione, nelle istituzioni, ecc. Abbiamo anche scoperto che la forma principale di attuazione dello stile conversazionale è il discorso orale, sebbene possa manifestarsi anche in forma scritta (lettere amichevoli informali, appunti su argomenti quotidiani, annotazioni di diario, commenti di personaggi di opere teatrali, in alcuni generi di narrativa e letteratura giornalistica). In tali casi, vengono registrate le caratteristiche della forma del discorso orale.
Le principali caratteristiche extralinguistiche che determinano la formazione di uno stile conversazionale sono: facilità (possibile solo nelle relazioni informali tra parlanti e in assenza di un atteggiamento verso un messaggio di carattere ufficiale), eufemismo, emotività, spontaneità e impreparazione della comunicazione . Sia l'emittente del discorso che il suo destinatario partecipano direttamente alla conversazione, spesso scambiandosi i ruoli; i rapporti tra loro si stabiliscono nell'atto stesso del discorso. Tale discorso non può essere pre-pensato; la partecipazione diretta del destinatario e del destinatario ne determina la natura prevalentemente dialogica, sebbene sia possibile anche un monologo.
Una caratteristica del discorso colloquiale è l'emotività, l'espressività e la reazione valutativa. Un ruolo importante nella lingua parlata è giocato dall'ambiente della comunicazione verbale, dalla situazione, nonché dai mezzi di comunicazione non verbale (gesti, espressioni facciali, natura della relazione tra gli interlocutori, ecc.).
Le caratteristiche extralinguistiche dello stile conversazionale sono associate alle sue caratteristiche linguistiche più generali, come la standardità, l'uso stereotipato dei mezzi linguistici, la loro struttura incompleta a livello sintattico, fonetico e morfologico, l'intermittenza e l'incoerenza del discorso da un punto di vista logico, connessioni sintattiche indebolite tra parti dell'enunciato o loro mancanza di formalità , interruzioni di frasi con vari tipi di inserimenti, ripetizioni di parole e frasi, uso diffuso di mezzi linguistici con una pronunciata colorazione emotivo-espressiva, attività di unità linguistiche con un significato specifico e passività di unità con significato astratto-generalizzato.
Letteratura
1) Ozhegov S.I., Shvedova N.Yu. Dizionario esplicativo della lingua russa / Fondazione culturale russa. - M.: Az Ltd., 1992. - 960 p.
2) Radugin A.A. Lingua russa e cultura della parola. M.: INFRA - M., 2004. - 250 p.
3) Lingua e cultura vocale russa: libro di testo per università / Ed. IN E. Maksimova. - M.: Gardariki, 2002. - 411 p.
4) Lingua letteraria russa moderna. Libro di testo / Ed. Lekant P.A. M.: UNITÀ - DANA, 2004. - 250 p.
5) Lingua e cultura vocale russa: libro di testo per università / Ed. IN E. Maksimova. – M.: Gardariki, 2002. P. 246
6) Cultura del discorso orale. Intonazione, pausa, tempo, ritmo: insegnamento pos-mi/sol. N. Ivanova - Ulyanova. - M.:FLINT: Science-1998.-150-193.
7) Kazartseva O. M. Cultura della comunicazione vocale: teoria e pratica dell'insegnamento: insegnamento post-e-2a ed. - M .: Flint: Nauka-1999-496p.
8) Retorica. Lettore per lavoro pratico. Muranov A. A. M.: Ross. insegnante Agenzia, - 1997 - 158 p.
9) Lingua e cultura vocale russa: Libro di testo/a cura del prof. V.I. Maksimova. - M.: Gardariki, 2002-490 pag.
10) L. A. Vvedenskaya, L. G. Pavlova, E. Yu. Kashaeva. Lingua e cultura vocale russa: libro di testo. manuale per le università. Messaggi N/A. Da "PHOENIX" anni 2001-160.
La definizione di stile è data nelle opere di: Vinogradov V.V. Risultati della discussione su questioni stilistiche // VYa. 1955. N. 1. P. 73; Golovin B.N. Fondamenti di cultura vocale. M., 1988. P. 261; Sirotinina O.B. La stilistica come scienza sul funzionamento del linguaggio // Concetti e categorie di base della stilistica linguistica. Perm, 1982. P. 12; Kozhina M.N. Stilistica della lingua russa. M., 1983. P. 49; e così via.